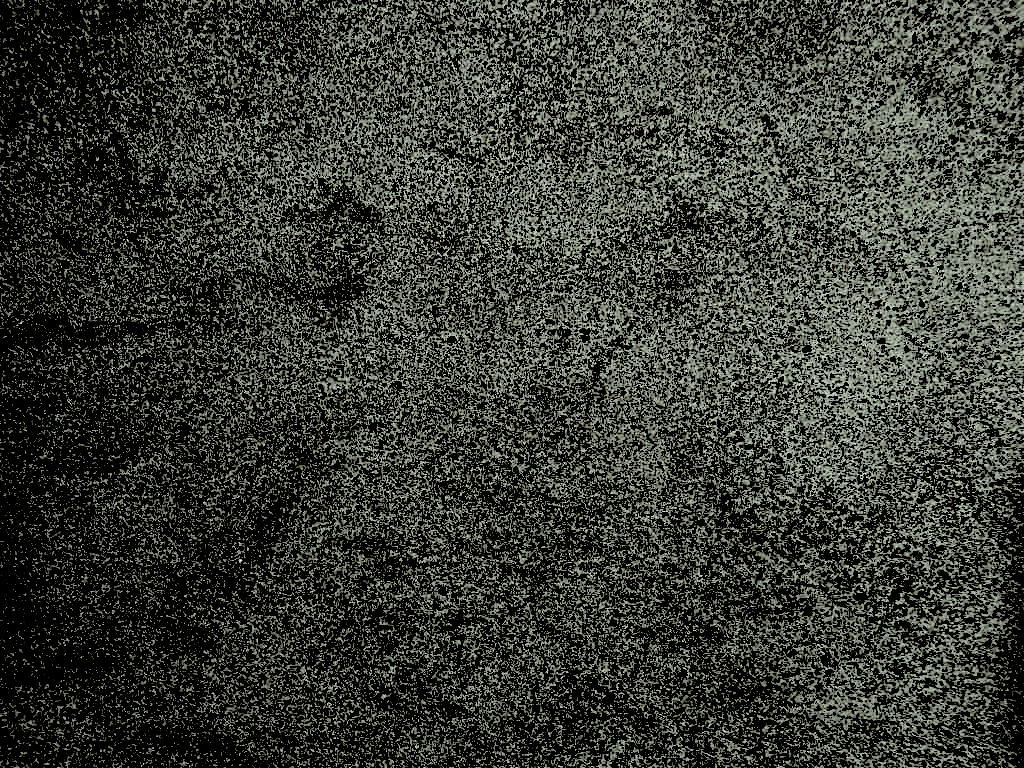Come nasce un personaggio romanzesco
L’essenza personaggi dei romanzi è per sua natura purgatoriale. Quando o come nasce il personaggio romanzesco? Nell’Amleto, proprio all’inizio nel primo atto, alla prima scena, nella didascalia, con molta semplicità, Shakespeare scrive: «Entra lo spettro». Questa notazione – il comparire del fantasma spettro – ha un impatto enorme sulla tragedia e sul personaggio, che noi riusciamo a valutare solo quando il principe danese e il suo defunto padre si incontrano. Amleto dovrebbe agire, essere il perfetto eroe delle tragedie di vendetta, e invece tergiversa, aspetta, tentenna, si tormenta; la visione dello spettro fa di lui un personaggio diverso, nuovo. Eppure Amleto è il fiore della nuova cultura, studia a Wittenberg, nelle facoltà umanistiche, è colto, è ironico, è sapiente, pare avere tutto per essere l’uomo nuovo, ma “entra uno spettro”, che proviene da un luogo che non è morte ma uno stato di dannazione temporanea, ed è condannato a girovagare: il padre di Amleto, ucciso nel fiorire dei suoi peccati, è costretto a questa esistenza. Questa apparizione manda in frantumi la psiche di Amleto e lo trasforma nel personaggio che noi leggiamo nella tragedia.
Secondo Brecht (Piccolo organon) la follia di Amleto è uno scontro di culture che si aggregano proprio nello spettro e nella sua natura: la visione dello spettro suggerisce ad Amleto che la ragione, la sua cultura, il suo umanesimo nulla possono davanti alla apparizione tremenda e unica, che modifica per sempre Amleto, e ogni personaggio moderno, nel racconto. Ogni personaggio romanzesco, nel suo svolgersi nel racconto, vive un momento in cui entra uno “spettro” e ne modifica l’esistenza. Il caso per me più chiaro è l’apparizione Rudy, il figlio morto di Leopold Bloom alla fine di quel sabba, una vera e propria notte di Valpurga, che è il cap. XV dell’Ulisse di Joyce, la figura muta del figlio in cui tutto il grande baccano del mondo si coagula e dà senso al personaggio del romanzo, anzi: ce lo rende finalmente e completamente intellegibile.
Uno spettro s’aggira per le pagine
Non è casuale che l’Ottocento, il secolo del romanzo, sia pieno di spettri. Leggendo Canto di Natale di Dickens siamo propensi ad accettare che la vita di Scrooge venga messa sottosopra dall’apparizione dei tre fantasmi dei Natali (passato, presente e futuro), la loro essenza essendo quella di mostrare al protagonista quanto cattivo egli sia, quanto triste, solo e disperato il cammino della sua vita: lo spettro in questo senso suggerisce l’esistenza di una interiorità con cui fare i conti: la coscienza appare in forma di specchio, che deforma, mostra e suggerisce ciò che è stato, è e sarà. Quest’entità fantasmatica che si aggira per Londra e mette in guardia un uomo per farlo ravvedere dai suoi comportamenti, mettendo in luce quando ha sfruttato, quanto è stato egoista, quanto è stato cattivo e avaro, mi ha sempre ricordato un altro libro pubblicato negli stessi anni, che si apre con uno degli incipit più belli di sempre: «Uno spettro si aggira per l’Europa». Le prime parole del Manifesto del partito comunista di Marx e Engels sono degne di un grande romanzo.
È chiaro che il Manifesto non è redatto con questo intento, ma anche la lettura dell’intera opera, la rappresentazione delle forze in campo, i loro scontrarsi, le sconfitte e le vittorie, che vengono raccontate, nascondono al proprio interno un desiderio di narrazione teleologica (ovvero di una logica che spieghi fenomeni apparentemente sconnessi), come se fosse un romanzo. Leggendo il Manifesto, si ha l’impressione che il proletariato sia Amleto, e che, come il principe triste, si muova sospinto e dalla vendetta e dalla crisi del suo essere lungo le terre ampie e vaste dell’Europa.
Quanto del romanzo c’è in questo muoversi? C’è il Chisciotte che esce per gli assolati campi della Mancia, c’è lo spettro di Shakespeare che vaga per le notturne lande della Danimarca, ci sono i bimbi tristi e malnutriti di Dickens, c’è lo statuto ontologico della merce come definizione dell’uomo, e infine a dominare tutto c’è il denaro come movente, ragione, causa e perdizione degli uomini che vivono “spettralmente”, come ci suggerisce Balzac: «Così come i corpi si proiettano realmente nell’atmosfera facendovi sussistere lo spettro afferrato dal dagherrotipo, che lo ferma al passaggio; così le idee, creazioni reali e attive, si imprimono in quella che dobbiamo chiamare atmosfera spirituale, vi producono degli effetti, vivono in essa “spettralmente” […] e allora certi esseri dotati di facoltà rare possono perfettamente scorgere queste forme o tracce di idee» (Il cugino Pons, trad. U. Déttore, Bur). Così come la fotografia ferma lo spettro di noi, non la nostra realtà, non il nostro vero essere, allo stesso modo, con la stessa intensità verrebbe da dire, i personaggi dei romanzi e delle creazioni d’arte vivono “spettralmente”, appartengono insomma qualcosa che non ha a che fare con la realtà, così come neppure i prodotti della fotografia, ma esistono nelle pagine. Balzac era convinto che la fotografia in un certo senso bloccasse una parte di questa esistenza “spettrale” o “fantasmatica” che è comune a tutti gli esseri viventi.
Riso e sorriso purgatoriale
«Poi sorridendo disse» (Purg III; 112) una delle immaginazioni più belle del Purgatorio dantesco è il sorriso delle anime: nella Commedia molti protagonisti ridono, anche nella cantica del Paradiso, ma in quel caso siamo davanti a una figura della beatitudine. Il riso nel Purgatorio è diverso, è un riso timido, pudico, colmo di vergogna, colui che ride nel Purgatorio sa cosa ha commesso e che in qualche modo, imprevedibile alle volte, si è salvato, è un riso allegro perché triste, e triste perché allegro.
Il nuovo riso “purgatoriale” è quello che diventerà fondamentale ad esempio in Rabelais, «meglio di risa che di pianti scrivere/ché ridere soprattutto è cosa umana» (Gargantua e Pantagruele, a cura di M. Bonfantini, Einaudi), o in Cervantes quando scrive: «Procurate pure che, nel leggere la vostra storia, chi è malinconico abbia ad esser mosso a riso, chi è allegro abbia ad accrescere la sua allegria» (Don Chisciotte, a cura di B. Troiano, G. Di Dio, Newton Compton). Tale è il riso di cui si ride nei romanzi, che non ha a che fare con il “far ridere”, ma è appunto un delicato moto dell’animo umano, una frontiera dell’uomo, non colpevole e non salvo.
Lo descrive bene Primo Levi proprio parlando di Gargantua e Pantagruele, quando scrive: «Amare gli uomini vuol dire amarli come sono, corpo e anima. In tutta questa enorme opera sarebbe difficile trovare una sola pagina triste, eppure il savio Rabelais conosce bene la miseria umana; la tace perché, da buon medico anche quando scrive, non l’accetta, la vuole guarire» (La ricerca delle radici, Einaudi).
Questo riso è un atto d’amore verso l’umano, verso l’uomo, questo riso è prodotto dal Purgatorio come possibile dilazione tra condanna o salvezza, entrambe senza appello, mentre il purgatorio rappresenta ancora una possibilità di essere qualcosa che non si è, così come si descrive Elena, nel Faust: «Vacillando esco dal vuoto che mi avvolge di vertigine»; ogni romanzo rappresenta questo supremo vacillare, la vertigine di tutto il possibile, del non ancora accaduto.
I personaggi dei romanzi ridono perché sanno la fragile condizione dell’uomo, che noi nella realtà concerta tendiamo a dimenticare, ma che per loro è consustanziale: essi esistono per il tempo del romanzo che li racconta. Ne Il passeggero (trad. M. Balmelli, Einaudi, qui la mia recensione) McCarthy scrive: «Prima di me non esisteva il tempo, dopo di me non ci sarà nulla». Credo che questo descrive perfettamente la possibilità del romanzesco, che con molta più profondità che non le “storie vere” riesce a mettere in luce l’esilità del nostro passaggio terreste.
Identificarsi/Immedesimarsi
Quando ero ragazzino mi capitava di servir messa e certe volte il sacerdote diceva che questa messa era celebrata per il suffragio delle anime del Purgatorio. Ciò che mi ha sempre colpito, allora in maniera oscura e oggi più chiaramente è che la salvezza non è una “cosa a due” tra Dio e l’uomo, ma ha a che fare con una comunità. L’invenzione del Purgatorio è dal punto di vista sociologico e antropologico la nascita di una idea nuova di comunità, al quale viene chiesto di immedesimarsi in un altro, nei dubbi, nei tormenti e nei dolori di un altro, viene chiesto a tale comunità di comprenderne i peccati e di intercedere per lei. In tale movimento ravviso qualcosa di molto simile all’azione mimetica del romanzo, che fa sì che il lettore sia, si avvicini, si immedesimi, senza mai identificarsi, con i personaggi delle sue storie. C’è in tale tensione qualcosa di molto simile alla libertà, una posizione mediana in cui come lettore non sono più “io”, nel senso il me che legge, ma sono in parte un noi – faccio ad esempio parte di una comunità di persone che stanno leggendo quel libro – e allo stesso tempo ascolto/leggo le parole di un “tu” (che può essere reale o fittizio) che mi narra le storie di un “egli” a cui in qualche modo sono condotto a immedesimarmi.
In questo spostamento dall’io, al noi, e infine all’egli si annida il romanzo. Il romanzo non chiede identificazione, cosa che invece le storie vere richiedono, anzi le storie vere vogliono che il lettore si “confonda” sia tutt’uno con l’autore della storia: c’è un atteggiamento mistico, di compenetrazione che il romanzo rifugge, perché esso non è mistico, non mira a confondersi, non ha che fare né con io né con noi, ma ha che fare con quella strana figura grammaticale che è l’egli, un mistero di non poco conto: «Non mi basta dunque scrivere ‘io sono infelice’ finché non scrivo altro. Finché mi limito a scrivere solamente ‘io sono infelice’ sono troppo vicino a me stesso, troppo vicino alla mia infelicità, perché questa mia infelicità diventi davvero mia, e non sono ancora davvero infelice. È soltanto nel momento in cui arrivo a questa strana sostituzione “egli è infelice” [il est malheureux] che questa felicità diventa mia» (cfr. Blanchot in C. Palucci, Persona. Soggettività nel linguaggio e semiotica dell’enunciazione, Bompiani). Ciò che descrive Blanchot a me pare un movimento romanzesco, la mia infelicità (o la mia felicità) per essere mia deve essere lontana da me, deve diventare altro un personaggio, un essere inventato, una cosa diversa da me (grammaticalmente l’egli è lontano e dall’io che enuncia e dal tu che ascolta l’enunciato).
Un gioco di ruolo
È possibile scorgere in atto, vedere rappresentato davanti a sé questo movimento puramente grammaticale che il filosofo francese descrive. Qualcosa di molto simile possiamo vederlo nelle pagine finali di Narrazioni dell’estinzione (trad. V. Latronico, Add). In questo saggio Elvia Wilk racconta un episodio interessante legato al suo romanzo Oval (trad. C. Reali, Zona 42). Lei sostiene che il primo impulso a scrivere il romanzo sia stata la volontà di elaborare e riflettere sulla sua separazione. Wilk sostiene che questa consapevolezza non è stata immediata, ma ne abbia preso coscienza durante la stesura del testo, assumendo così il racconto della separazione come fulcro dell’impianto testuale. Nello stesso tempo, all’interno di questo canovaccio classico, la storia di un uomo e di una donna che si lasciano, venivano inserite una serie di sotto trame, divagazioni e riflessioni saggistiche, a voler velare il nucleo originario.
Racconta l’autrice, e io spero di riassumere bene, di aver avuto l’impressione che la sua storia avrebbe potuto avere mille sviluppi diversi, ma che lei li forzasse affinché la storia andasse nella direzione della separazione. La domanda che l’autrice si pone potrebbe essere: Il romanzo deve avere un esito esisto simile all’esperienza reale da cui è scaturito? Ovvero, detto banalmente: i personaggi del mio romanzo si devono lasciare, perché io nella vita vera ho appena vissuto una separazione?
Sono, a parer mio, dubbi legittimi, anzi centrali, perché ci permettono una ulteriore ricognizione sul romanzo. Ad esempio, che cosa distingue una storia di una separazione da un romanzo che nasce da una separazione? Io risponderei: la possibilità che i personaggi non si separino, l’idea che potrebbero, invece, vivere insieme felici e contenti. A questo punto, per fugare ogni dubbio, Wilk – giunta a una versione sostanzialmente definitiva di questa storia – ha deciso di costruire un gioco di ruolo dal vivo (Larp), seguendo la trama del romanzo. È un’ipotesi interessante: un romanzo (opera di finzione totale) che nasce in parte da una esperienza reale (la separazione) diventa una simulazione più reale possibile (è questo lo statuto del Larp) dell’opera di finzione con personaggi che sono reali e che interagiscono e parlano e fanno cose concrete.
Wilk, in questa simulazione, ha scelto per sé il ruolo di comparsa non giocante, se vogliamo un ruolo molto vicino al narratore onnisciente, sa tutto, è dovunque, ma non interagisce, pur essendo – in qualche modo misterioso – in ogni luogo, in cui avviene un fatto del romanzo.
Durante il Larp avviene, secondo il racconto dell’autrice, una cosa inaspettata ma interessante: viene prodotta e sintetizzata una pillola che libera dalle inibizioni. Tale pillola – che nel Larp era un semplice mentina – viene offerta a Wilk in quanto comparsa, o meglio con un sotterfugio un personaggio del gioco offre da bere a Wilk, rivelandole dopo di aver messo la pillola; a questo punto Wilk si trova a dover stare al gioco dei suoi personaggi e al gioco della sua stessa narrazione e quindi diventa parte della storia, perché non può fare a meno di essere ciò che ha postulato nel corso della narrazione che lei stessa ha prodotto. Wilk ci fa sapere che nella simulazione i due protagonisti si lasciano, ma soprattutto che il Larp le ha fatto comprendere come il suo testo vivesse all’interno di una tensione duplice: da una parte era una storia d’amore, e dall’altra era il tentativo di scrivere un romanzo sistemico; la cosa più interessante, però, è avvenuta dopo la pubblicazione, quando, a detta della sua autrice, lei stessa viene coinvolta in situazioni reali, che lei aveva preventivamente immaginato e che la protagonista del romanzo aveva vissuto. In qualche modo il dato spettrale che Balzac pensava vivesse nelle storie ha reclamato la sua dose di realtà, come se scrivendo una storia romanzesca Wilk si fosse tolta alcuni “spettri” di sé, e che tali spettri fossero divenuti una sorta di possibilità, e che queste possibilità fossero diventate fatti reali.
Romanzo e profezia
L’esperimento raccontato in Narrazioni dell’estinzione ha, però, per me, un altro interesse: Wilk descrive la macchina del romanzo nel suo farsi, mettendo in luce e in discussione statuto ambiguo dell’autore, del suo rapporto il ciò che crede di narrare e ciò che narra in realtà, e infine mostra come il romanzo possieda oscuramente un dato di anticipazione e di profezia sulla realtà: al romanzo non interessa la storia vera, e, anzi mi verrebbe da aggiungere, neppure la storia di invenzione, perché il romanzo non è realista o fantastico, ma produce la realtà e il fantastico; il romanzo è sempre altro, è incontro e produzione di altro.
In conclusione, penso che non crediamo più alle storie perché non crediamo più al romanzo come momento della nostra conoscenza: siamo convinti che abbia più senso raccontare la nostra esperienza, che abbia più senso riprendere o riprodurre la realtà così come è piuttosto che entrare nel campo degli spettri, nel campo della possibilità. Eppure, subito dopo aver incontrato lo spettro, Amleto entra in scena con un libro, e a Polonio che gli chiede il tema del volume il principe risponde: «Parole parole parole». L’esperienza dello spettro, o l’esperienza del romanzo, dimostra che tutto il nostro sapere è vuoto, che la nostra scienza è vuota, che la nostra cultura è vuota a cospetto dell’enormità dell’esperienza romanzesca, finché non torneremo a spaventarci come Amleto, a incuriosirci come Chisciotte, a vagare per il mondo come Pantagruel scriveremo forse pagine bellissime e polite, ma non romanzi, o storie, perché abbiamo ormai, dimenticato, che ogni storia d’amore è una storia di fantasmi.
(leggi la prima parte qui)