
– 1. Durante la lettura Fenomenologia dell’impostore. Essere un altro nella letteratura moderna (Salerno Editrice) di Giancarlo Alfano [di cui ha scritto su La ricerca Riccardo Donati, N.d.R.] ho più volte pensato che lo studioso avrebbe potuto aggiungere al quadro una poesia di Primo Levi dal titolo Cuore di Legno, presente nella raccolta Ad ora incerta. Mentre leggevo le pagine di questo accurato saggio, mi tornava in mente questa poesia di Levi e ragionavo su come il suo commento avrebbe potuto concludere il percorso che Alfano aveva costruito durante le sue pagine. Questo perché sono convinto che l’impostura – come fenomeno letterario moderno, o meglio, della modernità – avesse in Auschwitz un momento culminante e di cambio di paradigma; e che il concetto di impostura post-Auschwitz fosse diverso da quello tratteggiato in questo saggio, e che trovasse infine una sua interessante e esemplificativa rappresentazione in Caro vecchio neon di David Foster Wallace, testo contenuto in Oblio (Einaudi, trad. Giovanna Granato).
0. In via preliminare, però, una cosa mi colpisce del saggio di Alfano, e la vorrei affrontare prima di commentare i due testi che prima ho menzionato, ovvero la una strana inferenza tra il linguaggio letterario e quello psicologico che si registra nella quarta di copertina. Alfano, nel corso della sua trattazione, e a ben vedere già dal titolo stesso, parla di una fenomenologia dell’impostore, ovvero il saggio indaga il lento disvelarsi e apparire di questa figura, che hegelianamente prende coscienza di sé e si forma lungo i secoli della storia letteraria occidentale. Un arco temporale che arriva fino ai giorni nostri, se non che nella quarta di copertina si legge un accostamento (?) tra questo fenomeno letterario e la “sindrome dell’impostore”. È giusto chiarire che Alfano nel suo saggio non utilizza mai il termine “sindrome” né concetti ad essa collegati, ed è pensabile che la quarta di copertina sia opera redazionale, ma nonostante questo – pur sottolineando la differenza tra testo e paratesto –, mi pare interessante fare una riflessione .
Ora, la letteratura ha spesso preso in prestito espressioni e concetti dalla psicologia e viceversa, e in questo non c’è nulla di sconvolgente. Risulta necessario, però, segnalare una differenza fondamentale tra l’impostore letterario e il senso di impostura psicologico. Nel secondo caso si vive (mi si perdonerà la sintesi) sperimentando con un senso di inadeguatezza, sentendo e pensando di non meritare ciò che si ottiene, provando un senso di difetto: il problema della sindrome è quindi legato a un soggetto che non vive con pienezza e in modo adeguato la propria vita, i propri successi. Ecco: questo mi pare non abbia nulla a che vedere con l’impostore letterario, che finge consapevolmente di essere qualcun’altro, non per un senso di inadeguatezza, ma per sopravvivenza, per onore, per affari o per semplice gioco o, infine, per un semplice mistero che mai ci verrà svelato. Fare riferimento alla sindrome dell’impostore come all’ultima apparizione fenomenologica della figura dell’impostore in letteratura è, a mio avviso, un errore di interpretazione.
1. Dal punto di vista narrativo l’impostura, la riflessione su di essa, il riconoscerne i modi con cui appare nel mondo della letteratura rappresenta uno dei confini netti tra finzione e realtà. L’impostura in letteratura è una particolare forma di “come se”, che diventa un facciamo finta che. Molte volte, nella lettura di un romanzo, ci accade di essere quel personaggio, quella creatura; sia essa Madame Bovary o Harry Potter o Odisseo, la lettura della loro storia diventa esperienza così intima che noi diventiamo loro, viviamo la loro vita, partecipiamo alle loro esistenze, leggendo i loro pensieri li facciamo nostri.
Viviamo una vita non nostra, facciamo una esperienza di intimità, di profondità di pensiero che spesso nella nostra vita reale ci sfugge; leggendo il capitolo conclusivo de L’Ulisse di Joyce sentiamo, viviamo e facciamo nostri quelli stati offuscati della mente, tipici di quando stiamo per addormentarci, stati che difficilmente riusciamo a registrare con coerenza nella nostra vita.
L’impostura letteraria produce, quindi, un confine ben delimitato tra ciò che è finto e ciò che è vero, ci permette di esigere e vivere una serie di esperienze che altrimenti non avremmo potuto vivere: è una forma di specchio, che per verba ci permette di sentire e vivere una vita non nostra.
2. La ragione e il fine dell’impostura, quella letteraria, non sono causate da un senso di inadeguatezza – ecco perché il ricorso nella quarta di copertina all’immagine della sindrome è fallace –, in quanto le motivazioni profonde dell’impostura rimangono, a detta di Alfano, un mistero: i grandi impostori della narrativa finiscono la propria vita in silenzio, non opponendo una spiegazione alla loro traiettoria esistenziale; la motivazione di ciò che hanno fatto, quella profonda, spesso non viene detta, o non è importante. È così per Iago, per Tartufo; risulta interessante a questo proposito la citazione di Carrère tratta da L’avversario che Alfano riporta: «[…] è difficile accettare che qualcuno non possa essere niente». L’impostore, nel paesaggio letterario, è questo niente, e questo essere un non-essere; l’impostura è la rappresentazione di un personaggio come di un Dio negativo, quasi che Dio fosse sottoposto a una seduta di raggi x e le lastre ci mostrassero il suo negativo: il non-è.
Genialmente è Shakespeare a costruire questo personaggio con Iago e la sua affermazione «I am not what I am», inversione terribile dell’affermazione di identità in Jhw che nella King version suona con “I am that I am”. L’affermazione di Iago, mi perdonino i traduttori, potrebbe suonare così Io-non-è è Io-è. Ovvero ciò che mi definisce come essere (Io-è) non è altro che la negazione dello stesso (Io-NON-è). La letteratura è esperienza di questa negatività, lo è sempre anche quando i personaggi che entrano in scena non sono degli impostori, perché leggendo un romanzo o una poesia facciamo l’esperienza nuova. Durante la lettura la nostra mente vive uno strano e complicato movimento interiore: da un lato proviamo empatia, simpatia eccetera, sentimenti che dovrebbero farci alzare dalla poltrona e raggiungere Bovary e Karenina o la figlia dello Svedese e impedir loro di fare ciò che stanno per compiere, ma nello stesso tempo siamo affascinati dal fatto che ciò che succede non può essere impedito, perché ciò che accade è un non-è: Ettore morirà sempre ucciso da Achille, Ophelia ci augurerà sempre “Buona notte” prima di togliersi la vita, Stavrogin guarderà sempre la bambina impiccarsi: questa passività, unita a questa forma di partecipazione, è dovuta al concetto di “I am not” che Shakespeare declina per Iago, ma che giustamente Alfano dice essere il tratto distintivo dell’impostore e, aggiungiamo noi, del fenomeno della letteratura finzionale. (Chiariamo, aprendo questa partentesi, che nel contesto di questa riflessione il termine passività non è usato in accezione negativa. È cosa nota che nel mondo attuale, iperconesso, sempre in movimento, l’idea di stasi, quiete e quiescenza sia vista, quantomeno, con sospetto; in queste righe, però, quando si parla di “passività” si fa riferimento alla teologia negativa di Meister Eckhart, nella quale è appunto il negativo, l’immobile, il buio, il freddo “il luogo” [anche sul termine luogo bisognerebbe dilungarsi, ma si prenda l’uso metaforico del termine e si vada avanti] in cui può avvenire l’incontro con Dio).
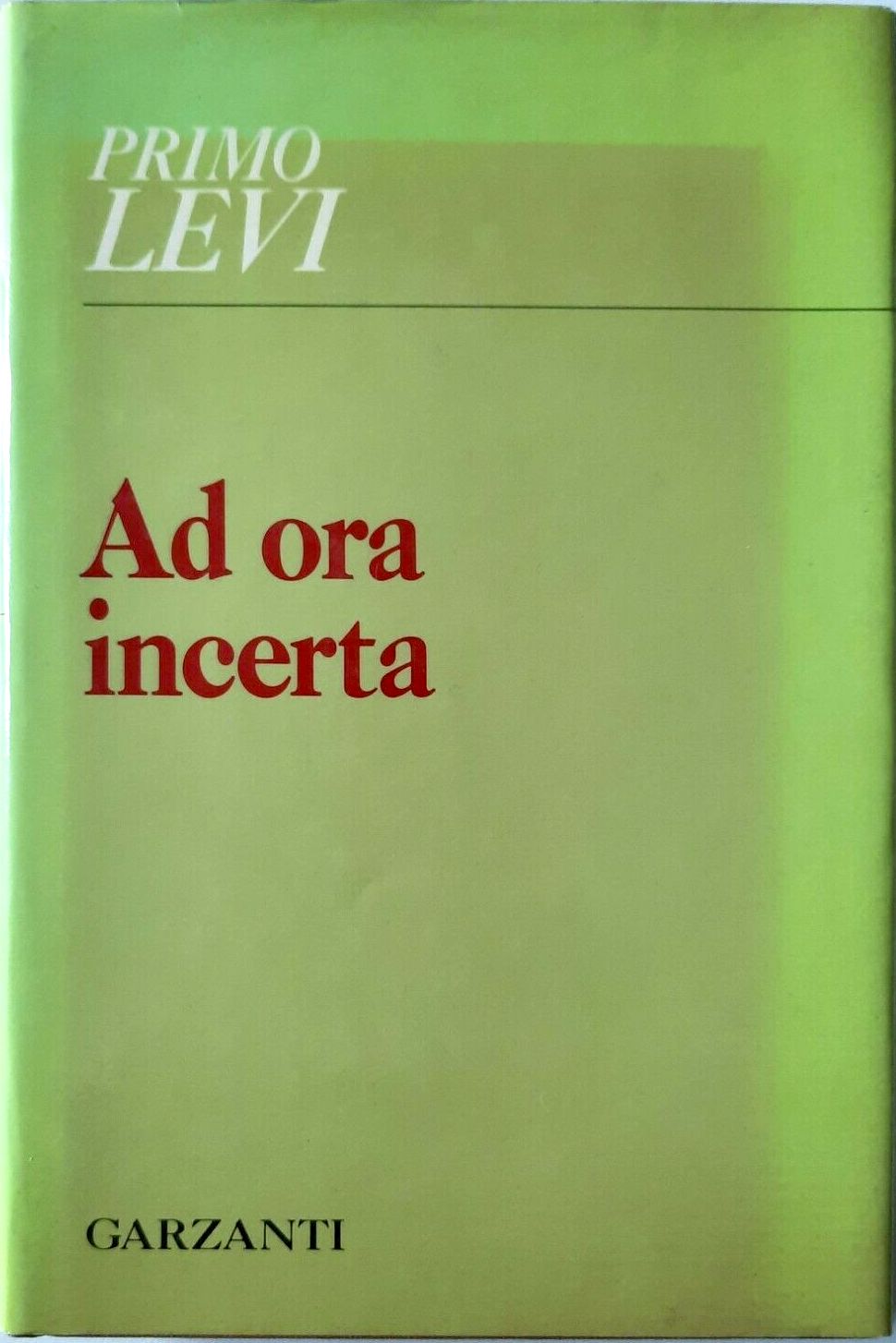 3. Se l’impostore è un guscio vuoto, credo che ora mi sia chiaro perché ho pensato alla poesia di Levi sull’ippocastano di Corso Re Umberto. È un’esperienza tipica di chi vive a Torino, quella di dover fare i conti, mentre passeggia nei controviali, con la possibilità di essere colpiti da un riccio che, caduto a terra, libera la castagna. Forse lo stesso Levi ha più volte sperimentato: l’essere colpito da un riccio, o l’aver assistito alla caduta di un riccio, che a contatto con il suolo si apre e mostra dentro la castagna, scura e lucida, e avrà anche Primo Levi, come molti, compiuto il gesto di prendersi la castagna e mettersela nella tasca del suo cappotto o dei pantaloni, tenendosela con sé perché – almeno così si crede – protegge dal raffreddore. Così un giorno Primo Levi, forse dopo aver raccolto una castagna dall’asfalto, scrive questa poesia che si intitola, appunto, Cuore di legno:
3. Se l’impostore è un guscio vuoto, credo che ora mi sia chiaro perché ho pensato alla poesia di Levi sull’ippocastano di Corso Re Umberto. È un’esperienza tipica di chi vive a Torino, quella di dover fare i conti, mentre passeggia nei controviali, con la possibilità di essere colpiti da un riccio che, caduto a terra, libera la castagna. Forse lo stesso Levi ha più volte sperimentato: l’essere colpito da un riccio, o l’aver assistito alla caduta di un riccio, che a contatto con il suolo si apre e mostra dentro la castagna, scura e lucida, e avrà anche Primo Levi, come molti, compiuto il gesto di prendersi la castagna e mettersela nella tasca del suo cappotto o dei pantaloni, tenendosela con sé perché – almeno così si crede – protegge dal raffreddore. Così un giorno Primo Levi, forse dopo aver raccolto una castagna dall’asfalto, scrive questa poesia che si intitola, appunto, Cuore di legno:
Il mio vicino di casa è robusto.
È un ippocastano di Corso Re Umberto;
ha la mia età ma non la dimostra.
Alberga passeri e merli, e non ha vergogna,
in aprile, di spingere gemme e foglie,
fiori fragili a maggio;
a settembre ricci dalle spine innocue
con dentro lucide castagne tànniche.
È un impostore, ma ingenuo: vuole farsi credere
emulo del suo bravo fratello di montagna
signore di frutti dolci e di funghi preziosi.
Non vive bene.
Gli calpestano le radici
i tram numero otto e diciannove
ogni cinque minuti; ne rimane intronato
e cresce storto, come se volesse andarsene.
Anno per anno, succhia lenti veleni
dal sottosuolo saturo di metano,
è abbeverato d’orina di cani.
Le rughe del suo sughero sono intasate
dalla polvere settica dei viali;
sotto la scorza pendono crisalidi
morte, che non diventeranno mai farfalle.
Eppure, nel suo torpido cuore di legno
sente e gode il tornare delle stagioni.
Non è questo lo spazio per una lunga analisi della lirica; limitiamoci a notare alcune particolarità:
α Levi stesso dichiara il portato autobiografico della poesia, mettendo in relazione la sua età con quella dell’ippocastano;
β l’ippocastano è descritto come un impostore, che ingenuamente vuole vivere l’esistenza del suo fratello di montagna;
γ l’ippocastano vive male (orina dei cani, lo smog, il crescere storto);
δ l’ippocastano nonostante tutto questo sente e prova il passare del tempo.
I quattro brevi punti mettono in evidenza come Levi, nei versi della poesia, rappresenti una particolare forma di impostura, quella di colui che ingenuamente si trova a vivere una esistenza che non è sua, una vita che non è una vita, un “vivere male” (faccio notare come basti un’inversione dei due termini e immediatamente ci risulta conoscibile la citazione da Ossi di seppia). Ma il “vivere male” di Levi è un sopravvivere male, è il vivere nonostante tutto, è il sentire le stagioni passare perché qualcun altro non ha potuto farlo: il passaggio dell’impostura che Levi produce – e che secondo me Alfano non indaga fino in fondo – è il passaggio dal “come se” all’“in vece di”[1].
La struttura dell’“in vece di” è, a parer mio, l’origine più antica e profonda dell’impostura, che affonda le sue radici nella commedia latina[2] e greca. La commedia trova la sua ragione d’essere nella sostituzione, nell vivere un’avventura al posto di un altro, nel gabbare qualcuno per poter soddisfare le proprie voglie: l’inganno, il travestimento, il cambio di identità dominano il mondo della commedia, quasi a suggerire l’instabilità del nostro “Io sono”, nella commedia l’affermazione “Io sono” è spesso una menzogna, un raggiro, o meglio ancora un equivoco . L’umiliazione comica, che avviene spesso attraverso l’impostura e che è qualcosa di diverso dall’agnizione nella tragedia, ha a che fare con il rendersi conto della propria nullità, del proprio essere nulla ; è il mostrare agli altri come siamo; è il rendersi conto che si è come gusci vuoti. L’idealtipo di questa impostura è, se vogliamo, Ser Bianca Doria, che troviamo nell’Inferno dantesco: un uomo che ha commesso peccati così gravi che la sua anima è già dannata, nonostante lui sia tutt’ora vivo e mangi e beva e vesta panni (non è causale che per descrivere il superstite nella poesia omonima Levi citi letteralmente l’episodio della Commedia). Questo genere di impostore vive male, è ormai svuotato, cavo come gli uomini vuoti di Eliot o come i personaggi descritti da Pound nei Pisan Cantos; questo impostore ha qualcosa di nuovo, che ha a che fare con l’uomo post-Auschwitz.
4. Ecco perché credo che la conclusione di Alfano su Carrère sia non sbagliata, ma incompleta. Paradossalmente Carrère e il suo avversario producono ancora un’idea dell’impostura legata al “come se”: certo l’autore francese rende bene quello stupore di vedere e di rappresentare un uomo che non è “niente”, ma con Auschwitz (prendiamo il nome del lager tedesco come figura di quella bancarotta della lingua, storia, cultura, religione e arte che avvenne nel mondo moderno post 1945) l’uomo passa dal poter non “essere niente” all’essere costretto a non “essere niente”. È un principio di svuotamento in cui l’impostore classico perde la sua caratteristica principale, ovvero l’essere qualcun altro, vestire i panni di qualcun altro: negli esempi portati da Alfano l’impostore sceglie di essere qualcun altro, decide razionalmente, anche se tace il motivo di assumere i panni di qualcuno. L’impostura post-Auschwitz perde questa intenzionalità, si diventa impostori malgrado sé, contro la propria volontà.
 Cosa resta quindi dell’impostura e dei personaggi che la rappresentano? Secondo me non resta che la messa in scena della stessa, e questo avviene nel bellissimo racconto Caro vecchio neon di David Foster Wallace. Il racconto, scritto in prima persona, è il resoconto di un’impostura che dichiara di essere tale. Ovviamente, un impostore che dice sin dalla prima riga “Io sono un impostore” pone a noi un dilemma linguistico, logico, filosofico e ontologico non dissimile dal famoso paradosso del mentitore, ovvero quel cortocircuito all’interno del quale mi trovo nella difficoltà a capire se “questa frase (che sto scrivendo) sia falsa”. Il racconto di DFW gioca sullo stesso evento linguistico: se io dico se sono un impostore, il mio dire è una forma di confiteor, di smascheramento, o è solo un modo più sottile di affermare che sono comunque un impostore? Se rimaniamo alla lettera del racconto, alla logica che è sottintesa alle frasi, non si riesce a venirne a capo, che è poi ciò che rende interessanti i paradossi. Lo stesso autore, però, aiuta a districarsi da tutto questo, quando fa affermare all’io narrante di essere un io narrante particolare. Il personaggio che dice Io in Caro vecchio neon è morto suicida. L’impostore parla da una sorta di extraluogo, sub specie aeternitatis, in cui, quasi seguendo le orme di Ockham, ci suggerisce di leggere la sua confessione d’impostura non tanto come un racconto – l’ennesimo bugiardo che racconta la sua bugia – ma come una meta-riflessione[3] su cosa sia impostura, su cosa significhi nel postmoderno, nel mondo dopo Auschwitz, essere impostori.
Cosa resta quindi dell’impostura e dei personaggi che la rappresentano? Secondo me non resta che la messa in scena della stessa, e questo avviene nel bellissimo racconto Caro vecchio neon di David Foster Wallace. Il racconto, scritto in prima persona, è il resoconto di un’impostura che dichiara di essere tale. Ovviamente, un impostore che dice sin dalla prima riga “Io sono un impostore” pone a noi un dilemma linguistico, logico, filosofico e ontologico non dissimile dal famoso paradosso del mentitore, ovvero quel cortocircuito all’interno del quale mi trovo nella difficoltà a capire se “questa frase (che sto scrivendo) sia falsa”. Il racconto di DFW gioca sullo stesso evento linguistico: se io dico se sono un impostore, il mio dire è una forma di confiteor, di smascheramento, o è solo un modo più sottile di affermare che sono comunque un impostore? Se rimaniamo alla lettera del racconto, alla logica che è sottintesa alle frasi, non si riesce a venirne a capo, che è poi ciò che rende interessanti i paradossi. Lo stesso autore, però, aiuta a districarsi da tutto questo, quando fa affermare all’io narrante di essere un io narrante particolare. Il personaggio che dice Io in Caro vecchio neon è morto suicida. L’impostore parla da una sorta di extraluogo, sub specie aeternitatis, in cui, quasi seguendo le orme di Ockham, ci suggerisce di leggere la sua confessione d’impostura non tanto come un racconto – l’ennesimo bugiardo che racconta la sua bugia – ma come una meta-riflessione[3] su cosa sia impostura, su cosa significhi nel postmoderno, nel mondo dopo Auschwitz, essere impostori.
Ed ecco che a questo punto del racconto fa la sua comparsa DFW, che viene evocato dal suo stesso personaggio, come colui che lo ha creato, per cercare di capire perché questa persona, che forse – sarà una bugia?, una mezza verità? – è realmente esistita, un uomo che aveva tutto dalla vita, abbia deciso di suicidarsi. E DFW non trova di meglio da dire, sostiene il suo stesso personaggio, che trasformarlo in un impostore, in qualcuno che parla “in vece sua”, al posto del suo autore. L’impostore, quindi, secondo egli stesso e secondo DFW, torna a essere una semplice espressione di parole, un qualcosa di vuoto, di splendidamente vuoto, che si auto-genera dalle parole stesse. E non è casuale appunto che Caro vecchio neon[4] si concluda con una citazione di Amleto: “Non una parola di più”, un invito al silenzio e al mutismo che avvicina in maniera precisa Amleto a Iago, entrambi custodi di un segreto più profondo che, ahinoi, non verrà mai rivelato.
L’impostore, quindi, è infine un mistero, un mistero che si riveste di parole, che trova il suo significato nelle parole e che ne dimostra l’inutilità; proseguendo il ragionamento, la letteratura, quindi, non è tanto menzogna, con buona pace di Manganelli, ma è impostura, la produzione di uno spazio vuoto e finto in cui, per un breve tempo che va dall’incipit all’explicit, si dicono parole che preannunciano un mistero mai svelato o non completamente.
Note
[1] Chi vede in questo “vivere male” una prima ed embrionale riflessione sull’essere il Caino di qualcun altro (così come mirabilmente descritto da Levi nei Sommersi e i salvati), che caratterizzerà la riflessione sulla vergogna nelle ultime opere leviane, secondo me ha ragione.
[2] Faccio notare che Levi, nella prefazione a La vita offesa (FrancoAngeli), per parlare del bisogno e della necessità degli ex-deportati di parlare e raccontare le proprie storie cita Plauto e il miles, questo reduce un po’ millantatore e un po’ sbruffone che è un vero e proprio “carattere” della commedia latina classica. Forse l’indagine sull’impostura leviana, che non a caso inizia proprio con questa prefazione e poi prosegue fino alla elaborazione ne I sommersi e i salvati, ha molto a che fare con questa figura di soldato fanfarone e che dice bugie.
[3] Per farla breve, Ockham diceva che il paradosso “questa frase è falsa” è tale solo se lo guardiamo dal punto di vista strettamente linguistico, ma se cambiamo punti di vista – mi si perdoni la semplificazione – e lo guardiamo dal punto di vista meta-linguisitco, la frase ha un senso perché ci porta a riflettere su cosa sia il concetto di falso.
[4] Il titolo del racconto si comprende solo alla fine. Inizialmente il lettore si chiede quale sia il significato di questo neon, ebbene verso il finale delle del racconto l’impostore dice che DFW lo vedeva “sempre circondato da un’aureola che sembrava quasi al neon”. Partendo da questa citazione si può desumere che a pronunciare la frase del titolo sia proprio DFW, l’autore, che in quel modo si riferisce all’amico e quindi si potrebbe leggere il titolo come “Caro vecchio amico”.


