La psicoanalisi mirava alla profondità, le neuroscienze alla superficie, in parallelo con altri fenomeni tipici delle nostre società liquide o ipermoderne, di cui sono note la predilezione per la cartografia, le mappe, la perdita di spessore del passato e del futuro. Viene da domandarsi: con quale delle due aree di ricerca può utilmente allearsi la letteratura?
Schematizzando si può dire che la psicoanalisi immaginava l’essere umano come un’entità stratificata (Freud ha spesso usato metafore di origine mineraria o archeologica) percorsa da tensioni fra l’insieme corporeo delle sensazioni di piacere e dolore, delle pulsioni di origine sessuale e l’insieme psichico e mentale distinto in una parte conscia, collocata in posizione elevata e una parte inconscia, rappresentabile (come in una proiezione in 3d) in una dimensione di profondità. Le neuroscienze, invece, vedono l’uomo a una dimensione (nessun rapporto diretto con le idee di Marcuse, che a modo suo era un seguace di Freud), costituito da un ampio cranio (contenitore), da un intricato cervello (contenuto) e da un intreccio nervoso molto complesso.
A questo sistema, paragonato a volte a un computer o a una rete di fibre che operano per forza elettrica o chimica, vengono attribuite le capacità squisitamente umane dell’elaborazione e comunicazione linguistica e, grazie ai famosi neuroni specchio, la capacità creativa di provare empatia e di inventare e raccontare mondi.
Ci sono, fra gli studiosi (e anche fra i linguisti, i pedagogisti e gli esperti di didattica), molte manifestazioni di entusiasmo un po’ ingenuo per le novità delle neuroscienze. Ma ci sono anche posizioni più meditate e problematiche, con proposte abbastanza interessanti. Nel libro Convergenze (Milano, 2010), ho riferito in dettaglio la posizione del professore americano Paul Hernadi, il quale mette in rapporto i processi mentali di chi legge un’opera letteraria (proiezione fuori di sé di un mondo immaginario, partecipazione, conoscenza) con i processi psicologici che i cognitivisti attribuiscono al nostro cervello (possibilità di sdoppiarsi, rispecchiarsi in una situazione immaginaria, rappresentarla dentro di sé, volontariamente costruirsi una situazione di sogno). Egli inoltre collega quei processi con la lunga evoluzione della razza umana, dalle reazioni meccaniche e istintuali alle più complesse forme di traduzione linguistica delle situazioni, capacità di risolvere problemi e prevedere azioni future, rafforzamento dei processi biologici della sopravvivenza e della selezione della specie, adattamento all’ambiente. Hernadi attribuisce alla letteratura (intesa in senso ampio come capacità immaginativa) una funzione essenziale nell’evoluzione della specie.
Certo quando Hernadi utilizza, su suggerimento di alcuni suoi colleghi cognitivisti dell’Università della California a Santa Barbara, la metafora del coltellino dell’esercito svizzero per parlare delle molte e diverse funzioni a cui può adattarsi il cervello umano, egli cade inevitabilmente in posizioni funzionaliste, un po’ troppo appiattite sui meccanismi del cervello come macchina pensante.
Fra le altre proposte degne di interesse, ricordo il grosso manuale in lingua tedesca scritto dal poeta austriaco (autore, fra l’altro, di una nuova traduzione dell’Iliade) Raoul Schrott e dallo psicologo tedesco della Freie Universität di Berlino Arthur Jacobs. Il loro libro, che si intitola con bella allitterazione sillabica Gehirn und Gedicht (Cervello e poesia – Come costruiamo le nostre realtà, Monaco 2011), si occupa, da un punto di vista rigorosamente neuroscientifico, d’intelligenza e memoria, relazioni, intenzioni ed emozioni, metafore, similitudini e allegorie, onomatopea e sinestesi, verso e rima, immagini e figure di pensiero. Ricordo, inoltre, le intelligenti riflessioni di Alberto Casadei, che nel libro Poetiche della creatività. Letteratura e scienza della mente (Milano, 2011), rinnova in modo abbastanza fruttuoso le esperienze della stilistica di Spitzer e del formalismo e strutturalismo russo, praghese e francese. Casadei ricorda la teoria del click a cui Spitzer attribuiva la capacità intuitiva di riconoscere lo stile specifico di un’opera e addirittura quello che, ancora idealisticamente, egli chiamava l’«etimo spirituale».
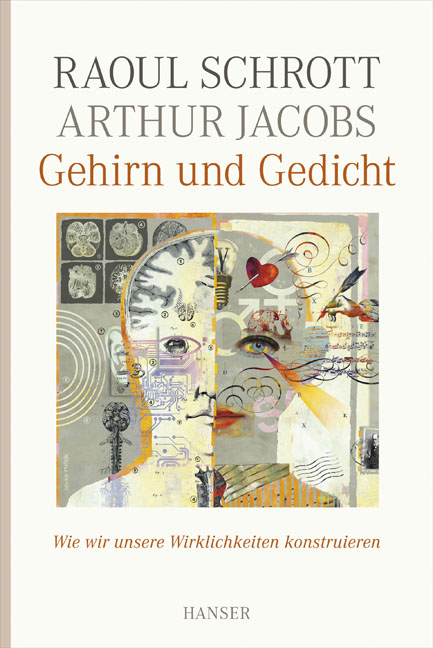
Differenziandosi nettamente, Casadei propone una rigorosa indagine dei procedimenti che portano creativamente alla formazione di uno stile. E ancora ricordo, dal fronte dei neuroscienziati, gli interessanti interventi, in materia di teoria linguistica, estetica, teatro e teoria letteraria, da parte di uno dei componenti del gruppo parmense che, sotto la direzione di Giacomo Rizzolati, ha scoperto i neuroni specchio: alludo a Vittorio Gallese, con il quale ho intrattenuto qualche tempo fu un dialogo molto interessante (Intervista a Vittorio Gallese, in «Transpostcross», marzo 2012).
Di recente, nel 2008, un neuropsichiatra francese, molto noto anche da noi, Jean-Pierre Changeux del Collège de France e dell’Institut Pascal, ha scritto un libro intitolato, nella traduzione italiana, Il bello, il buono, il vero. Un nuovo approccio neuronale (Milano, 2013). Un filosofo inglese, Colin McGinn, ha pubblicato sulla «New York Review of Books» (11 luglio 2013) una lunga recensione molto critica del libro. Ne è seguito un vivace scambio di lettere fra i due sulla stessa rivista (15 agosto-25 settembre). Le principali accuse mosse da McGinn sono queste: 1) Changeux scambia il contenuto di uno stato mentale con lo stato mentale stesso; fa confusione fra atto e oggetto dell’atto (per esempio: «quando un matematico pensa, il suo cervello si mette a vibrare e ronzare, ma ciò non significa che oggetto del suo pensiero sia il suo stesso cervello»); 2) Changeux cade nell’errore che viene normalmente definito «riduzionismo» (per esempio, egli non discute la bellezza come attributo di una certa opera d’arte, ma piuttosto la nostra percezione di quella bellezza: «l’atto, non l’oggetto»). Dalla recensione e dallo scambio polemico fra Changeux e McGinn risultano due posizioni inconciliabili: da una parte c’è un atteggiamento, che potremmo tranquillamente chiamare «materialistico», per cui quel che conta è il comportamento del cervello e dei neuroni; dall’altra c’è la fedeltà a una tradizione filosofica antica, che senza ricorrere alla concezione dell’anima e delle idee di Platone, mantiene una netta distinzione fra cervello e mente, fra sensazioni e coscienza (il rapporto fra mente e coscienza è il tema principale di molti scritti di McGinn). Egli scrive: «Sappiamo tutti molto bene cos’è la coscienza; ma a me risulta assai difficile capire come la coscienza possa sorgere semplicemente dalle proprietà elettriche e chimiche del cervello. Non ho inteso liquidare i progressi delle neuroscienze come una sorta di neuromania. È il considerare insistentemente le neuroscienze come chiave di tutti i problemi filosofici che appare una forma di neuromania. Non ho niente contro i neuroni, mi sono simpatici – ma penso che essi non siano la chiave per capire la bellezza, la bontà e la verità».

