
Se un tempo erano disposti a tollerarle come un costoso ornamento, ora sono drastici: «La soluzione del problema è semplice: cancellare programmi e corsi che agli studenti riservano soltanto disoccupazione». Se poi alcuni proprio vogliono studiare sciocchezzuole come il latino, la storia, la geografia o la letteratura inglese, i politici, con tipica brutalità americana, scendono sul terreno della spesa e intimano: «paghino più degli altri».
Le risposte che vengono dagli ambienti delle scienze umane e sociali a me sembrano tutto sommato abbastanza deboli, anche perché tendono a rappresentare lo scontro fra due blocchi: da una parte le scienze umane, o arti liberali (che danno gloria e niente guadagni), dall’altra, in un unico mucchio, le scienze dure, le conoscenze professionali e le applicazioni tecnologiche (che sarebbero molto più remunerative in un mondo dominato dalle ragioni economiche, dagli affari, dalla grande finanza – ma questo è vero per chi fa ricerca nei laboratori scientifici?).

Ho visto, fra gli altri, un documento preparato da una commissione apposita dell’Università di Harvard negli anni 2012-2013, intitolato The Teaching of the Arts and Humanities at Harvard College. Mapping the Future e un altro preparato dall’American Academy of Arts and Sciences, reso pubblico anch’esso quest’anno, intitolato The Heart of the Matter. The Humanities and Social Sciences. For a vibrant, competitive, and secure nation. In questi documenti, e specialmente nel secondo, c’è molta retorica, molte cose note (tutto sommato giuste) sull’importanza della conoscenza storica e delle capacità critiche degli studenti e si arriva, nel documento di Washington, a sostenere che le scienze umane possono aiutare a rafforzare la sicurezza del Paese: «l’America avrebbe migliorato la ‘guerra al terrorismo’ se avesse incrementato la conoscenza della lingua araba prima dell’inizio delle ostilità» (dice la lingua, neanche la cultura). Il documento di Harvard, oltre a difendere il ruolo delle scienze umane nello sviluppo delle capacità critiche, nello smascheramento delle logiche di potere e nella creazione di «cittadini responsabili impegnati a vivere e preservare la società democratica», arriva a esaltare, con qualche esagerazione, il pur importante contributo che gli ‘umanisti’ possono dare all’incremento del relativismo dei valori: «Noi aspiriamo a fondare il nostro senso di noi stessi su una conoscenza stabile dei nostri ideali nella vita (per esempio, il nostro ruolo di cittadini responsabili in una società libera), ma al tempo stesso dobbiamo costantemente aspirare a scoprire di nuovo qual è il modo migliore per caratterizzare e coltivare quell’ideale. Le scienze umane sono il luogo in cui questa tensione viene coltivata, nutrita e sostenuta».
Ai documenti americani si può accostare, perché mosso da un uguale spirito di difesa delle scienze umane sotto attacco nel mondo scolastico e accademico italiano, Un appello per le scienze umane pubblicato sulla rivista «Il Mulino» nel numero 6 dello scorso ottobre, con motivazioni e discorsi che sono in parte diversi da quelli americani, perché adattati alla nostra situazione e per questo concentrati sull’importanza dell’insegnamento della storia, della lingua e della letteratura italiana. Si tratta di un appello, anch’esso inevitabilmente retorico, come richiede il genere di discorso a cui appartiene, decisamente polemico contro la «crescente tecnicizzazione», contro il crescente «carattere scientifico-tecnologico [della didattica – ecco la versione italiana dello STEM] opportunamente avvolto nell’involucro di un’informe, e non di rado retorica, pedagogia civica (educazione alla Costituzione, all’affettività ecc.) a scapito dei contenuti ‘umanistici’ tradizionali». L’appello è firmato da un letterato come Alberto Asor Rosa, un filosofo come Roberto Esposito e uno storico come Ernesto Galli della Loggia: intellettuali notoriamente diversi fra loro per convinzioni ideologiche, ma uniti nella volontà di gettare un allarme, e anche di esprimere posizioni molto simili a quelle degli umanisti di Harvard e dell’Accademia di Washington. Simile è, per esempio, la tesi (del resto condivisibile) che «molte delle nuove professioni digitali e telematiche, come anche la gestione dei rapporti con il personale nelle imprese, richiedono operatori dotati di una conoscenza di base e di una creatività che solo alcune facoltà umanistiche, opportunamente rinnovate, possono dare».

Uno dei problemi che incombono su questo tipo di discussioni è che il sistema delle discipline nelle nostre scuole, in particolare in quelle americane, che hanno gradualmente abbandonato il modello humboldtiano, non è costituito da due blocchi, ma da tre: da una parte le tradizionali discipline umanistiche, dall’altra le altrettanto tradizionali e importantissime discipline scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia, scienze naturali, neuroscienze) e dall’altra ancora le discipline più legate alla tecnologia e alle applicazioni pratiche (ingegneria, medicina, scienze dell’educazione, scienze politiche, ecc.). Al tempo dell’organizzazione dei grandi sistemi educativi europei, le istituzioni scolastiche erano distinte in scuole di educazione generale (ginnasi, licei, collegi) e scuole di formazione professionale e, a livello accademico, fra «Università» e «Scuole», cioè «Hochsculen» o «Technische Schulen»: i «Politecnici», i «Conservatori», le «Scuole d’arte», ecc. A queste si sono aggiunte, in America, con progressivo cedimento prima delle istituzioni di provincia poi anche di quelle prestigiose come Harvard, Yale, Stanford, le «Schools of Management», le «Business Schools» e altre simili che preparano alle professioni nel mondo degli affari.

Le motivazioni culturali, gli scopi e gli interessi delle discipline umanistiche e di quelle scientifiche sono sostanzialmente simili, ed è necessario secondo me sostenerli e difenderli insieme; quelli delle scuole professionali sono diversi e hanno la loro legittimità e importanza (pensate all’utilità dell’ingegneria o ai grandi trionfi della medicina, che ha allungato in tutto il mondo avanzato la durata media della vita), ma hanno inevitabilmente un diverso rapporto con le fonti di finanziamento, obbiettivi diversi nella formazione e criteri diversi nella valutazione dei risultati.
Le ragioni che hanno ispirato la grande tradizione europea delle scuole e delle università e le hanno volute aperte a tutta la popolazione e finanziate in toto o in parte dallo Stato sono ben note (e spesso sono state sostenute da Habermas): l’incremento della preparazione culturale, della capacità di ragionamento, della responsabilità morale ottenute dagli studenti attraverso il percorso educativo si risolvono in un miglioramento individuale, ma anche in una crescita culturale generale della società. Nel caso delle scuole professionali lo scopo è molto più concentrato sulla preparazione del singolo e gli consente uno sfruttamento anche economico della professione appresa e una carriera di successi e onorari adeguati (magari anche, per scelta individuale, di interventi utili per tutti). In questo caso sembra giusto che, tramite numeri chiusi, esami di ammissione, tasse di iscrizione, prestiti di onore e simili lo studente faccia un «investimento» economico nella scuola e si riprometta di trarne a suo tempo un vantaggio.
A questo proposito va ricordato che il sistema americano è molto diverso da quello europeo e che per questo qualsiasi applicazione di quel modello al nostro sistema è sempre un’operazione delicata, da fare con grande prudenza. I nostri pedagogisti tendono a dimenticarsene troppo spesso. Il sistema americano non ignora forme di investimento statale nelle scuole e università pubbliche, nei Community Colleges e simili; ma la presenza di scuole private è dominante e tanto più pericolosa da quando, sulla spinta delle logiche di mercato, le scuole preparatorie e secondarie, anche quelle di eccellente tradizione, si sono via via trasformate in «imprese» economiche e le grandi università in «Corporations».
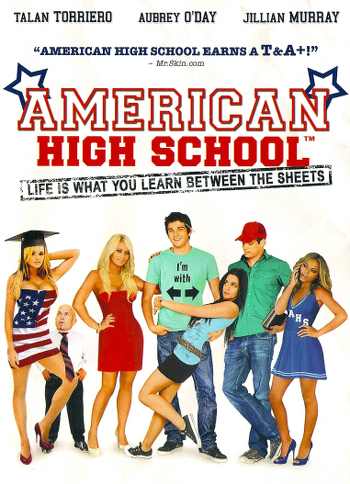
È il caso di ricordare che la retta per gli studenti che frequentano le scuole medie private, dove si impartiscono insegnamenti preparatori di materie umanistiche, scientifiche e professionali (dai 6 ai 12 anni) è in media di circa 30.000 dollari all’anno (38.000 se gli allievi frequentano corsi speciali di «Academic Support Programs», cioè di corsi avanzati per coloro che pensano poi di andare al college) e che la retta per quelli che frequentano gli istituti superiori privati («High Schools») è di 35-40.000 dollari all’anno (50-60.000 per quelli che scelgono di vivere in comunità). Le rette universitarie sono naturalmente più alte.
Fra i testi del dibattito suscitato dalla pubblicazione dei due documenti americani mi piace citare, per il suo vigore polemico, l’editoriale di Thomas Frank, intitolato Course Corrections, nella bella rivista «Harper’s Magazine» dell’ottobre scorso (pp. 10-13). Frank, che è un intellettuale progressista e democratico, non risparmia critiche alla combinazione di velleità retoriche, buone intenzioni e vacuità di proposte che ritrova nei due documenti. Poi, con schiettezza, riporta il discorso sulla crisi delle scienze umane alle sue basi economiche e quindi sull’intero sistema politico della società statunitense. Gli studenti che scelgono, al termine del percorso scolastico, le scuole professionalizzanti, hanno investito, oltre alle notevoli somme delle scuole inferiori, circa 60.000 dollari all’anno per tutti gli anni della loro formazione universitaria (prima del dottorato). Se hanno fatto prestiti d’onore ci vorranno non pochi anni di carriera professionale per ripagare i circa 240.000 dollari spesi da loro o dai loro genitori, ma alla fine saranno soddisfatti. Nessuna meraviglia che la grande maggioranza degli studenti segua questa strada. Gli altri, che hanno scelto il percorso umanistico o quello scientifico, spendendo cifre esattamente uguali, si ritroveranno sì con una bella formazione culturale, ma con pochissimi sbocchi lavoratovi e con scarse prospettivi di ripagare i debiti fatti. Conclude Frank, rivolgendosi agli estensori del documento di Harvard: «Professori, smettete di far propaganda per le vostre istituzioni. Cambiatele. Afferrate le leve del potere e azionatele».

