
1. In questi giorni mia figlia sta leggendo The Picture of Dorian Gray. La prima cosa che l’ha colpita del romanzo è stata la famosa introduzione in cui Wilde sostiene che tutta l’arte è perfettamente inutile. Così lei è venuta da me chiedendomi: «Perché scrive che tutta l’arte è inutile?». Confesso che la mia risposta alla sua domanda è stata sbrigativa, non diversa da quelle tre/quattro cose che si insegnano a scuola: l’estetismo, la crisi dell’intellettuale e la perdita di aureola, l’industrializzazione della società, la marginalità economica del prodotto culturale e bla… bla... Mia figlia si è detta soddisfatta, ma io, invece, no. Così sono rimasto ancora un po’ a lambiccarmi sulla sua domanda, e anziché che riflettere sull’utilità o l’inutilità dell’arte, ho capito che avrei dovuto risponderle utilizzando le categorie dell’agio e del disagio.
Come scrive Franco Moretti in Segni e stili del moderno: «Diciamo che la funzione sostanziale della letteratura consiste nell’assicurare il consenso. Nel far sentire l’individuo a suo agio nel mondo in cui si trova a vivere, a conciliarlo in modo piacevole e inavvertito con le norme culturali che vi prevalgono. Questa l’ipotesi di fondo». È da molto tempo che mi interrogo su questo assunto, perché non sono convinto che individui il motivo segreto, il compito/fine?, della letteratura; mi sembra che il ragionamento del grande critico contenga in sé una fallacia, che però non ero riuscito a scovare fino a quando non ho avuto quel breve scambio di opinioni con mia figlia.
Partiamo dal presupposto che Moretti abbia ragione, che la frase che abbiamo appena letto sia condivisibile in toto; ora mi chiedo: “Cosa accade se il mondo, di cui la letteratura ha il compito di comunicarci l’agio e la comodità, è letteralmente sul punto di collassare, di finire, di implodere in sé stesso?”. Formulo il concetto in un altro modo: “Cosa accade se la letteratura, o meglio questa immagine borghese della letteratura e del romanzo, che Moretti veicola come specchio autorappresentativo e autoassolutorio, viene posta di fronte all’estinzione e alla morte di quello stesso mondo che vorrebbe rappresentare? Cosa rimane del mondo rappresentato, quando il rappresentabile tende al caos, alla distruzione e alla fine?”.
2. Non credo sia casuale che, nel corso di questi anni, il numero di pubblicazioni nostrane (all’estero questo tipo di “discorso letterario” è già attivo da più tempo), afferenti al tema generico de “la fine del mondo” sia divenuto dominante; termini e concetti come ecocidio, antropocene, apocalisse climatica, rischio estinzione ecc. sono divenuti sostanzialmente di dominio pubblico, tanto da rendere la battuta pronunciata da uno dei personaggi de Il re pallido di David Forster Wallace – «Sai che novità. Notizia flash: moriremo» – patrimonio comune. È questo il sottofondo, il minimo comune denominatore di tutte e diverse riflessioni: siamo andando verso il collasso, la distruzione di noi e della terra.
Ora, che gli uomini abbiano una straordinaria capacità di non accorgersi dei disastri che producono non è una novità, ce lo ricorda Pascal che nei Pensieri descrive proprio il genere umano tutto impegnato a correre bendato verso un precipizio. Negli ultimi 400 anni non pare che sia cambiato nulla nel nostro modo di essere, e così, mentre formulavo questi pensieri, che – ne sono consapevole – rimandano una idea fatalista del nostro stare nel mondo, e come tali indirizzano in un certo modo il mio ragionamento, ho pensato a tre libri che mi sono capitati in mano nelle ultime settimane.
Tre titoli molto diversi, ma che hanno tutti a che fare con l’apocalisse; il primo è un estravagante commento al libro dell’Apocalisse, dal titolo La necessità degli apocalittici di Geminello Alvi (Marsilio), il secondo è un breve saggio in bilico tra critica letteraria e antropologia di Carla Bendetti, La letteratura ci salverà dall’estinzione (Einaudi), e l’ultimo è un romanzo/memoir di Marc O’Connell Appunti da un’Apocalisse. Viaggio alla fine del mondo e ritorno (il Saggiatore, traduzione di Alessandra Castellazzi). Ciò che segue è un tentativo di panoramica, riflessione e estemporanea conclusione rispetto a questi tre lavori.
 3. Il saggio di Alvi si presenta come una divertita ed erudita scorribanda nel libro più iconico e meno letto del Nuovo Testamento, un testo che forse più degli altri riprende l’imagery della Bibbia ebraica, ma riscrivendola e dialogando con il grandi profeti del passato senza mai citarli; Alvi tende, infatti, a sottolineare come l’intertestualità dell’Apocalisse sia data non tanto dalle citazioni (i riferimenti letterali dall’Antico Testamento sono pochissimi) quanto da suggestioni, rifacimenti e riscritture. L’Apocalisse, come libro, è una ri-Scrittura, perché l’annuncio di un cielo nuovo e una terra nuova, che viene scritto nel nuovo libro che verrà aperto, quando i sigilli saranno rotti. La necessità degli apocalittici, quindi, vede nell’ultimo testo del Nuovo Testamento non la rivelazione decisiva del mondo, la caduta delle ombre e lo svelamento della verità, ma una ricapitolazione, un enorme riassunto in cui la storia del mondo di mostra così come è da sempre.
3. Il saggio di Alvi si presenta come una divertita ed erudita scorribanda nel libro più iconico e meno letto del Nuovo Testamento, un testo che forse più degli altri riprende l’imagery della Bibbia ebraica, ma riscrivendola e dialogando con il grandi profeti del passato senza mai citarli; Alvi tende, infatti, a sottolineare come l’intertestualità dell’Apocalisse sia data non tanto dalle citazioni (i riferimenti letterali dall’Antico Testamento sono pochissimi) quanto da suggestioni, rifacimenti e riscritture. L’Apocalisse, come libro, è una ri-Scrittura, perché l’annuncio di un cielo nuovo e una terra nuova, che viene scritto nel nuovo libro che verrà aperto, quando i sigilli saranno rotti. La necessità degli apocalittici, quindi, vede nell’ultimo testo del Nuovo Testamento non la rivelazione decisiva del mondo, la caduta delle ombre e lo svelamento della verità, ma una ricapitolazione, un enorme riassunto in cui la storia del mondo di mostra così come è da sempre.
C’è, nel racconto apocalittico giovanneo, un tempo lungo (letteralmente mezz’ora) in cui il mondo rimane in silenzio (Ap 8, 1). In questa sospensione la vita si ferma e in quello spazio e momento preciso lo scorrere dell’esistenza si arresta e diventa presente. Così, secondo Alvi, durante tale silenzio altissimo e profondissimo (così simile a quello che Leopardi descrive ne Il cantico del gallo silvestre) vedremo (o abbiamo già visto?) le cose come sono sempre state.
L’Apocalisse, quindi, non è il libro in cui male viene sconfitto, ma semplicemente dove si mostra ciò che l’esistenza sarà quando il mondo finirà. La conclusione di Alvi è semplice quanto disarmante: l’apocalittico non può nulla sul male.
Questa tesi fondamentale de La necessità degli apocalittici segna una rottura rispetto all’intento con cui molti di questi libri sulla fine del mondo vengono scritti o letti, perché a loro fondamento c’è la volontà di rispondere alle seguenti domande: “cosa possiamo fare?”, “come dobbiamo comportarci?”. Chi legge questi libri desidera che gli venga rivelato il modo per sopravvivere a questa imminente fine del tempo.
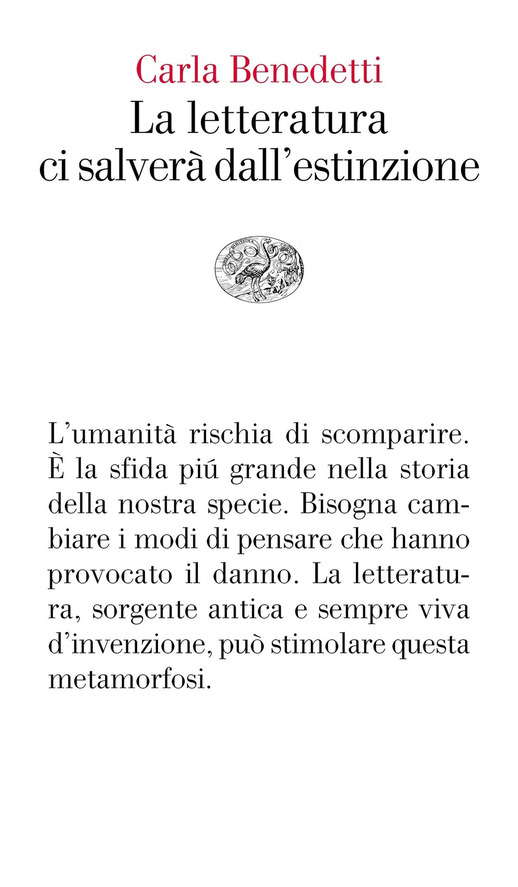 4. Nel libro di Benedetti questa tensione di praxi innerva ogni pagina: Moresco, Gosh, Anders vengono interrogati per trovare i modi, i mezzi, le mappe e le tracce per impedire la catastrofe imminente; anche questo è, quindi, un libro di commento all’Apocalisse, perché lo scandaglio delle varie opere letterarie si muove alla ricerca del segno, dell’interpretazione tropologica che indichi la via di uscita, per cui l’uomo possa nuovamente stare a proprio agio e in armonia con il mondo. Nel libro di Benedetti si possono ravvisare due “assenze”, entrambe interessanti. Il libro si apre, infatti, con una riflessione sulla bomba atomica; per questo, stupisce vedere appena citata ma non analizzata a dovere la pagina finale e profetica de La coscienza di Zeno (forse perché Svevo nella sua pagina conclusiva non lascia al lettore molte speranze di agio?). Impressione che si rafforza quando si constata che nel corso del ragionamento di Benedetti non vi siano riferimenti diretti o indiretti né a Pro o contro la bomba atomica né a La storia di Morante, che è forse il romanzo più apocalittico della nostra letteratura. Ci si può chiedere il perché di tale assenza, e rispondere sostenendo che Morante nel racconto delle vicende del romanzo non produca una risposta pratica e decisiva su quello scandalo che dura 10mila anni (i.e. la storia in sé stessa). Morante traccia le biografie di Useppe e Ida all’interno della Storia, ma senza che queste possano in qualche modo modificarsi o cambiare, come se tutto fosse stabilito, come se la letteratura nulla possa fare se non serbarne una memoria nell’accettazione di un destino segnato da sopruso e dalla fine. Come potrebbe Benedetti parlare di un romanzo dove la letteratura è chiamata semplicemente a contemplare l’estinzione?
4. Nel libro di Benedetti questa tensione di praxi innerva ogni pagina: Moresco, Gosh, Anders vengono interrogati per trovare i modi, i mezzi, le mappe e le tracce per impedire la catastrofe imminente; anche questo è, quindi, un libro di commento all’Apocalisse, perché lo scandaglio delle varie opere letterarie si muove alla ricerca del segno, dell’interpretazione tropologica che indichi la via di uscita, per cui l’uomo possa nuovamente stare a proprio agio e in armonia con il mondo. Nel libro di Benedetti si possono ravvisare due “assenze”, entrambe interessanti. Il libro si apre, infatti, con una riflessione sulla bomba atomica; per questo, stupisce vedere appena citata ma non analizzata a dovere la pagina finale e profetica de La coscienza di Zeno (forse perché Svevo nella sua pagina conclusiva non lascia al lettore molte speranze di agio?). Impressione che si rafforza quando si constata che nel corso del ragionamento di Benedetti non vi siano riferimenti diretti o indiretti né a Pro o contro la bomba atomica né a La storia di Morante, che è forse il romanzo più apocalittico della nostra letteratura. Ci si può chiedere il perché di tale assenza, e rispondere sostenendo che Morante nel racconto delle vicende del romanzo non produca una risposta pratica e decisiva su quello scandalo che dura 10mila anni (i.e. la storia in sé stessa). Morante traccia le biografie di Useppe e Ida all’interno della Storia, ma senza che queste possano in qualche modo modificarsi o cambiare, come se tutto fosse stabilito, come se la letteratura nulla possa fare se non serbarne una memoria nell’accettazione di un destino segnato da sopruso e dalla fine. Come potrebbe Benedetti parlare di un romanzo dove la letteratura è chiamata semplicemente a contemplare l’estinzione?
Se questa assenza, proprio perché mette in crisi la tesi stessa del libro, è quindi spiegabile, meno lo è il mancato accenno o riflessione sull’esperienza del romanzo collettivo TINA. Storie della grande estinzione (Aguaplano) curato da Matteo Meschiari e Antonio Vena. Pur con differenze sostanziali e concettuali, l’operazione Benedetti e quella di Meschiari&Vena mirano a fornire una mappa di un possibile agire umano sociale e politico in questo tempo infra-apocalittico e post apocalittico; entrambi i testi si muovono convinti che la letteratura possa essere in un certo senso utile, mezzo concreto di sopravvivenza, per resistere al collasso; e che anzi per opporsi a questa grande estinzione la risposta stia proprio in una nuova immaginazione e quindi di una idea di letteratura rinnovata. Date queste premesse, sorprende l’assenza di menzione di questo romanzo e di tutta l’operazione di produzione, di sviluppo teorico molto importante e imponente, che avrebbe meritato un posto in questa idea messianica di letteratura, teorizzata nel saggio da Benedetti.
 5. Questo articolo è iniziato con breve intermezzo di paternità. Proprio sul tema della paternità, sul rapporto del genitore con il futuro del proprio figlio, sul domandarsi se in un mondo che va in rovina sia utile, necessario e saggio mettere al mondo altri esseri umani, si fonda la tesi del libro di O’Connell Appunti da un’Apocalisse, una storia in cui l’autore riversa in ogni pagina la propria ossessione sul tema della fine del mondo. Queste 235 pagine rappresentano il tentativo di descrivere persone, luoghi e momenti in cui possa darsi testimonianza di come il sentimento escatologico della fine sia presente. O’Connell descrive i suoi vagabondaggi via web e per il mondo alla ricerca dei diversi testimoni della nuova apocalisse, mettendone in risalto tic, nevrosi e paure, e in loro egli specchia sé stesso. L’autore sceglie l’ironia per mettere in evidenza i vari non sequitur del pensiero apocalittico: tra i tanti che ravvisa, è interessante sottolineare una certa ideologia reazionaria presente in molti “immaginari” apocalittici, dove spesso a vincere è il più forte, quello che ha preparato lo zaino migliore ecc. Ciò suggerisce che, forse, dovremo fare i conti su quanto e come sia “reazionario” il mito della sopravvivenza alla fine del mondo, e di come forse l’accettazione del nostro destino fragile, del nostro essere una specie tra le altre destinate all’estinzione, sia in realtà un mitologema molto più «progressivo» (uso questo aggettivo nell’accezione che Luporini diede nel suo celebre scritto su Leopardi) che non immaginarci futuri mondi possibili dopo il collasso.
5. Questo articolo è iniziato con breve intermezzo di paternità. Proprio sul tema della paternità, sul rapporto del genitore con il futuro del proprio figlio, sul domandarsi se in un mondo che va in rovina sia utile, necessario e saggio mettere al mondo altri esseri umani, si fonda la tesi del libro di O’Connell Appunti da un’Apocalisse, una storia in cui l’autore riversa in ogni pagina la propria ossessione sul tema della fine del mondo. Queste 235 pagine rappresentano il tentativo di descrivere persone, luoghi e momenti in cui possa darsi testimonianza di come il sentimento escatologico della fine sia presente. O’Connell descrive i suoi vagabondaggi via web e per il mondo alla ricerca dei diversi testimoni della nuova apocalisse, mettendone in risalto tic, nevrosi e paure, e in loro egli specchia sé stesso. L’autore sceglie l’ironia per mettere in evidenza i vari non sequitur del pensiero apocalittico: tra i tanti che ravvisa, è interessante sottolineare una certa ideologia reazionaria presente in molti “immaginari” apocalittici, dove spesso a vincere è il più forte, quello che ha preparato lo zaino migliore ecc. Ciò suggerisce che, forse, dovremo fare i conti su quanto e come sia “reazionario” il mito della sopravvivenza alla fine del mondo, e di come forse l’accettazione del nostro destino fragile, del nostro essere una specie tra le altre destinate all’estinzione, sia in realtà un mitologema molto più «progressivo» (uso questo aggettivo nell’accezione che Luporini diede nel suo celebre scritto su Leopardi) che non immaginarci futuri mondi possibili dopo il collasso.
Ciò che mi pare di intuire leggendo questi testi e seguendo il dibattito che ruota intorno a essi è appunto il tentativo di definire una nostra, nel senso di umana, specificità. Quindi non mi sottraggo neppure io: ciò che ci definisce come esseri viventi non è la posizione eretta, o l’uso del pollice opponibile, o il linguaggio, ma l’utilizzo del linguaggio per preconizzare la nostra morte, fine e estinzione.
6. È questa la reale motivazione, che ci affascina e ci spinge verso i novissimi, verso ciò che è ultimo nel nostro vivere e della nostra storia. L’idea stessa che qualcuno di noi – che come noi ha camminato, mangiato, figliato, vissuto una vita sufficientemente felice e piena – abbia un giorno sentito l’idea, il bisogno, e infine abbia prodotto un’immagine di un mondo che andrà avanti senza di noi, che senza di noi infine si spegnerà, ci commuove. Ci turba pensare come questo mondo sensibile sia destinato a esaurirsi nei millenni a venire, e di come nonostante tutto questo la terra continui a produrre bellezza, senso, anzi produca una tale bellezza da costringerci a pensare che dovremmo salvaguardarla, con i suoi animali e ecosistemi, attuando nuove pratiche di vita sociale e in armonia con la natura, illudendoci così che a lungo andare si possa donare al mondo una possibilità di sopravvivere alle apocalissi.
7. Il libro dell’Apocalisse si conclude con un’invocazione che non ha risposta. Questa invocazione è l’explicit del libro, ed è – se vogliamo – la fine della storia: un grido, una richiesta, un’esultanza per qualcosa che non sappiamo se verrà. Al versetto 12 del capitolo 22 dell’Apocalisse si legge: «Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ». La traduzione Cei riporta: «Colui che attesta queste cose dice: “Sì, verrò presto!”. Amen. Vieni, Signore Gesù» o almeno dice questo nel 1971, perché nell’ultima versione 2008 scrive: «Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù». A una lettura disattenta la frase sembra la stessa, con l’unica differenza di quello scambio di verbo da futuro a presente. Questa modifica grammaticale fa in modo che il concetto suoni diverso: il passaggio da “verrò” a “vengo” indica il movimento da una possibilità di avvenimento a qualcosa che è già avvenuto, la forma all’indicativo presente mostra non un evento che deve accadere nel futuro, ma che accade, e quindi nell’accadere è già passato. Letta in questo modo la supplica finale, «Vieni signore», significa, che «L’Apocalisse implica che la paura dell’ultimo respiro sia sciocca» (p. 424), come scrive Alvi nel concludere il suo saggio.
Con questo “vieni”, come un respiro che si spegne, si chiude il Libro, e la chiusura è un circolo perfetto, che ritorna al “in principio”, nel luogo esatto dove tutto era sorto, nel vuoto del inizio, nell’angoscioso nulla cosmico, nel tutto vuoto, dove Dio sta(va) prima della creazione (Gn 1). Quell’ansia, paranoia, disperazione, angoscia, timore di quando le cose che saranno non sono ancora, quel panico è ciò che ci spinge a guardare il futuro; scrutiamo la fine dei tempi, l’apocalisse, la catastrofe (i.e. rivolgimento) perché abbiamo un passato, perché un homo sapiens prima di noi, in un giorno qualsiasi della sua esistenza, ha provato questa paura enorme di non essere niente e ha scritto: “In principio Dio creò…”. Quella sua paura è la nostra.
8. Consapevoli del timore appena descritto, torniamo alla frase di Moretti. E se il compito della letteratura e del romanzo non fosse fare sentire a suo agio nel mondo il lettore, ma fosse l’esatto opposto? La letteratura, credo, deve provocare disagio, far sentire all’uomo che questo mondo che abita non è il suo, che per lui non esiste nulla di certo, che la sua vita è una totale emergenza, un pericolo costante, un male subìto a cui non può sottrarsi. Questo è ciò che la letteratura dovrebbe comunicare. Si apre quindi un grande problema legato al linguaggio, al mezzo che usiamo per dire e raccontare le nostre storie, e mi pare che questo dato non sia mai molto approfondito, quando si parla di apocalisse e/o fine del mondo. Si riflette molto sul cosa dire, si riflette altrettanto sul come, ma si tralascia il medium che si usa, ovvero il linguaggio.
«Sebbene il linguaggio sia totalmente interiore, tuttavia esso possiede anche una presenza autonoma e esterna che esercita una violenza sull’uomo stesso», così Humboldt citato da Stenier in Dopo Babele (p. 114), che così chiosa: «Il linguaggio mette a suo agio l’uomo nel mondo, ma ha anche il potere di alienare» (ibidem).
E se quindi la realtà fosse un luogo inospitale e inabitabile? Forse l’errore di molti scrittori apocalittici sta nel voler descrivere, tramite la finzione, la realtà di questo nostro tempo, dimenticando che «ogni atto di parola ha una potenziale di invenzione, una capacità di iniziare delineare o costruire un’antimateria» (Steiner, p. 277). Costruire un’antimateria, qualcosa che si oppone così profondamente alla hyle da negarla nelle sue fondamenta: la letteratura è questa cosa (potremmo dire pensiero? azione?) che si oppone alla realtà, e che si mette contro, la letteratura non mette chi legge a suo agio, ma pone l’uomo davanti a uno specchio enigmatico, è un gridare Al lupo, al lupo!, quando il lupo non c’è, oppure se anche il lupo ci fosse e fosse ben visibile sarebbe del tutto diverso da quello che le nostre povere parole mortali possono significare.

