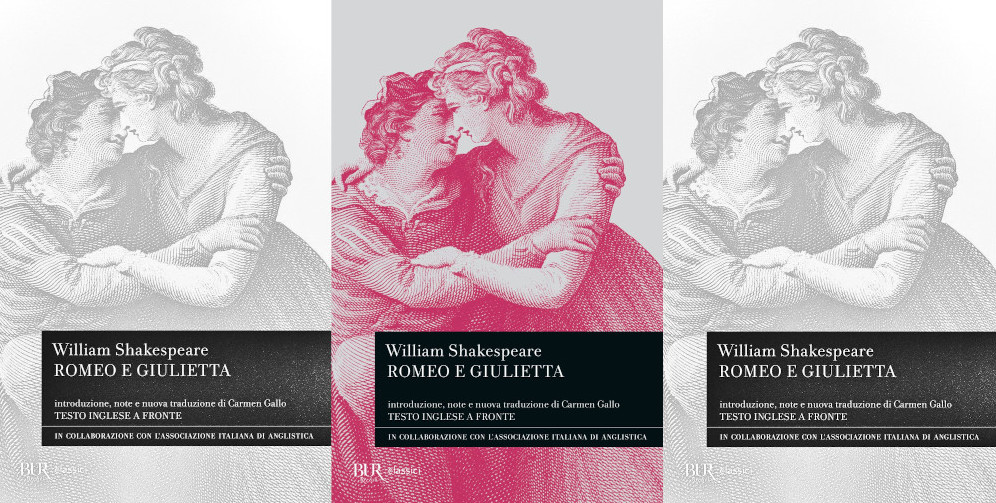Basta grattare un po’ sotto la patina uniformante stesa dall’oleografia romantica e ispessita negli anni da molte trasposizioni del mito proposte dalla pittura, dal balletto, dal cinema e dallo stesso teatro per rendersi conto del fatto che Romeo e Giulietta è un’opera polimorfa. Ancor prima che per l’ibridazione dei registri, a renderla tale è la natura plurima, composita delle fonti e dell’ispirazione: la commedia dell’arte fusa col teatro da camera, la lirica petrarchista e le mistiche vette del canto liturgico commiste al linguaggio basso-corporeo e alla spontaneità orale delle nenie tramandate. E ancora: il profilarsi in queste pagine di un’Italia medievale fantastica confusa con l’Inghilterra elisabettiana reale (sullo sfondo, le guerre di religione), di profonde istanze vitali contrapposte alla mefitica qualità dei tempi (negli anni della stesura del testo Londra era flagellata dalla peste), ma, soprattutto, di una potente amalgama di virtualità libertaria e ineluttabilità autoritaria.
Rispetto a quest’ultimo nodo la metafora dell’oggetto-libro che fila per tutto il dramma risulta davvero illuminante, giacché lascia trasparire la compresenza, talora anche nel breve spazio d’una scena, di opposti che si attraggono e respingono, confrontano e collidono: sete di autentico e maniera, eredità di convenzioni e affinità elettive, dovere di comporre ogni gesto in una rilegatura preordinata e volontà di squadernare il mondo per aprirlo a impensate, ulteriori possibilità vitali.
L’occasione per riscoprire la complessità di Romeo e Giulietta è oggi offerta dall’uscita della traduzione di Carmen Gallo, una delle voci più accreditate della poesia italiana contemporanea. Preceduta da una ricca introduzione e accompagnata da uno stringato ma puntuale apparato di note, la nuova versione della most excellent and lamentable tragedy della letteratura occidentale (Bur, Milano 2023) ha il merito di rendere leggibili, in una lingua e in un ritmo vicini alla sensibilità del lettore/spettatore di oggi, le potenzialità espresse e inespresse di tale polimorfismo lessicale, stilistico, scenico, concettuale.
In una Nota sulla traduzione che precede il testo Gallo dà conto delle sue opzioni formali: ha deciso, spiega, di evitare le forme chiuse – oltre l’86% del componimento è in versi, 1/5 dei quali sono rimati o comunque disposti entro gabbie metriche, al punto che Carla Freccero ha parlato di un sonnet-infested play – «ricorrendo a una serie di espedienti compensativi (fonici, ritmici, retorici) utili a ricostruire su altri livelli la tessitura poetica del linguaggio, secondo una pratica diffusa nella poesia contemporanea» (p. 35). Con duttile intelligenza filologica, storico-critica e performativa – “portabilità” della battuta, cadenza, attenzione all’efficacia scenica delle scelte versali – la traduttrice conferisce modernità alla partitura scespiriana, assorbendo e reinventando nel flusso discorsivo le movenze del sonetto, del blank verse comico e delle altre tipologie di versificazione presenti nell’originale.
Colpisce in particolare un dato, che la studiosa e poetessa ben restituisce nel suo lavoro di trasposizione dall’inglese di fine Cinquecento all’italiano d’oggi, e che opportunamente discute nelle glosse di accompagnamento storico-critico: mi riferisco alla quota di atteggiamenti per così dire gender fluid riscontrabile in alcuni personaggi. È questa un’ulteriore declinazione del polimorfismo di cui si parlava, freudianamente perverso in quanto improduttivo, perturbante.
In Romeo e Giulietta, infatti, come in altri lavori del drammaturgo di Stratford-upon-Avon, a partire dai Sonetti – ben lo ha intuito un altro poeta di valore, Marco Simonelli, riscrivendone alcuni nel suo Will (d’if, Napoli 2009) – si assiste all’assottigliarsi della linea di demarcazione tra i sessi e a un frequente rovesciamento dei ruoli. Dalla scarsa adeguatezza di Romeo rispetto ai modelli di virilità corrente alla “virile” risolutezza di Giulietta, passando per il sogno “androgino” dei due protagonisti, fino all’intercambiabilità delle parti sia nel registro alto dei Capuleti sia in quello basso dei servi, vi sono uomini che assumono, metaforicamente o nella prassi, costumi femminili, e viceversa. Forse che Shakespeare intendesse coltivare (anche) qui il sogno platonico di un ritorno dell’umanità alla sua condizione pre-edenica, bivalente ed ermafrodita?
Il fatto è che una lettura “desiderante” della tragedia sempre più si impone. Osserva Hester Lees-Jefries in un recentissimo saggio apparso sulla prestigiosa “The Review of English Studies” che «the language of Romeo and Juliet might properly be called body language» (l’articolo, significativamente intitolato Body Language: Making Love in Lyric in Romeo and Juliet, si può leggere qui). Nella sua brillante resa dell’originale, Carmen Gallo valorizza proprio questo aspetto così centrale nella poesia, ma direi in generale nell’arte, di oggi, ovvero appunto il tema del corpo, delle sue pulsioni e delle parole per dirlo.
In una società dove il contatto fisico era impedito o comunque fortemente limitato, Romeo e Giulietta è una storia di mani che si cercano – gelide quelle di Mercuzio, calde quelle dell’unico figlio ed erede della famiglia Montecchi – di labbra che s’incontrano, di piedi che danzano di concerto, di pupille dilatate e cuori spremuti.
«I diletti, l’amor, l’opre, gli eventi», per dirla col Leopardi di A Silvia, ossia tutto, ma proprio tutto, in questi ragazzi, parla la lingua dei desideri fisici. Parimenti il piano metateatrale agisce a questo livello, se Shakespeare, da uomo di palcoscenico, oltre che mirabile versificatore, qual è, mira ad accordare la voce lirica ai corpi simpatetici di attori e spettatori, sollecitandone il coinvolgimento giusto tramite il richiamo ai fatti ultimi, intimi e insopprimibili della fisiologia umana.
Il nesso corpo-lingua marca insomma questo prosimetro da ogni punto di vista e sin dalle prime scene, dove un eros di sola parola slitta verso un eros vissuto intus et in cute e che si fa parola solo dopo essersi caricato di valori altri, rinnovati. Questa Vita nova, per quanto effimera, comporta una messa a nudo del regime socio-politico vigente, e di conseguenza l’apertura, per dirla con un fortunato libro di Daniela Brogi, di uno spazio delle donne (Einaudi,Torino 2022) che è luogo espressivo-somatico implicante un altrove (r)et(or)ico alternativo sia all’algido, platonico, discorso sublimante codificato della lirica cortese, sia al parlar grasso fallocentrico di Mercuzio e della balia.
Se ha ragione Anna Rosa Azzone Zweifel nel rilevare come Giulietta sia «l’unico personaggio capace di incarnare un equilibrio possibile, anche se socialmente pericoloso, tra idealizzazione e fisicità» (cito da p. 16 dell’introduzione al volume edito da Marsilio nel 2008, Romeo e Giulietta. Variazioni sul mito), si potrebbe aggiungere che nessuno, a eccezione di lei, possiede un’autentica intelligenza del corpo.
O, meglio, è lei, la saggia tredicenne only child of the rich Capulet a rapidamente maturarla, per poi con-dividerla, come un’Eva liberata, col compagno che si è scelta. Per questo la storia dei due star-crossed lovers veronesi è, anche, il resoconto di un apprendistato, dove l’imporsi sulla scena di Giulietta apre alla precoce conquista di una pedagogia dei fatti ultimi: Eros e Thanatos.
Per dar conto di come Carmen Gallo abbia saputo svestire di ogni paludamento pregresso il focoso cifrario del corpo-lingua, e dare risalto alla fattiva intraprendenza verbale della sposa-bambina (fruta avrebbe detto Pasolini), propongo in conclusione la lettura in parallelo di tre passi. Il primo, tratto dalla scena 2.2, è un esempio di retorica erotica liberata. Qui i corpi degli amanti letteralmente si spogliano di ogni pregiudizio di casata, di ogni convenzione prescritta:
| Romeo, doff thy name,
And for thy name, which is no part of thee, Take all myself. |
Romeo, spogliati del tuo nome,
che non è parte di te, e in cambio del tuo nome, prendi [tutta me. |
Sottolineerei sia l’audacia erotica del verbo adottato, «spogliarsi», sia il “rimare” di «no-me» e «me», dove la decisione di restituire all myself con «tutta me» implica un abbandono totale e senza riserve a colui che si è scelto come amante – laddove c’è da immaginare che Paride, lo sposo imposto dalla famiglia, non avrebbe avuto di lei che a part: il solo nome di moglie, e nient’altro.
Passo al conturbante componimento epitalamico della scena 3.2, celebrativo del momento in cui l’unione viene carnalmente consumata. Con questo participio intendo evidenziare l’aspetto cerimoniale, ovvero sacro, del rapporto sessuale legittimato non già dalle convenzioni, ma dalla passione. Il corpo dell’altra, dell’altro, è manducato, assimilato, quasi in senso eucaristico. L’ardore con cui le due macchine desideranti si fondono è poi anche ciò che le divora, proprio come una candela che brucia da ambo i lati (per citare il celebre motto caro a Rosa Luxemburg).
| Come, civil night,
Thou sober-suited matron all in black, And learn me how to lose a winning match, Played for a pair of stainless maidenhoods. Hood my unmanned blood, bating in my cheeks, With thy black mantle, till strange love grow bold, Think true love acted simple modesty.
|
Vieni, notte austera,
tu, sobria matrona vestita di nero, e insegnami a perdere una partita vincente, giocata da una coppia di vergini senza macchia. Il tuo mantello nero nasconda il sangue che a me, ignara di uomini, accende le guance, finché l’amore inesperto non si farà audace, pensando puro e casto l’atto del vero amore. |
Anche qui, due rilievi: la notte come pronuba/dea santificante il sacrario delle anime gemelle (la retorica erotica connota la liturgia del true love’s rite: embodied word), e insieme cortina che cadendo cela alla vista l’altare deputato al rito (il talamo nuziale); il sangue, “sugo della vita” nella definizione di Camporesi, come presenza agrodolce, allusiva alla deflorazione ma anche al tumulto dei sensi che è il prezzo da pagare a Eros prima, a Thanatos poi.
Traggo infine l’ultimo esempio dal monologo pronunciato da Giulietta allorché, con la mente alterata e in preda a visioni terribili, si accinge a ingurgitare la pozione ammannitale da Frate Lorenzo (4.3):
| O, if I wake, shall I not be distraught,
Environed with all these hideous fears, And madly play with my forefathers’ joints, And pluck the mangled Tybalt from his shroud And, in this rage, with some great kinsman’s bone, As with a club, dash out my desperate brains? |
Oh, se mi sveglio, non potrei perdere la testa,
circondata da tutte queste paure tremende, e giocare impazzita con le ossa dei miei avi, e strappare Tebaldo, straziato, dal suo sudario, e, in un impeto, farmi schizzare via il cervello disperato con l’osso di un grande antenato? |
Quello di Romeo e Giulietta è un death-marked love: Morte reclama i due figli di buona famiglia che hanno trasgredito l’ordine patriarcale (casato/città/stato), rifiutando di farsi intrappolare dalle cadaveriche leggi degli adulti. Si noti appunto il dettaglio infantilizzante del verbo «giocare», connesso alle venerande reliquie degli avi che la ragazzina col suo comportamento ha già profanato.
Come noto, alla fine della tragedia le fattezze dei due pupilli scaligeri saranno monumentalizzate. Il diventare-statua comporta certo la fine della minaccia che il loro disordine sentimentale ha rappresentato: imbozzolati dentro forme auree, non potranno più opporsi al volere dei grandi. Una volta neutralizzato il potere sovversivo del corpo-lingua, la necropolitica che giostra le vite dei giovani con armi luciferine – «tristi» erano definiti Montecchi e Capuleti in Pg. VI, 108 – può star sicura: il suo potere non è stato neppure scalfito.
Eppure, eppure, chiuso il libro, calato il sipario, celebrato Morte il suo trionfo, resta nell’aria qualcosa, l’eco di un ragionar d’amore che ha fatto della disobbedienza una virtù, della tenerezza un’arma politica. E quell’eco, ripetendo il suo gentile, ma fermo, no! a ciò che ripugna alla mente e al cuore, è ciò che conta e che dura.