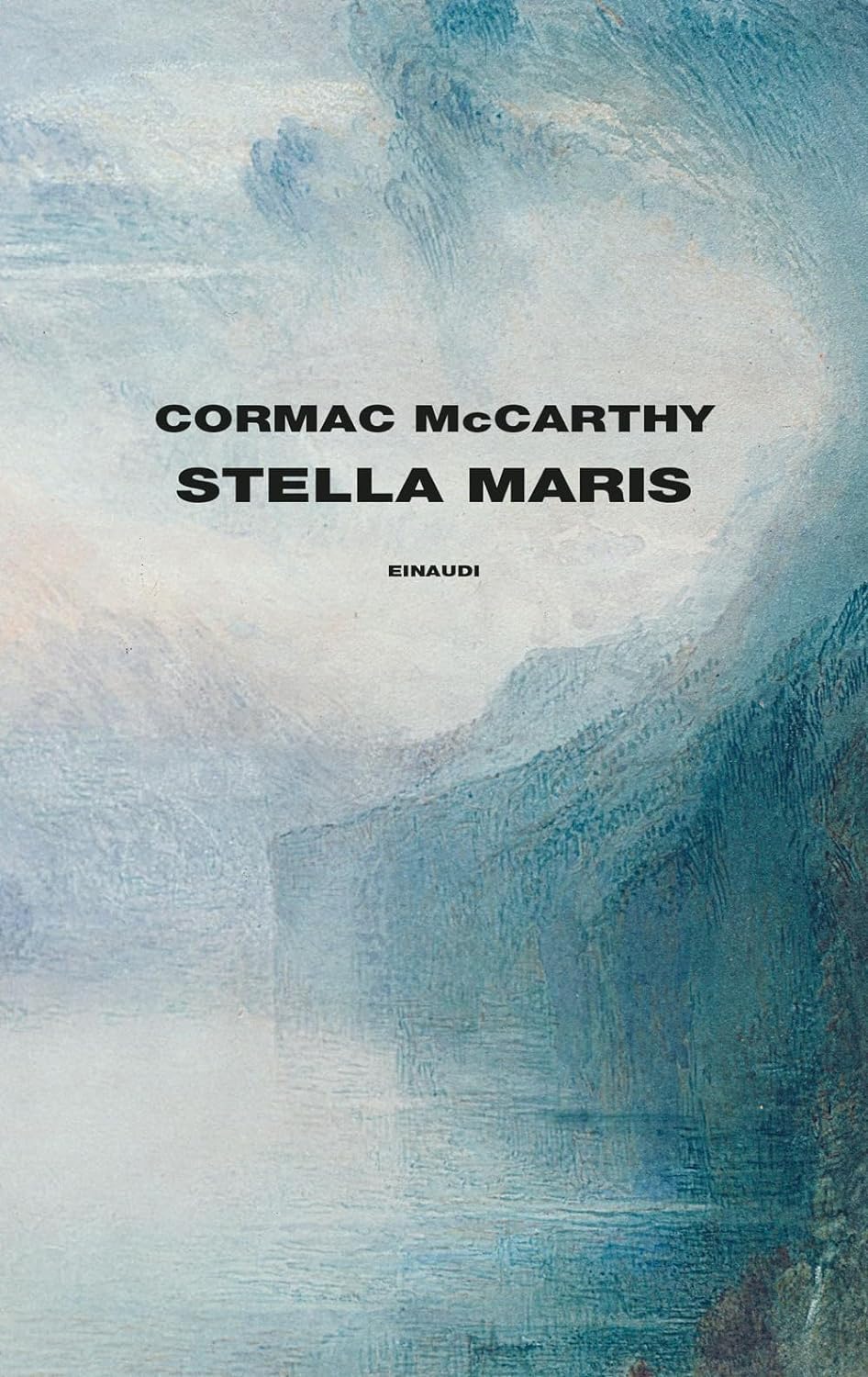Inizio questa riflessione su Stella Maris di Cormac McCarthy (Einaudi, traduzione – splendida – di Maurizia Balmelli) allo stesso modo con cui avevo iniziato il precedente ragionamento su Il passeggero (Einaudi), ovvero sostenendo l’impossibilità di fornire una recensione (il libro è bello? brutto? non se ne può parlare in questi termini, forse) sull’ultima sequenza di questa diade dello scrittore americano. La prima domanda che dobbiamo farci è se Stella Maris sia un romanzo. Possiamo annotare che non sono presenti nelle centonovantacinque pagine, che compongono il testo, descrizioni o didascalie: Stella Maris è un “dialogo” (il motivo per cui è tra virgolette sarà chiaro a fine riflessione) tra Alicia e lo psicologo, che avviene in sette sedute, a partire dall’ottobre del 1972. L’unico momento diegetico sta nel paratesto, nel quale viene riportato il quadro clinico della paziente corredata con un’immagine sfocata dell’esterno dell’edificio che la ospita, accompagnato con i dati minimi per ubicarlo e situarlo temporalmente. Del resto non sappiamo nulla: di come sia la stanza che ospita i colloqui, quali vestiti che indossino Alicia e il dottore; certo, ci sono brevi cenni o immagini legate alla cura o incuria del vestire della paziente, e ci sono alcune battute di dialogo didascaliche, perché indicano un’azione di uno dei due personaggi – il tremare delle mani, il mettersi a piangere o l’alzarsi per preparare un the. Anche il tempo all’interno di dialoghi è assente, se si escludono alcune battute in cui lo psichiatra chiede alla paziente se desideri fare una pausa; in questo romanzo McCarthy abolisce, quindi, la dimensione spaziale e temporale del racconto, ovvero la “spina dorsale” di ogni narrazione.
La forma romanzo potrebbe essere descritta come il racconto della storia di un personaggio all’interno di determinato tempo e un determinato luogo; Stella Maris non pare essere un romanzo, dato che McCarthy fa in modo che tutto si riduca a dialogo. E allora viene da chiedersi: potrebbe essere un testo/una pièce teatrale? Ora, il dialogo prevede la esatta coincidenza del tempo della storia e del tempo della narrazione: stiamo ad ascoltare due persone che, nel momento in cui le leggiamo, stanno parlando. I dialoghi tra Alicia e il suo dottore, però, non hanno nulla di mimetico, non c’è in essi alcun richiamo al parlato: non ci sono i tentennamenti, gli sbuffi, le ripetizioni e gli indugi tipici dell’espressione orale, che possiamo ravvisare ascoltando una nostra registrazione audio. I dialoghi in Stella Maris non hanno nulla, quindi, della messa in scena drammatica, perché l’autore non segnala i respiri, le esitazioni, i tentennamenti. I due personaggi sono due emittenti: la loro voce non è mai dubbiosa, non torna mai su sé stessa, è chiara, logica, sempre perfettamente coerente con quello che sta dicendo, organizzata come se fosse scritta.
Quindi Stella Maris non pare essere neppure teatro, mancando appunto di gesti, didascalie, toni, sospensioni (sono quasi del tutto assenti i tre puntini, ad esempio). Stella Maris è il culmine di un processo di abbandono della forma narrativa, che si poteva già ravvisare abbastanza chiaramente ne Il passeggero, e che qui, appunto, è portato alle estreme conseguenze.
Ciò che è più vicino all’idea costitutiva di Stella Maris sono i dialoghi platonici, quasi che McCarthy, giunto ormai al limite della sua esistenza terrena e della sua opera letteraria, facesse a meno della letteratura, dell’invenzione, e aspirasse in qualche modo alla contemplazione assoluta e astratta delle cose. Si ritorna alla vecchia condanna platonica dell’arte poetica, della narrazione, che è declinata perfettamente in Repubblica: esiste una idea di seggiola, che filosofo contempla nella sua purezza, di seguito c’è il falegname che costruisce una seggiola, e infine, buon ultimo verrebbe da dire, c’è il narratore che immagina una seggiola su cui si siedono i personaggi in una seduta psichiatrica. La letteratura, la finzione, sono questo ultimo e più degradato passaggio dalla idea alle cose concrete (anzi, la letteratura sarebbe un’immagine non già della cosa in sé, ma una descrizione della cosa nella realtà, che è appunto una degradazione rispetto all’assoluto delle idee).
Si ha l’impressione, leggendo, che le cose concrete siano sparite dalla pagina di McCarthy. Lo scrittore americano cerca in qualche modo di produrre un testo che faccia a meno della letteratura e del linguaggio letterario. Ecco perché a dominare queste pagine è la speculazione matematica, perché essa è una sfera della conoscenza dell’uomo che si oppone a qualsiasi esperienza concreta, come bene esemplifica Alicia: «Dal canto mio io non ho mai visto un sei» (p.183) o anche «Se moltiplicassi due pomodori per due pomodori non otterrei 4 pomodori. Otterrei quattro pomodori in quadrato. Quindi cos’è il due. Be’. È un operatore matematico astratto indipendente» (p.137).
Cosa sono il sei o il due, cosa indicano sei o due? Sono quantità, ma quale quantità è sei, è c’è differenza tra sei e 6? La riflessione sul linguaggio e la matematica, già presente ne Il passeggero, in queste pagine diventa totale: nel racconto di Alicia la scoperta del linguaggio è simile a un’invasione, un virus, che non arricchisce l’uomo, ma lo impoverisce: «Ma bisogna capire cos’è stato l’avvento del linguaggio. Per un bel po’ di milioni di anni il cervello se l’era cavata piuttosto bene senza. L’arrivo del linguaggio è stato come l’invasione di un sistema parassitario» (p. 177); per l’uomo il linguaggio è stato qualcosa di devastante: «Molto devastante. Proporzionalmente alla sua rilevanza. Distruzione creativa. Sono certamente andati persi talenti e abilità di ogni tipo. Perlopiù comunicativi» (p.178).
Il mondo, secondo Alicia, corrisponde (esiste), wittgensteinamente, a «quello che se ne può dire» (p.179). Il mondo viene ridotto a linguaggio, e può essere spiegato solo attraverso esso (il linguaggio per essere raccontato, spiegato finanche confutato ha bisogno del linguaggio, cosa che invece non è necessaria per la pittura – si può descrivere un quadro –, un brano musicale o una foto); l’uomo ha bisogno del linguaggio per capire il mondo, ma così facendo si nega all’accesso al reale e sceglie l’astratto: «Il punto è che centomila anni fa qualcuno è saltato su nel letto in veste da camera e ha detto Porca merda. Si fa per dire. Ancora non possedeva un linguaggio. Ma quello che aveva appena capito era che una cosa può esserne un’altra. Non somigliarle o agirla. Esserla. Incarnarla. I ciottoli possono essere capre. I suoni possono essere cose» (p. 137).
Lo sguardo di Alicia, e il nostro con lei, quindi, scruta nei sette capitoli del libro la radice e l’origine del tutto, quando il mondo non era contaminato dal linguaggio. Non è casuale come Stella Maris sia suddivisa in sette dialoghi quanti i giorni della creazione in Genesi: la creazione nelle Bibbia, almeno quella di Gn 1, ha a che fare con il linguaggio. Contrariamente ad altre cosmogonie, molto più concrete e materiali, lo Javista sostiene che Dio crea tramite la parola, tramite il linguaggio: non impasta niente, non cuoce niente, non prende fango o poltiglia spaziale o materia nera dal nulla intorno a Lui, ma semplicemente emette parola, che produce il fenomeno: sia la luce e la luce fu. Il desiderio di Alicia è quello di riportare il suo sguardo, la sua comprensione del mondo a quegli instanti scaturenti, ai momenti fondativi del mondo e della nostra civiltà, tanto che il brano prima citato così continua: «Il nome dell’acqua è acqua. Quello che a noi sembra irrilevante in virtù dell’abitudine è in realtà il concetto fondativo della civiltà» (p. 137).
Se il mondo viene così creato, in che modo l’uomo lo abita, e lentamente ne prende possesso? Per provare a rispondere a queste domande dobbiamo approfondire il tema dell’incesto, dell’amore tra i due fratelli. La storia d’amore tra Alicia e Bobby è, nel corso dei due romanzi, una relazione negata, immaginata, un rapporto mai consumato, sempre spostato su di un piano onirico, lontano dalla concretezza: un desiderio che rimane tale. Bobby in Stella Maris è silente, lontano, comatoso nel nulla che lo tiene tra la vita e la morte; egli viene evocato molte volte, con una certa insistenza, dal terapeuta, ma Alicia nega, non risponde, svia e solo alla fine deve ammettere e dichiarare il suo amore, il suo primigenio e unico amore, l’unico e possibile desiderio sessuale, di pienezza e di compimento, che ha come protagonista il proprio fratello. Alicia, quindi, immagina questo atto e la sua consumazione fisica (l’amore se è tale deve essere eros, deve essere sesso), ma è consapevole che già il descriverlo pone lei e Bobby fuori dal contesto sociale; li condanna a essere paria, capri espiatori. Eppure, viene da sostenere una volta finito il libro, è proprio tale turbamento che dobbiamo guardare, perché esso dice qualcosa di noi, di come fummo all’inizio, prima del linguaggio, prima del pensiero razionale, e getta uno sguardo sulla nostra preistoria e sui primordi della nostra socialità: l’incesto è la prima apparizione di Eros. Infatti, se «dapprincipio c’era il Caos» (Esiodo, Teogonia, Mondadori, trad. E. Cingano, E. Vasta), è «Eros, il più bello tra gli dei immortali» (ivi) a spingere Gea a unirsi a Urano, e tale unione produce una genealogia di dei, che a loro volta si uniscono e generano tra di loro, facendo sì che tale tabù sia il motore primordiale del mondo.
Alicia, infine, perduta al mondo così come è, inseguita dai suoi fantasmi e operatori schizofrenici, arriva alla fine del tempo che è il suo inizio, dove linguaggio, società, civiltà, musica, arte, bellezza perdono di significato; in cui l’idea di vita terrena o di suicidio (bellissime le pagine in cui Alicia immagina la sofferenza di un corpo che si lascia morire in lago ghiacciato) non sono altro che un’altra modalità di «non essere io» (p.193). Rifiutato lo stadio del linguaggio (l’abbandono della speculazione matematica), compresa l’impossibilità di vivere prima della nascita della civiltà (il veto ad amare fisicamente Bobby), Alicia decide di negare sé stessa, immagina di addentrarsi nel folto bosco di una montagna, di pregare per «poter vedere la verità del mondo prima di morire» (p.194). E così, non appena il fuoco si spegnerà (non è causale, perché ne ribalta l’immagine, il riferimento all’altro grande romanzo di McCarthy, La strada), Alicia sarà eucarestia degli animali selvatici (p. 194). Il viaggio dell’uomo, di ogni essere umano, si conclude nel silenzio musicale di un bosco («avrebbe avuto il sapore della musica», p.194), nel mistero dell’offerta e nella rinuncia di sé.