
Metamorfosi e identità
In Alice nel paese delle meraviglie. Attraverso lo specchio – siamo nel capitolo V – il bruco chiede alla protagonista: «Chi sei tu?». A questa domanda, apparentemente semplice, Alice risponde così: «Io… in questo momento non lo so bene signore… per lo meno, so chi ero quando mi sono alzata questa mattina, ma penso che, da allora, io sia cambiata più di una volta». Il dialogo pone una particolare attenzione ai termini che indicano identità, che Carrol sottolinea con l’uso del corsivo; andando avanti leggo questo dialogo, che riporto, nella traduzione di Luca Manini (Bompiani):
“Temo di non riuscire a spiegarmi, signore,” disse Alice, “perché non sono me stessa, vedete”
“Non vedo,” disse il Bruco.
“Temo di non riuscire a dirlo in modo più chiaro,” rispose Alice, molto educatamente, “perché, tanto per cominciare, non riesco a capirlo nemmeno io, e a cambiare così spesso dimensione in un giorno solo è una cosa che confonde molto”.
“Non lo è,” disse il Bruco.
“Be’, forse non l’avete ancora sperimentato,” disse Alice; “ma quando vi dovrete trasformare in una crisalide… e un giorno accadrà, lo sapete bene… e poi, dopo di ciò, in una farfalla, penso che proverete una sensazione piuttosto strana… o no?”
“Assolutamente no,” disse il Bruco.
“Be’, forse le vostre sensazioni saranno diverse” disse Alice; “quello che io so è che, a me, sembrerebbe tutto molto strano.”
“A te!” disse il bruco con disprezzo. “E chi sei tu?”
Questo scambio di battute pone al centro la questione dell’identità, che Alice fatica a trovare, date le sue diverse e molteplici trasformazioni dovute ai suoi mutamenti di altezza; il bruco, che continua, con monotona cantilena, a chiedere alla ragazza «Chi sei», pone la domanda per eccellenza della narrativa e del romanzo, ovvero la domanda di identità: «Cosa è un individuo? In che cosa consiste la sua identità? Tutti i romanzi cercano di dare una risposta a queste domande. E in effetti, che cos’è che definisce un io?» (M. Kundera, I testamenti traditi, trad. M. Daverio, Adelphi). Va anche sottolineato come a porre tale interrogativo identitario sia il bruco che, come giustamente nota Alice, è il simbolo del cambiamento, del passaggio da uno stato all’altro dell’essere. Il bruco metafora del cambiamento chiede una definizione certa di “chi uno è”.
A una prima lettura questa scelta potrebbe apparire uno dei tanti giochi linguistici del racconto di Carrol, ma provo a guardarlo con un occhio diverso, soffermando l’attenzione sul bruco e non sulla giovane Alice.
E quindi: Perché è il bruco a porre la domanda identitaria? La risposta che posso darvi è che il bruco, proprio per il suo destino di metamorfosi, di cambiamento e trasformazione, conosce la labilità e la complessità dei confini dell’io: il suo stato attuale non è che un passaggio verso qualcos’altro; e, quindi, chiede e domanda perché sa lo smarrimento di Alice. Per conoscere chi realmente siamo dobbiamo comprendere quanto l’identità, l’identificarsi con qualcosa di preciso e dato, sia impoverente, mentre l’immaginare di essere altro da sé, di trasformarsi in altro da quello che siamo, ci consente di scoprire nuove possibilità.
Metamorfosi e abitare il mondo
Ne Il libro delle metamorfosi (Moscabianca edizioni, trad. Lucrezia Pei), Jean-Baptiste de Panafieu, grazie ai disegni di Camille Renversade, racconta e narra diversi tipi di metamorfosi, letterarie e scientifiche. Il mondo, sembrano suggerirci gli autori, questo mondo che abitiamo è per sua definizione metamorfico e cangiante: fare esperienza del cambiamento è fare esperienza del mondo, è sentirsene parte:
Tutti abbiamo sognato almeno una volta di avere un corpo diverso, più possente, più capace o bello, o persino di un altro sesso. Chi non è mai immaginato trasformato in uccello, in delfino o in cavallo? […] Grazie alla metamorfosi si sfugge alla propria vita per trovarne una nuova. Si valica un confine che permette di percepire il mondo in maniera diversa. […] Cambiare la nostra natura significa anche riconoscere che facciamo parte dello stesso universo, dello stesso mondo vivente. L’animale è altro da noi, ma prenderne la forma presuppone che ci sia qualcosa che ci lega.
Questo dato esperienziale è interessante: il racconto della metamorfosi non è tanto dato dal virtuosismo in sé, dall’abilità degli artisti di mostrare questa modificazione in atto – penso ad Apollo e Dafne di Bernini o a Ingela Ihrman, The Passion Flower per prendere due esempi nella scultura distanti nel tempo – quanto dall’esperienza che questo cambiamento produce in noi e nella nostra psiche: la metamorfosi, quindi, non si risolve nel dato descrittivo, ma nell’esperienza di stare nel mondo. Il mutare della forma è, quindi, prima di tutto un dato sapienziale e solo successivamente un dato formale: nella vicenda di Tiresia, che diventa donna, è centrale non tanto per la sua trasformazione nell’altro sesso, quanto per l’aumento di sapere e di conoscenza e di consapevolezza che questo nuovo sé porta in dono (ovviamente si potrebbero fare altri esempi di questo tipo, infatti qualcosa di simile avviene in Apuleio o nella trasformazione orrenda e grottesca di Lucignolo in asino in Pinocchio).
 Parlare della metamorfosi, di certo, ha a che fare con il fantastico e il meraviglioso, o meglio ancora con il soprannaturale, con qualcosa – quindi – che eccede la natura, che la avvolge e la sovrasta. Da qui la spinta ovidiana nell’incipit del suo poema: «In nova fert animus mutatas dicere formas/corpora»: il corpo cambia forma, si muove verso un territorio inesplorato e incognito, è una vera e propria rottura di ciò che abbiamo davanti agli occhi. Tale frattura lo si può notare anche dall’organizzazione del verso, nel quale Ovidio fa di tutto per allontanare “nova” e “corpora” grazie all’iperbato e all’enjambement, isolandoli nella loro assolutezza. La metamorfosi è esperienza di una novità, che è insita in noi, ma che noi non comprendiamo. In questo senso le tavole disegnate da Renversade ne Il libro delle metamorfosi sono, oltre che belle, suggestive, perché mettono in risalto come a livello anatomico il corpo umano possa diventare altro da sé; questo dettaglio anatomico produce una sorta di sovrasenso, di immaginazione, come se l’artista suggerisse che dentro di noi, nascosto nel profondo, ci sia un qualcosa, un seme, una traccia della nostra appartenenza non soltanto alla specie umana, ma a quella animale, via via fino al semplice organismo unicellulare: il nostro corpo contiene in sé la memoria geologica di ciò che siamo stati, di ciò che la vita è stata da quando è apparsa, e quindi la metamorfosi sarebbe tanto un viaggio in avanti, un cambiamento, quanto un viaggio a ritroso all’interno di noi stessi, alle nostre radici, non tanto alle nostre radici di umane, ma se vogliamo di pura esistenza e vita. Si intravede qui, appena accennato, il fatto che la metamorfosi ha a che fare con la nostalgia.
Parlare della metamorfosi, di certo, ha a che fare con il fantastico e il meraviglioso, o meglio ancora con il soprannaturale, con qualcosa – quindi – che eccede la natura, che la avvolge e la sovrasta. Da qui la spinta ovidiana nell’incipit del suo poema: «In nova fert animus mutatas dicere formas/corpora»: il corpo cambia forma, si muove verso un territorio inesplorato e incognito, è una vera e propria rottura di ciò che abbiamo davanti agli occhi. Tale frattura lo si può notare anche dall’organizzazione del verso, nel quale Ovidio fa di tutto per allontanare “nova” e “corpora” grazie all’iperbato e all’enjambement, isolandoli nella loro assolutezza. La metamorfosi è esperienza di una novità, che è insita in noi, ma che noi non comprendiamo. In questo senso le tavole disegnate da Renversade ne Il libro delle metamorfosi sono, oltre che belle, suggestive, perché mettono in risalto come a livello anatomico il corpo umano possa diventare altro da sé; questo dettaglio anatomico produce una sorta di sovrasenso, di immaginazione, come se l’artista suggerisse che dentro di noi, nascosto nel profondo, ci sia un qualcosa, un seme, una traccia della nostra appartenenza non soltanto alla specie umana, ma a quella animale, via via fino al semplice organismo unicellulare: il nostro corpo contiene in sé la memoria geologica di ciò che siamo stati, di ciò che la vita è stata da quando è apparsa, e quindi la metamorfosi sarebbe tanto un viaggio in avanti, un cambiamento, quanto un viaggio a ritroso all’interno di noi stessi, alle nostre radici, non tanto alle nostre radici di umane, ma se vogliamo di pura esistenza e vita. Si intravede qui, appena accennato, il fatto che la metamorfosi ha a che fare con la nostalgia.
Essere come un albero
Certo, trasformarsi in un leone, in un orso, puranche in una tigre o lupo è inquietante, ma in un certo senso è un passaggio da “vivente” a “vivente”, e in tali frangenti siamo ancora nel regno del comune, se non dell’identico. Il passaggio da essere umano a vegetale è invece tra le varie tipologie di metamorfosi una delle più inquietanti. In questo caso non si dà solo un cambiamento di forma –– dove c’era una bocca ora vedo un becco, invece delle unghie artigli – ma avviene qualcosa di più profondo: l’essere umano che si fa pianta, arbusto, albero, foglia quasi cedesse una sua parte di esistenza, come se ne privasse e andasse a occupare uno spazio vivente nuovo e diverso, come se esistesse una vita umana e più in basso, più oscura, una vita vivente, che in qualche modo precede la nostra comprensione, la nostra conoscenza e consapevolezza: esiste quindi, e la metamorfosi vegetale lo mostra, uno stato in cui noi partecipavamo a una vita, che pur non essendo ancora quella che noi chiamiamo vita ci definisce.
A venirmi in soccorso è Omero. Nell’Iliade si intravede – anche se questo è un dato molto grossolano, spero che la semplificazione non infici troppo il ragionamento – una struttura linguistica che pare ricorrente; durante le grandi rappresentazioni delle battaglie, esistono sostanzialmente due ordini di similitudini: la prima riguarda il regno animale (come leoni, cinghiali, cani ecc.) e la seconda il regno vegetale (come piante, come grano, fiori, foglie ecc.). Omero fa ricorso alla prima similitudine per descrivere i guerrieri che si lanciano all’attacco, mentre con la seconda sigilla la descrizione della loro morte, questa alternanza non può essere casuale, ma ha un preciso intento nel sistema di valori che il poema omerico individua. L’uomo, o meglio l’essere umano, nel pieno della sua esistenza quando fa le cose, combatte, vive, mangia, gioca, abbraccia la moglie, fa l’amore, s’adira, vive una sorta di esistenza animale, e Omero, quindi, per descriverlo nel momento della maggiore vitalità, che è la guerra – la guerra per il poeta è bellezza – utilizza l’immaginario animale. Esiste, però, una modalità di vita che si fonda sul mutare delle stagioni, sullo sfiorire e il rifiorire, sul ciclo incessante del tempo che torna, e che è tipico delle piante. Quando l’uomo viene ucciso non perde tutta la vita, perde soltanto una parte – una qualità –, quella animale della sua vita, ma l’altra, quella vegetale, rimane intatta: come se morendo il guerriero non morisse all’esistente ma tornasse a essere simile alle cose di natura ai sassi, alle piante, ai fiori, ai semi. Ecco quindi la similitudine vegetale: per Omero non moriamo, ma ritorniamo ad appartenere al ciclo vegetativo della terra, torniamo a essere una parte del ciclo della fotosintesi.
 Il legame tra la nostra condizione umana e quella vegetale è misterioso e terribile, quasi che quest’ultima indicasse come fine ultimo la rinuncia all’umano, l’annuncio di una vita che non è vita umana, non è vita senziente, ma è semplicemente esistere. Nel suo saggio L’impensato, Katherine N. Hayles si pone costantemente tale interrogativo: è possibile una condizione esistente che non sia per forza cosciente? È necessario essere coscienti, consapevoli per esistere? (e già nella recensione al saggio avevo trovato proprio su questo tema strana l’assenza del dispositivo metamorfico). Alle urgenti e fondamentali domande di Hayles viene in soccorso, in un certo qual modo, l’immagine della metamorfosi vegetale: il trasformarsi in piante sembra suggerire che più antica della vita dell’uomo, più antico dell’alito di Dio che crea Adamo e Eva, esista qualcos’altro, una vita assoluta, completamente nuda (per usare un termine filosofico), che è il centro irradiante di uno dei romanzi più interessanti e misteriosi degli ultimi anni ovvero La vegetariana della scrittrice sudcoreana Han Kang (trad. Milena Zemira Ciccimara, Adelphi).
Il legame tra la nostra condizione umana e quella vegetale è misterioso e terribile, quasi che quest’ultima indicasse come fine ultimo la rinuncia all’umano, l’annuncio di una vita che non è vita umana, non è vita senziente, ma è semplicemente esistere. Nel suo saggio L’impensato, Katherine N. Hayles si pone costantemente tale interrogativo: è possibile una condizione esistente che non sia per forza cosciente? È necessario essere coscienti, consapevoli per esistere? (e già nella recensione al saggio avevo trovato proprio su questo tema strana l’assenza del dispositivo metamorfico). Alle urgenti e fondamentali domande di Hayles viene in soccorso, in un certo qual modo, l’immagine della metamorfosi vegetale: il trasformarsi in piante sembra suggerire che più antica della vita dell’uomo, più antico dell’alito di Dio che crea Adamo e Eva, esista qualcos’altro, una vita assoluta, completamente nuda (per usare un termine filosofico), che è il centro irradiante di uno dei romanzi più interessanti e misteriosi degli ultimi anni ovvero La vegetariana della scrittrice sudcoreana Han Kang (trad. Milena Zemira Ciccimara, Adelphi).
Essere come un albero
Il centro del romanzo riguarda Yeong-hye, una donna che, dopo una notte agitata da un sogno (Kafka?), smette di mangiare carne: questa sua scelta la trasforma, e il romanzo è una narrazione che vede come momento apicale la rinuncia all’umano, come quando nelle prime pagine vediamo la protagonista non fare più sesso con suo marito, perché il corpo dell’uomo «puzza di carne».
Il cambiamento radicale avviene per gradi, proprio come nelle metamorfosi: dopo la rinuncia della carne, la protagonista vivrà una nuova fase di cambiamento, quando il marito di sua sorella, un artista in crisi alla perenne ricerca di ispirazione, le proporrà di posare per una sua video installazione con il corpo nudo completamente dipinto di fiori. Tale immagine è la prefigurazione della metamorfosi vera e propria: qui la protagonista, per la prima volta, avverte qualcosa di nuovo, comprende sé stessa in ciò che sta mutando in lei, e desidera che quei fiori non si cancellino dal suo corpo.
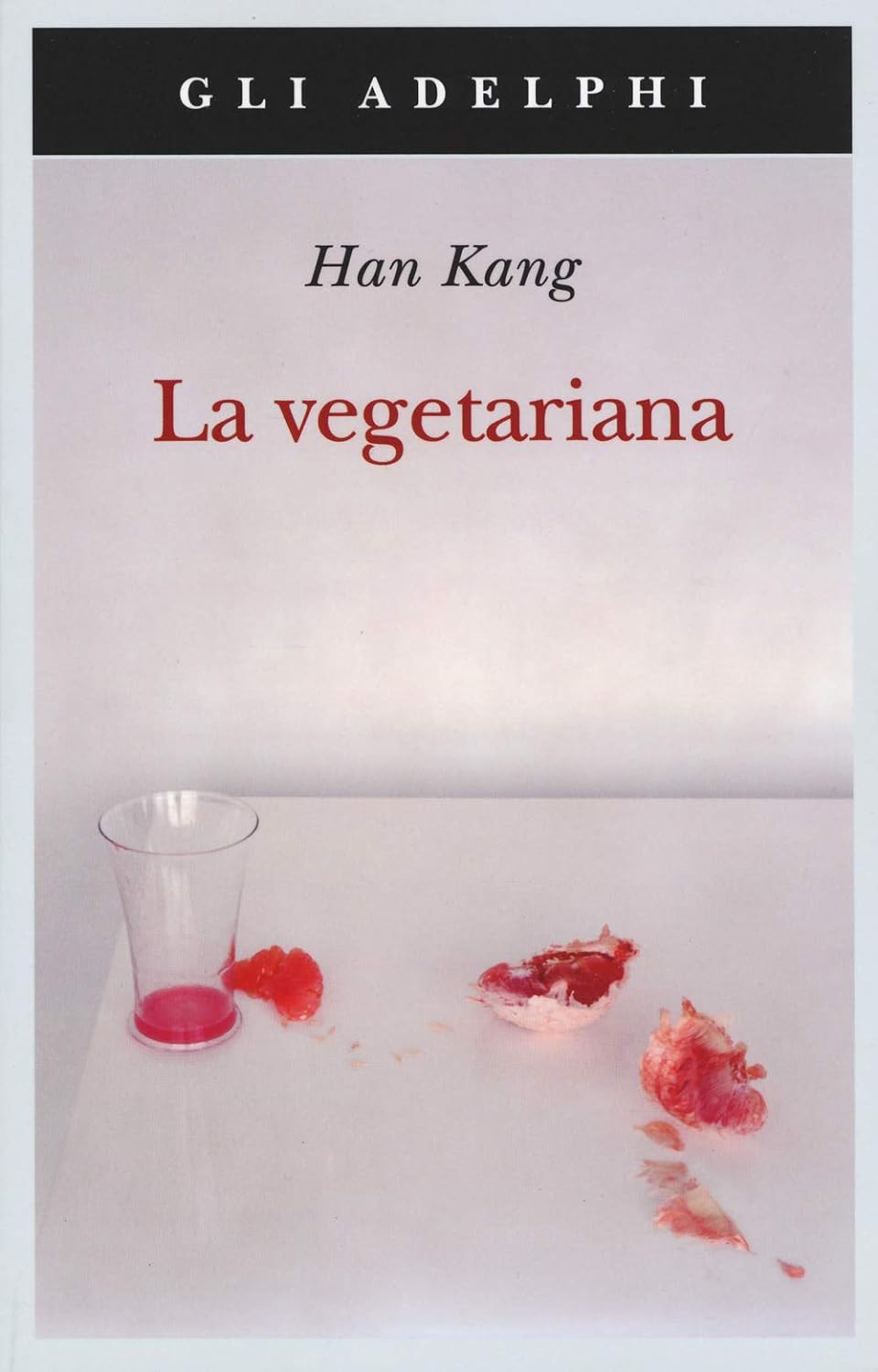 Leggendo il romanzo, si comprende che la sua scelta di non mangiare carne è segno di una trasformazione, di una comprensione intima di quel mondo vegetale che ci sfugge alla razionalità: «Sorella… tutti gli alberi del mondo sono come fratelli e sorelle». La sua metamorfosi non ha nulla di fantastico o di immaginifico, ma è concreta, reale, anzi secondo i medici è una forma acuta di anoressia, aggravata da una serie di disturbi psicologici. È questo un dato di differenza rispetto ai modelli classici ovidiani e non solo, anzi in ragione di questa la privazione del dato di eccentricità o di fantastico, l’atteggiamento della protagonista diventa più rivelatore e inquietante. Ad esempio alla sorella, che andandola a visitare in una clinica psichiatrica dove è ricoverata, la scorge a “fare la verticale”, Yeong-hye si rivolge così: «Io non lo sapevo. Pensavo che gli alberi stessero a testa in su… L’ho scoperto solo adesso. In realtà stanno con entrambe le braccia nella terra, tutti quanti». E infine aggiunge: «Devo dare acqua al mio corpo. Non ho bisogno di questo genere di cibo, sorella. Ho bisogno di acqua».
Leggendo il romanzo, si comprende che la sua scelta di non mangiare carne è segno di una trasformazione, di una comprensione intima di quel mondo vegetale che ci sfugge alla razionalità: «Sorella… tutti gli alberi del mondo sono come fratelli e sorelle». La sua metamorfosi non ha nulla di fantastico o di immaginifico, ma è concreta, reale, anzi secondo i medici è una forma acuta di anoressia, aggravata da una serie di disturbi psicologici. È questo un dato di differenza rispetto ai modelli classici ovidiani e non solo, anzi in ragione di questa la privazione del dato di eccentricità o di fantastico, l’atteggiamento della protagonista diventa più rivelatore e inquietante. Ad esempio alla sorella, che andandola a visitare in una clinica psichiatrica dove è ricoverata, la scorge a “fare la verticale”, Yeong-hye si rivolge così: «Io non lo sapevo. Pensavo che gli alberi stessero a testa in su… L’ho scoperto solo adesso. In realtà stanno con entrambe le braccia nella terra, tutti quanti». E infine aggiunge: «Devo dare acqua al mio corpo. Non ho bisogno di questo genere di cibo, sorella. Ho bisogno di acqua».
Queste battute, tratte dall’ultima delle tre parti in cui è diviso il romanzo, mostrano il processo conclusivo della metamorfosi: la trasformazione della protagonista, nata da uno scrupolo morale, diventa metafisica perché agli occhi è una volontaria scelta di morte. Io guardo questo personaggio con occhi che “odorano” di carne, penso che lei voglia morire, ma Yeong-hye, e Kang con lei, mi spiazza: «Dicono che le mie viscere si sono tutte atrofizzate, lo sai? […] Non sono più un animale, sorella. Non ho bisogno di mangiare, non più. Posso vivere senza. Ho bisogno soltanto del sole».
Yeong-hye vuole diventare un albero, nei suoi movimenti: l’anoressia, il silenzio, l’estraneità al mondo rivedo la tensione presente in certe mistiche e sante anoressiche, capaci di non nutrirsi per mesi. Il mistico non ha paura di “indiarsi”, di diventare tutt’uno con il dio, quale che esso sia: il dio de La vegetariana è la natura, così Yeong-hye non ha paura di “diventare albero”, lo desidera fortemente, perché essa – infine – è libera da ogni cosa, come gli alberi, è libera dal vivere animale, ha rinunciato all’umano, e rinunciando all’umano si affranca dalla morte. Così, quando la sorella le urla: «Se faccio così, è perché ho paura che tu muoia», Yeong-hye risponde: «Perché, è così terribile morire?».
Agli occhi dell’uomo la morte è un male irrimediabile, ma l’albero non muore, non sente la terribilità del morire, perché fa parte di un ciclo vegetativo, che prevede la rinascita. Una nuova sapienza è possibile per Yeong-hye perché attinge a qualcosa di incognito, precedente all’uomo, a un luogo in cui il ciclo della vita e della morte, il lutto, la perdita, la salvezza afferiscono a qualcosa di diverso: è la salvezza della materia, della fotosintesi clorofilliana, del ciclo delle stagioni, dell’omeostasi, perché «è totalmente concentrata su qualcosa, o qualche luogo, da non essere consapevole dell’immediato ambiente circostante». Solo comprendendo tale tensione la sorella può finalmente vedere, e ogni lettore con lei, come tutto questo muoversi, questo rinunciare al cibo, alle cure, abbia come unico scopo il “liberarsi dell’umano”.
La metamorfosi e la nostalgia
 Lutto, metamorfosi e forma vegetale sono centrali anche nel bellissimo romanzo di Sheila Heti Colore puro (trad. Federica Aceto, Il Saggiatore), la terza parte del romanzo è, difatti, dominata da un’immaginazione metamorfica che colpisce la protagonista dopo la morte del padre. Mira, così disperata per la morte del suo genitore, finisce per dissolversi e trovare rifugio in una foglia di un albero che dà sul lago: «Bisogna avere un desiderio segreto che ti facesse arrivare dove volevi. Anche lei aveva un desiderio segreto, ma era stato talmente segreto che non sapeva quali sarebbero state le parole per esprimerlo». Ancora una volta il dato vegetale attinge a qualcosa di così nascosto che quasi sfugge alla comprensione della protagonista: conosce questo segreto ma non sa come formularlo verbalmente. La protagonista, in questa trasformazione, trova la sua giusta dimensione: «Non sapeva nemmeno quali fossero le sue giuste dimensioni, Ma lì, sotto il sole dorato, finalmente l’aveva scoperto: erano le dimensioni di una foglia». Tale trasformazione mostra un modo di diverso adesso, meno antropomorfizzato di vedere la terra e la sua creazione: «Nel paesaggio cosmico le piante hanno un posto in prima fila. Dio è entusiasta del fatto che il pubblico della creazione sia interamente composto di piante: alberi e cespugli, fiori e bacche tutti seduti a godersi lo spettacolo […]. Che privilegio poter star lì comodi a guardarla! Essere riempiti interamente della bellezza della vita! […]. Non è stato mica facile per le piante imparare a starsene sedute buone buone».
Lutto, metamorfosi e forma vegetale sono centrali anche nel bellissimo romanzo di Sheila Heti Colore puro (trad. Federica Aceto, Il Saggiatore), la terza parte del romanzo è, difatti, dominata da un’immaginazione metamorfica che colpisce la protagonista dopo la morte del padre. Mira, così disperata per la morte del suo genitore, finisce per dissolversi e trovare rifugio in una foglia di un albero che dà sul lago: «Bisogna avere un desiderio segreto che ti facesse arrivare dove volevi. Anche lei aveva un desiderio segreto, ma era stato talmente segreto che non sapeva quali sarebbero state le parole per esprimerlo». Ancora una volta il dato vegetale attinge a qualcosa di così nascosto che quasi sfugge alla comprensione della protagonista: conosce questo segreto ma non sa come formularlo verbalmente. La protagonista, in questa trasformazione, trova la sua giusta dimensione: «Non sapeva nemmeno quali fossero le sue giuste dimensioni, Ma lì, sotto il sole dorato, finalmente l’aveva scoperto: erano le dimensioni di una foglia». Tale trasformazione mostra un modo di diverso adesso, meno antropomorfizzato di vedere la terra e la sua creazione: «Nel paesaggio cosmico le piante hanno un posto in prima fila. Dio è entusiasta del fatto che il pubblico della creazione sia interamente composto di piante: alberi e cespugli, fiori e bacche tutti seduti a godersi lo spettacolo […]. Che privilegio poter star lì comodi a guardarla! Essere riempiti interamente della bellezza della vita! […]. Non è stato mica facile per le piante imparare a starsene sedute buone buone».
Torna, qui, da un diverso punto di vista, l’idea di un esistente che precede la comparsa dell’uomo, le piante sono prima della creazione, ne sono spettatrici. La metamorfosi, con il suo dispositivo metaforico, di conoscenza e di racconto, modifica il modo di guardare; in questi anni nel dibattito culturale è stato posto il tema, con giusta attenzione, dell’Antropocene; una delle risultanti più interessanti nel riflettere su questo concetto è, a mio parere, la richiesta imperativa, fatta ai letterati, filosofi, antropologici e intellettuali in genere, di osservare il mondo “come se” l’uomo non ci fosse. A me pare chiaro che guardare il mondo in assenza dell’uomo si configuri come un paradosso – nel momento stesso in cui immagino qualcosa del genere sto comunque antropomorfizzando lo sguardo, lo sto rendendo più acuto, più preciso, più etico e plurale, ma non posso liberarmi dal mio essere uomo – ma è un paradosso che porta a cambiare prospettiva.
È la stravaganza della metamorfosi a insegnarci questo: a ben pensarci spesso ragioniamo sulla metamorfosi come un processo che da α si modifica in β, in questo modo tendiamo a dare più importanza a β, dimenticando α; in tal modo vediamo sono una parte del procedimento. La metamorfosi, infatti, produce sempre una sorta di sentimento di nostalgia, il cambiamento che viviamo sia che sia temporaneo o definitivo, contiene in sé la mancanza o la perdita di ciò che eravamo prima: la questione identitaria non può mai essere disgiunta dalla questione del ritorno, ritorno e identità sono uniti dalla nostalgia, ciò che abbiamo modificato, per quanto sia per sempre, per quanto sia terribile, ci definisce anche nella sua assenza, anche nel suo non esserci più: «E poi di colpo un quadrato di luce era entrato nella foglia, […] e Mira era caduta fuori, fuori, fuori da una foglia».
La metamorfosi è reversibile, non sempre definitiva, in entrambi i casi ciò che lascia è appunto perdita e acquisto: si perde qualcosa perché si acquista altro, ma ciò che viene perduto rimane come ombra, come traccia che ci turba e rappresenta il nostro passato. Tiresia vecchio cieco con le mammelle avvizzite è il simbolo di questa coabitazione della perdita e dell’acquisto: la metamorfosi insegna che l’identità non avviene per aggiunta, ma per sottrazione, avviene per negazione: io mi definisco non in base ha ciò che ho, ma ho ciò che non ho più, io mi definisco non in base a quello che sono, ma a quello che non sono più; quello-che-non-sono-più è il cammino della nostalgia, la nostalgia ha che fare con la vergogna, con la colpa, con l’inesplicabile che ci circonda; con i sogni inquieti che ci svegliano al mattino tramutati in insetti.


