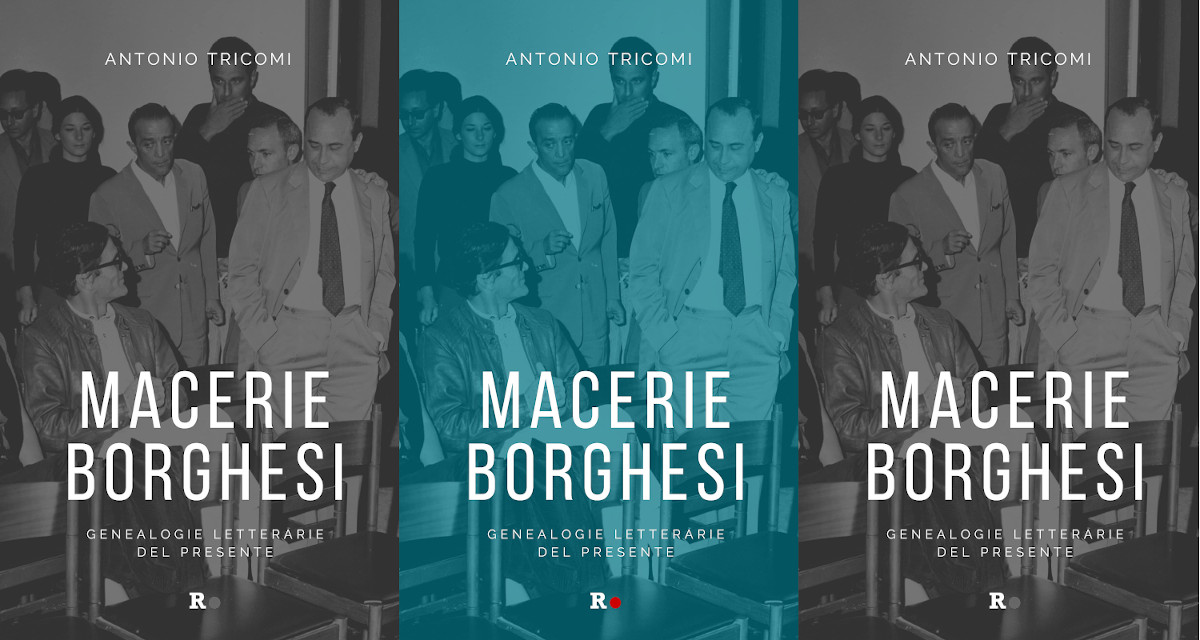Riccardo Donati: Antonio Tricomi, il suo Macerie borghesi. Genealogie letterarie del presente (Rogas, 2023) inaugura una collana di critica letteraria il cui titolo richiama un intervento di Franco Fortini del 1949, Vergogna della poesia:
il poeta non genera poeti, non genera chi ripeta all’infinito la sua eco, ma pone invece l’esigenza di un superamento di quella forma: il passaggio dal formare al fare, dal poièin al prassein, dall’estetica all’etica e alla politica. La poesia dunque non è tanto engagée quanto engageante.
Può chiarire perché queste parole scritte nel Dopoguerra non solo le paiono attuali, ma assumono il valore di una dichiarazione programmatica, di una mozione d’intenti «rigorosamente di parte», come scrive nella Nota al testo?
Antonio Tricomi: Fortini ha pubblicato quel saggio all’incirca da un trentennio quando Roland Barthes, in una celebre Lezione al Collège de France, definisce la letteratura, se non «distrutta», ormai però «desacralizzata» perché non realmente «custodita» da istituzioni – scuola e università in primis – tanto socialmente svalutate da non aver più l’autorevolezza necessaria a proporla come «il modello implicito dell’umano». E certo – lo dico da insegnante di un Istituto tecnico e da ex docente universitario a contratto – quella che, nel 1977, appariva una spinta già pronunciata a rimuovere il valore etico-civile della letteratura rischia oggi di sembrarci un processo del tutto compiuto.
E dunque no: ogni invito a concepire un testo letterario come un appello rivolto ai lettori, affinché essi lo rendano la premessa di un qualche loro agire sociale, oggi suona oltre misura inattuale. Lo si può di conseguenza ripensare – o è almeno questa la scommessa da cui trae origine la collana di cui stiamo parlando – come una paradossale possibilità utopistica. Del resto, dato che nulla o quasi la letteratura ormai conta sul piano socioculturale, perché mai accanirsi a scriverne, insistere a leggerla, continuare a occuparsene in sede critica se non per provare a riscoprirla uno strumento di decodifica e di potenziale trasformazione della realtà? Molto più utile e gratificante dedicarsi ad altre forme espressive, per chi ad essa viceversa si accosti con spirito – diciamo così – rinunciatario.
RD: Engageante evoca la lezione di Fortini, nei suoi saggi torna a più riprese la figura ispiratrice (sebbene non idolatrata) di Pasolini, presente anche nella foto di copertina che lo ritrae con Sciascia. Il Novecento e i suoi conflitti sono diventati la cattiva infinità entro cui non smettiamo di dibatterci? E i suoi venerati maestri la cattiva coscienza del nostro presente inadeguato?
AT: Per quanto mi riguarda non ho dubbi: il modo in cui quegli autori potevano costruire il loro profilo di scrittori, aspirando a presentarsi quali coscienze critiche della società, oggi non è riproponibile, perché non si dà più – per citare Bauman – la figura, miticamente moderna, dell’“intellettuale-legislatore”. E perché, dissoltesi – per dirla questa volta con Lyotard – le “grandi narrazioni” moderne, non si offre alle opere letterarie la possibilità di strutturare sé stesse, e di chiedere l’attenzione del pubblico, in base a un proprio desiderio di confliggere o di confessarsi in sintonia con sistemi filosofici o paradigmi utopistici culturalmente vivi.
Anche però considero la nostalgia un sentimento intrinsecamente reazionario. Non si tratta, dunque, né di rimpiangere Sciascia né di augurarsi che gli scrittori dei nostri anni vogliano imitare Pasolini. Se desideriamo davvero mettere a frutto la lezione di quei maestri, si tratta piuttosto di riconoscerne la cifra squisitamente etico-politica per capire in quali forme del tutto inedite ci risulti poi possibile – sia come lettori sia come autori – farla rivivere. Nel libro ricordo la maniera in cui proprio a questo si è dedicato, per esempio, un esponente della mia generazione che troppo presto ci ha lasciato: Alessandro Leogrande.
RD: La sua postura “geneaologica” mi pare sottenda un discorso storico e insieme una volontà trasformativa. Un discorso storico giacché ridiscute valore e senso dei “poveri resti”, per così dire, del secolo socialdemocratico; una volontà trasformativa in quanto rifiuta l’idea che il terrain vague rimasto dopo la rimozione di certe macerie borghesi sia una landa inabitabile e non un nuovo possibile spazio civile. In che misura lo studio delle dinamiche letterarie può ancora aiutarci a capire il sistema socio-culturale in cui viviamo e, di conseguenza, a operare sul piano culturale per cambiarlo?
AT: A tal punto protagonista della modernità da poter addirittura pretendere di identificarsi con essa, nel destino della classe sociale cui appartengo, la borghesia, sembra esserci una continua produzione di macerie. In origine, quelle di un mondo arcaico in larga parte travolto dalle sue istanze emancipatrici. Per circa due secoli, però, anche quelle di ogni realtà e ogni logica non assimilabili alla sua congenita anarchia, se il capitalismo, che dell’etica borghese è il trionfo, altro in verità non è che il costante ammonticchiarsi sì di merci, sì di spettacoli, sì di promesse di illimitato godimento individuale per ciascun cittadino, ma soprattutto di distruzioni sempre presunte rigeneratrici.
E l’impressione è che nell’era della crisi, ormai incontrovertibile, della democrazia liberale, che va ad aggiungersi a quella, da tempo conclamata, della classe media, con un altro cumulo di macerie la borghesia debba oggi fare i conti: con i propri, di “poveri resti”. Perché quella in cui viviamo sempre più rassomiglia a una padronale società post-borghese, non esattamente fedele all’eredità storica dell’illuminismo e, anzi, dai lugubri tratti neofeudali. Una società composta da pochi, garantiti, immarcescibili signori e da nutrite schiere di loro subalterni abbandonati, in quote e forme diverse, a un progressivo, mortificante impoverimento. Come pure una società in cui è concesso, ai primi, di procedere a una sempre più autoreferenziale museificazione della cultura e si offrono, ai secondi, retoriche identitarie apertamente fondate sull’abiura di qualsivoglia reale aspirazione conoscitiva, sul rigetto di ogni canonico sapere formalizzato, su logiche perciò inclini ad autorizzare una collettiva riscoperta della barbarie.
Di per sé, la letteratura (proprio come le poesie, nel titolo di un celebre volume di versi pubblicato da Patrizia Cavalli nel 1974) non ha mai cambiato il mondo e mai lo cambierà. Può aiutarci tuttavia a capirlo, perché l’arte – come sosteneva Adorno nella Filosofia della musica moderna – racconta la nostra storia di uomini e di donne con maggiore precisione che non i documenti. Ecco quindi che rileggere, come ho cercato di fare nel mio libro, alcuni autori italiani (da Parise a Morselli, da Volponi a Morante) attivi nel Dopoguerra e attenti a sondare valori e disvalori, ipocrisie e conquiste della borghesia, e in egual misura confrontarsi con scrittori a noi coevi particolarmente inclini a interrogare le dinamiche sociali del presente (penso in primo luogo a Walter Siti e Francesco Pecoraro), può farci meglio intendere il nostro tempo. E solo chi effettivamente comprende l’età in cui si trova a vivere può, nel caso in cui desiderasse poi agire per trasformarne le logiche, elaborare strategie quantomeno plausibili di intervento sulla realtà.
RD: Può dirci qualcosa circa i futuri titoli della collana?
AT: Entro l’estate prossima sarà pubblicato Nel vuoto del tempo di Mario Pezzella. Che muoverà dal confronto con alcuni autori letterari – Thomas Mann e Céline su tutti – capaci, negli anni Venti e Trenta del Novecento, di esplorare o di esprimere gli “stati d’animo” responsabili di aver predisposto l’intera coscienza europea al fascismo nascente o neonato, per metterci poi sull’avviso esaminando, in particolar modo, opere cinematografiche più recenti, da Vincere di Bellocchio a Moloch di Sokurov: si nota forse una tragica “corrispondenza benjaminiana” tra il sentire e gli eventi di un secolo fa e quelli attuali.
Ci stiamo ancora lavorando, per cui non sono già in condizione di annunciare i successivi titoli della collana, nell’ambito della quale conveniamo con l’editore di pubblicare due, al massimo tre, volumi all’anno. Quello che mi sento tuttavia di assicurare è che si tratterà sempre non di studi specialistici, e in tal senso classicamente accademici, ma di saggi filologicamente attenti, questo sì, e però disposti anche a prendersi dei rischi interpretativi, pur di ribadire un’idea della critica letteraria quale generoso esercizio di critica della cultura.