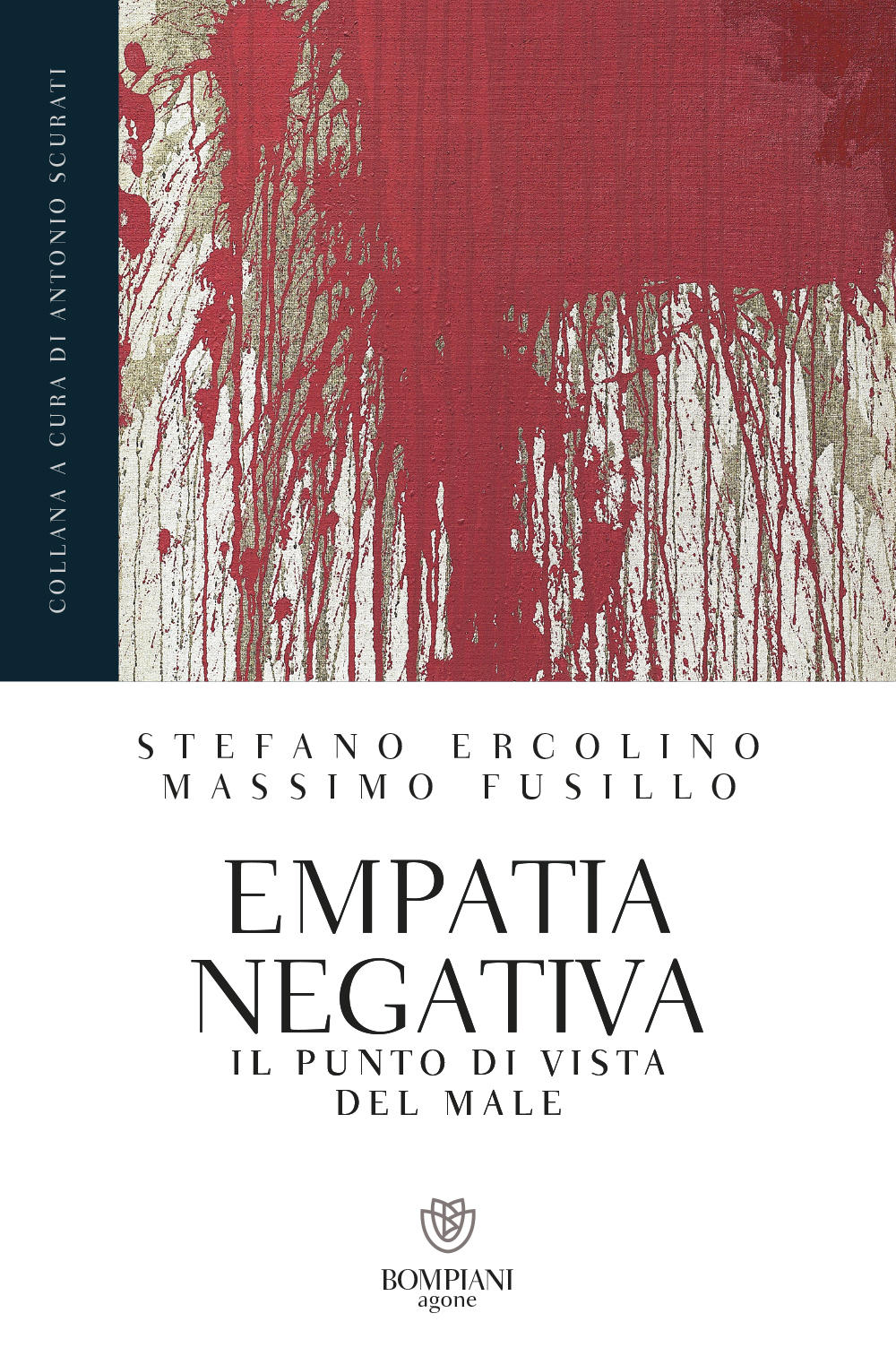L’esperienza del negativo
Nelle scene finali dell’Otello, dopo aver macchinato e ottenuto ciò che voleva, Iago si chiude in silenzio ermetico. Non dirà neppure una parola, tacerà per sempre, custodendo in sé e per sé il segreto motivo per cui ha compiuto, e a cui noi spettatori abbiamo assistito. L’enigma di questo suo tacere, che ci turba, si associa a una sensazione altrettanto sgradevole, che una volta usciti da teatro non ci abbandona: ovvero, quella di aver provato empatia, di essere diventati e di esserci sentiti, come lui, di aver provato piacere a vedere come Iago riusciva a costruire la sua nera trama.
Tale sensazione trova la sua più completa e precisa descrizione nel bel saggio Empatia negativa di Stefano Ercolino e Massimo Fusillo (Bompiani), che ha nel suo sottotitolo una possibile giuda di lettura: il punto di vista del male. Il saggio ha una duplice funzione: da un lato ci guida a scoprire studi e riflessioni sull’esperienza del “negativo”, e dall’altro analizza alcune opere, sia dalla letteratura sia nel cinema e nell’arte, nelle quali lo spettatore e il fruitore vivono questa esperienza limite.
Gli autori sembrano avallare la tesi di Siti in Contro l’impegno, per il quale l’espressione artistica è diventata veicolo di valori morali, legati al bene, al buono, al corretto, con una sempre maggiore attenzione affinché né la vita né le opere di un dato artista possano contenere qualcosa di conturbante, estraneo, spaventevole. I due saggisti, infatti, citando e seguendo la tesi di Bataille che scriveva «se la letteratura che si allontana dal male diventa subito noiosa» (La letteratura e il male), sostengono come la posizione dello scrittore francese «oggi difficilmente troverebbe molti consensi nei circoli accademici e negli orientamenti culturali mainstream, dove non è affatto raro che l’arte venga decontestualizzata e presentificata, mentre si cerca di trasformarla in un discorso più o meno edificante».
Rispetto a questo quadro, fin troppo catastrofista, bisognerebbe ricordare che la letteratura, e l’arte nei secoli, ha sempre posseduto un potere oscuro (si pensi alla famigerata, discussa e complessa messa al bando dei poeti dalla Repubblica di Platone; più in generale su questo tema ha scritto Gottschall ne Il lato oscuro delle storie, edito da Bollati Boringhieri), e che essa produce in chi la vive un’esperienza del negativo, dello sconosciuto e dell’altro, che non può essere messa da parte. Se la narrativa è l’esperienza dell’alterità, alla base di ogni narrazione c’è un patto riassumibile a un “come se”, se leggere un romanzo è l’attraversamento del confine lasco tra fatto e finzione, se nel leggere sentiamo di essere come Madame Bovary o come Humbert Humbert, se quindi la narrativa è l’esperienza dell’altro da noi, per quale motivo dovremmo avere paura e timore di metterci nei panni del completamente altro da noi ovvero il Male, l’oscurità, la negatività?
Per quanto sottoposto a un tentativo di addomesticamento, che per gli autori come abbiamo visto si configura come una sorta di rimozione dello stesso, il negativo rimane come quanto di più «tellurico, sovversivo, antigerarchico e, insieme, sublimante e catartico» ci sia nell’arte. Anche nel male, nel negativo e nel disturbante esiste, però, una possibile gradazione. Particolari dinamiche ci spingono, ad esempio, a trovare una maggiore capacità di empatia con Walter White il protagonista di Breaking Bad (quanti di noi hanno nell’armadio una maglietta con la sua effige) che con il protagonista di Lolita.
Il tema su cui ruota il saggio di Ercolino e Fusillo può essere riassunto nel concetto di identificazione, che non deve essere confuso con una semplicistica idea di adesione – io divento il personaggio –, ma con una sorta di capacità di sentire su di sé il personaggio, di avvertirlo, di produrre una immaginazione in cui “avremmo potuto noi essere così”. Si torna, quindi, al discorso antico (temporalmente) ma sempre presente della catarsi aristotelica, che ha come fondamento la differenza tra i testi storici e i testi d’invenzione: i primi raccontano le cose come sono accadute, mentre i secondi si occupano delle cose come avrebbero potuto accadere. Quindi, concludendo con le parole di Ercolino e Fusillo, noi, «senza più figurarsi di essere l’altra persona, mutiamo maniera consapevole e intenzionale la nostra prospettiva al fine di immaginare a quali pensieri, emozioni, decisioni ecc potremmo prevenire se ci trovassimo nella situazione in cui si trova l’altra persona».
Ciò è vero se in qualche modo, la narrazione, in maniera diretta o indiretta, ci aiuta a costruire una identificazione tramite una situazione narrativa (entrambi termini appunto usati nel saggio); ma se queste due coordinate ci vengono precluse? Se la costruzione stessa del personaggio, il nucleo dell’agire, fosse in qualche modo opaco? Quale sarà la nostra identificazione di lettori, e perché essa avviene? E cosa ci lascia? Proviamo a porre queste domande a due testi in particolare e a due personaggi di queste opere: Iago nell’Otello di Shakespeare e Stavrogin nei Demoni di Dostoevskij.
Il paradosso di Iago
Iago ormai prigioniero pronuncia le seguenti parole: «Non chiedetemi più nulla. Quello che sapete sapete. E da questo momento non dirò più una parola» (Otello V, 2 – utilizzo qui la traduzione di C. Vico Ludovici edita da Einaudi). La domanda che ci facciamo mentre vengono pronunciare tali parole è: “Cosa sappiamo di Iago?”. Di lui non sappiamo veramente nulla, o poco; le motivazioni per cui ha tramato contro Otello – gelosia?, una possibile storia di tradimento della moglie; invidia?, il desiderio di usurpare il ruolo di Otello – sono talmente evanescenti che, durante la rappresentazione, le dimentichiamo. Non c’è nessuna ragione speciale per fare quello che fa, non c’è un criterio, che invece guida le azioni di Macbeth o Amleto – con i quali infatti è più facile empatizzare, perché comprendiamo ciò che fanno e il perché lo fanno. Ciò non avviene con Iago, il suo agire ci è misterioso, l’identificazione deve avvenire su un piano diverso.
Shakespeare lascia al lettore/spettatore piccoli indizi per far comprendere che Iago è un personaggio che trascende l’opera che stiamo leggendo; nella grandezza della sua immaginazione, con Iago il drammaturgo inglese ha voluto incarnare e mettere sulla scena la negazione dell’essere, la negazione dell’individuo. Iago è un personaggio ultra-mondano, che non risponde con le sue azioni a ciò che è terreno; è sempre estraneo all’azione, sempre sui generis. Se riprendiamo il testo, poche battute prima di quelle riportate poco sopra, assistiamo a quest’altro dialogo, tra un Otello cieco di rabbia e Iago:
Otello: Guardo il suo piede, se non sia forcuto come quello del diavolo. Ma se sei un diavolo non potrò ucciderti (Ferisce Iago).
Ludovico: Disarmatelo!
Iago: Mi ha ferito ma non ucciso.
Anche queste battute hanno a che vedere con l’identità di Iago: Otello lo osserva, cerca in lui qualche segno del suo essere diabolico (il piede caprino), poi affonda la spada per ucciderlo, affermando, però, che se Iago è un diavolo non potrà morire. Dopo la breve colluttazione Iago dichiara di essere stato ferito ma non ucciso. Potremmo interpretare questo scambio alla stregua di un sillogismo: ciò che è diabolico può essere ferito ma non ucciso; Iago viene ferito ma non ucciso; Iago è diabolico.
Ciò mostra con chiarezza che Iago non appartiene all’umano: egli osserva gli ultimi accadimenti senza più neppure dire una parola; se la sua presenza scenica nella rappresentazione rimane, nel testo, nella lettera, svanisce. Iago scompare, non viene neppure nominato nei movimenti, se non alla fine quando Ludovico lo apostrofa, ma ne parla come se fosse un’assenza, qualcosa che nella sua presenza si nega.
Di Iago conosciamo benissimo i pensieri, i discorsi che fa per costruire il suo intrigo, ma non la sua anima: la sua presenza è tale che produce come una scomparsa. Perché ci turba questo personaggio? Perché egli ci appare come una negazione vivente di ciò che è umano; è l’esperienza limite del descrivere qualcosa che non è. A conferma di questo possiamo leggere Otello I, 1, dove a parlare è lo stesso Iago, inizialmente non diamo la giusta importanza alle sue parole, perché forse ancora distratti dal brusio che accompagna l’inizio della tragedia. «Io non sono quello che sono» è la sua dichiarazione, spersa nel fuoco d’artificio dialogico, che quasi ci sfugge. Non ne cogliamo la polisemia, ci accontentiamo della lectio facilior, io non sono quello che sembro, sono un mentitore, sembra dire Iago, sono un impostore. Secondo questa ipotesi, allora, la tragedia di Otello è appunto nient’altro che un dramma della gelosia e della rivalsa. Se, però, consideriamo con più attenzione le sue parole, vediamo come essa ricordi una ben altra affermazione di identità. È chiaro che Shakespeare, qui, citi Esodo e il versetto: «Io sono colui che sono», ovvero la dichiarazione di identità e di esistenza del Dio biblico, rivolta a Mosè. Tale prossimità è ancora più forte se prendiamo l’originale: «I am not what I am» e la paragoniamo Esodo 3, 14: «I am that I am». La natura della citazione è chiara, Iago annettendo a sé stesso il “not” non nega tanto Dio, quando afferma il suo non essere ciò che Dio è: anzi è la negazione di Dio.
Se volessimo tradurla molto liberamente, potremmo dire che Iago “È ciò che Dio non è”: e quindi potrebbe essere il Diavolo, ecco perché Otello lo ferisce, ma non lo uccide. A sostegno della ipotesi della natura diabolica di Iago si potrebbe aggiungere anche il suo agire lungo l’intera storia; egli divide, separa e si mette di traverso, e come tale è assimilabile alla etimologia della parola diavolo, colui che si diverte con Dio a scommettere sulla bontà di Giobbe.
C’è, però, un dato ancora più interessante, un’altra frase, sempre contenuta in Otello I, 1, che attira la nostra attenzione «Se io fossi il Moro, non vorrei essere Iago». Che cosa significa questa frase? Vuole essere Otello per non essere sé stesso? O se fosse Otello, non potrebbe essere sé stesso? Come spesso accade in Shakespeare, la frase può avere diverse interpretazioni, ma entrambe le affermazioni di Iago possiedono una caratteristica, una spia linguistica, legata al “not/non”; Iago si definisce per negazione: lui è il “non”, la negazione di sé, la negazione di ciò che ha nel cuore; è un essere negativo.
Ritornando, quindi, al tema del saggio Empatia negativa, è possibile quindi identificarsi con qualcosa che rifiuta o postula la non identità? Dal punto di vista della logica, l’affermazione di Esodo 3, 14 è una tautologia “Io = Io”, quindi Dio è dal punto di vista logico una semplice identità, Iago, quindi, si configura come una rottura di questa tautologia.
Il nucleo, forse sotterraneo, del saggio di Ercolino e Fusillo può essere ravvisato nel “se e come” viene risolta la domanda identitaria, riprendendo una riflessione di Kundera nell’Arte del romanzo. Semplificando brutalmente, il romanzo nasce per rispondere alla domanda “Chi sono io?”, nasce con il lungo cammino che intraprende Chisciotte proprio per affermare la sua identità. Il romanzo, quindi, postula una ricerca di definizione identitaria fin dai suoi inizi, ma con Iago ci troviamo davanti a un dilemma: il lettore viene a identificarsi con un personaggio che nega sé stesso.
Il turbamento che ci produce è appunto la nostra esperienza, la nostra identificazione con un “personaggio”, il quale non si interroga sul “non” essere come Amleto, ma che è un “non” essere. Iago mostra all’uomo cosa significa abbandonare l’umano, che tipo di destino tocca, quando si varcano certi confini: è un viaggio metafisico, una speculazione, è lo sguardo gettato su ciò che non c’era prima che Colui che è fosse.
Filologia del male
Come abbiamo visto, Ercolino e Fusillo individuano due diversi poli per definire l’empatia: la prima è l’identificazione (analizzata in Iago), e la seconda è la situazione narrativa. Interpreto qui l’idea di situazione narrativa come la combinazione tra fabula e intreccio, di progressivo dispiegarsi della storia agli occhi del lettore e di come questa empatia possa variare, esserci o meno, a seconda della modificazione di tale struttura. Vorrei utilizzare come esempio due diverse edizioni dei Demoni di Dostoevskij e paragonarle: sarà un breve esercizio di filologia del male.
La mia prima edizione dei Demoni, letta nel periodo universitario, era un tascabile, comprato per poche lire sulle bancarelle dell’usato; il testo era diviso in due volumi, riportando la divisone del romanzo così come Dostoevskij l’aveva voluta: 3 parti, ognuna è composta da una serie di capitoli: I – 5, II – 10, III – 8; alla fine di questi era posta un’appendice, che riportava un capitolo censurato, che si intitolava Da Tichon. La traduzione era di G. Buttafava nell’edizione della Bur Rizzoli. Nella mia edizione attuale, edita da Feltrinelli, il curatore e traduttore Gianlorenzo Pacini fa una scelta diversa. Il romanzo è sempre diviso in tre parti, ma nella seconda i capitoli sono 11, perché appunto inserisce il capitolo Da Tichon, tra il capitolo 8 pubblicato e il capitolo 9 pubblicato, facendo sì che diventi il capitolo [9].
La posizione del capitolo è quella che Dostoevskij aveva previsto nel piano originale dell’opera, Da Tichon doveva essere posto tra Il figlio dello zar (cap. 8) e La perquisizione in casata Stepan Trofimovic (cap 9). Le domande sono presto formulate: Come e cosa cambia all’interno della narrazione ripristinare il capitolo censurato nella sua posizione primitiva o aggiungerlo in coda come appendice? In che modo la scelta di una delle due opzioni cambia la mia avventura di lettore? E in che modo, infine, tale scelta ha a che fare l’empatia negativa?
Da Tichon è uno dei capitoli più terribili del romanzo, nel quale Stavrogin fa leggere a Tichon – un uomo santo, un eremita – e a noi con lui, una lettera, in cui il principe racconta di come ha abusato di una bimba di quattordici (o dieci? il dato sull’età non è chiarissimo) anni e di come in seguito abbia assistito e non mosso un dito, mentre la bimba si toglieva la vita.
Questo capitolo rappresenta il momento in cui «demone dell’ironia», che possiede Stavrogin, si esprime pienamente; dice ciò che ha nel cuore, e ciò che ha compiuto. È la prima volta che assistiamo a questo movimento di sincerità del protagonista; nel corso dei Demoni ogni personaggio vuole in qualche modo leggere nel cuore di Stavrogin, ogni personaggio crede di sapere cosa egli pensi, sappia e agisca, ma – nella realtà romanzesca – egli è veramente l’enigma indecifrabile per tutti, dove ognuno compie azioni in nome suo, senza che lui abbia mai detto “Sì”. È presente in lui una opacità, nel pensiero, nelle opere e nelle azioni, che è il segno del male; anzi Stavrogin è la grande invenzione di Dostoevskij la rappresentazione di un male totalmente nuovo, moderno. Stavrogin è chiuso in un mistero che lui non vuole esprimere, più volte il narratore infatti accompagna i comportamenti del principe alla parola “enigmatico”. Oltre alla lettera di cui abbiamo detto, nel romanzo è presente solo un altro momento in cui Stavrogin parla apertamente. Nel capitolo finale del romanzo, egli scrive alla sorella di Satov una lettera, che noi leggiamo prima di conoscere il suo suicidio. Stavrogin confessa in questa missiva la sua disperazione, la sua ombra, il suo essere male, tacendo, però, ciò che ha detto a Tichon (la sorella di Satov lo sapeva? Forse, oppure è una scelta voluta di non dire, non lo sapremo mai). Le due lettere, che sono due dei momenti più alti e apicali del romanzo, sono separate da circa 450 pagine. La confessione di Tichon è nel mezzo del romanzo, la lettera alla sorella di Satov è collocata in chiusura.
Questo ordine dà alle pagine un certo movimento, un certo montaggio, facendoci percepire il capitolo della visita a Tichon come il fulcro del romanzo, la sua tenebra inespressa; la lettera a Daria, però, produce dubbi, dona alle parole di Stavrogin un’ulteriore ambiguità: cosa voleva dire con quella lettera? Perché dopo quella lettera in cui chiede alla sorella di Satov di venire da lui e di fuggire insieme, ben sapendo che lei sarebbe andata, Stavrogin si suicida? Forse questo è dovuto dall’ombra del rimosso, del non detto, della confessione di Tichon, che noi conosciamo ma che Daria presumibilmente no? Oppure Daria sapeva, e allora il suicidio del principe assume una diversa luce e prospettiva.
Se, invece, prendiamo per buona la soluzione in cui il capitolo Da Tichon viene posto in appendice a chiusura di testo, cosa cambia nella nostra situazione narrativa? Intanto dobbiamo dire che dal punto di vista “scientifico” essa è altrettanto giustificabile. Certo, potremmo chiederci come scrupolo filologico: “Siamo poi sicuri che infine Dostoevskij avrebbe tenuto quel capitolo? O che l’avrebbe tenuto così? O che l’avrebbe mantenuto in quella posizione?”. Sono domande il cui ventaglio di risposte è troppo ampio e troppo vago, quindi atteniamoci alla possibilità che si possa fare. Spostando il capitolo a conclusione, abbiamo un’altra narrazione, tutta diversa. Ad esempio le due “confessioni” non solo sono ravvicinate, ma anche invertite, prima la lettera alla sorella di Satov e poi la confessione a Tichon: questa scelta, che è in fin dei conti una scelta narrativa, infatti neppure la filologia è una scienza neutra, produce una serie di cambiamenti. In tal modo la confessione a Tichon si configura come una spiegazione delle oscurità e ambiguità delle parole alla lettera di Satov, e illumina e disambigua tutta la descrizione di Stavrogin; ovvero ha un effetto esattamente opposto a quello di rimettere il capitolo al suo posto primitivo.
Viene da chiederci: “Ma quale è la scelta migliore?”
Per vedere quale sia la scelta migliore penso che sia utile chiedersi cosa voglia rappresentare Stavrogin: Stavrogin è una sorta di guscio vuoto, che fa le cose per farle, senza un vero e proprio progetto, è la perfetta rappresentazione del male idiota, il male di per sé, è il male amorfo che prende forma a seconda di chi lo guarda. Egli è veramente il male che ha per nome Legione, e che trova rifugio negli altri, nei porci, nei personaggi che incontra; è un male tiepido, ordinario, poco demoniaco, è un buco. Se questa impressione è vera, l’ipotesi dell’appendice perde senso narrativamente, perché appunto spiega, ridimensiona questo personaggio, che è così moderno, al rango di “semplice” cattivo.
La scelta opposta, ovvero il capitolo nella sua posizione originaria, ci consegna un personaggio diverso, in cui la scena della violazione della bambina e il suo suicidio si configurano come una delle tante azioni, non finale, né ultimativa – dal punto di vista narrativo –, del principe. La seconda scelta ci consente, in quanto lettori, di immedesimarci con lui, perché l’episodio avviene nel mezzo della narrazione: non si configura come il risultato finale di quel processo di conoscenza che è il romanzo. Entra, quindi, in gioco l’empatia negativa di cui parlano Ercolino e Fusillo: dopo aver letto la confessione, andiamo avanti con le pagine, trasaliamo quando ci appare sulla pagina il riferimento a un ragno o a un insetto, leggiamo con la speranza che qualcosa accada, che qualcosa succeda, arriviamo alla lettera per sorella di Satov, sperando, cercando e immaginando qualcosa, che ci tolga dalla memoria il pugno della bimba davanti al volto del protagonista, un’immagine talmente vivida come se fosse davanti al nostro viso, perché Dostoevskij ci ha portato a essere Stavrogin. Noi siamo il fulcro della narrazione e la sua soluzione, leggiamo e vogliamo dimenticare la bimba appesa; ci illudiamo, ci dimentichiamo della Zoppa sgozzata, della fine misera di Lizveta, leggiamo la lettera, ma nulla, la bimba è sempre lì, non si cancella, la sua presenza non produce colpa o ravvedimento, è semplicemente fissa nel nostro cervello: non c’è peccato, non c’è pentimento. Così il suicidio non è affermazione di colpevolezza, o di insopportabilità della vita, ma scelta finale, la più semplice, ironica e idiota, per “non dire niente” e per fare sì che ciò che è stato fatto e compiuto rimanga un mistero, perché il male non ha nessuna logica se non il fatto di essere male.
Il notevole interesse di Empatia negativa di Ercolino e Fusillo sta tanto nella critica al “politicamente corretto”, quanto nella profonda e inesausta indagine di questo meccanismo, che noi come lettori, o fruitori d’arte, facciamo quotidianamente e che non è per nulla “innocente” o “neutro”; troppo spesso l’arte è vissuta come un passatempo, una facile ricerca delle emozioni, e noi viviamo in una dittatura delle “commozione”, dei “sentimenti”, della “emozione”, mentre l’arte è qualcosa di più oscuro, è guardare – anche – il tremendo, uscire turbati da uno spettacolo teatrale o da una mostra, dalla lettura di un romanzo, ripetendosi infine «da me è uscita soltanto la negazione, senza nessuna magnanimità e nessuna forza» (Demoni, 881), perché ci mostra lo scandalo dell’uomo: «Io tuttora posso desiderare di compiere una buona azione e ciò mi procura piacere; al tempo stesso desidero compierne una malvagia e anche questo mi provoca piacere» (Demoni, 880).
Questo scandalo è il cuore del romanzo, della letteratura e dell’arte.