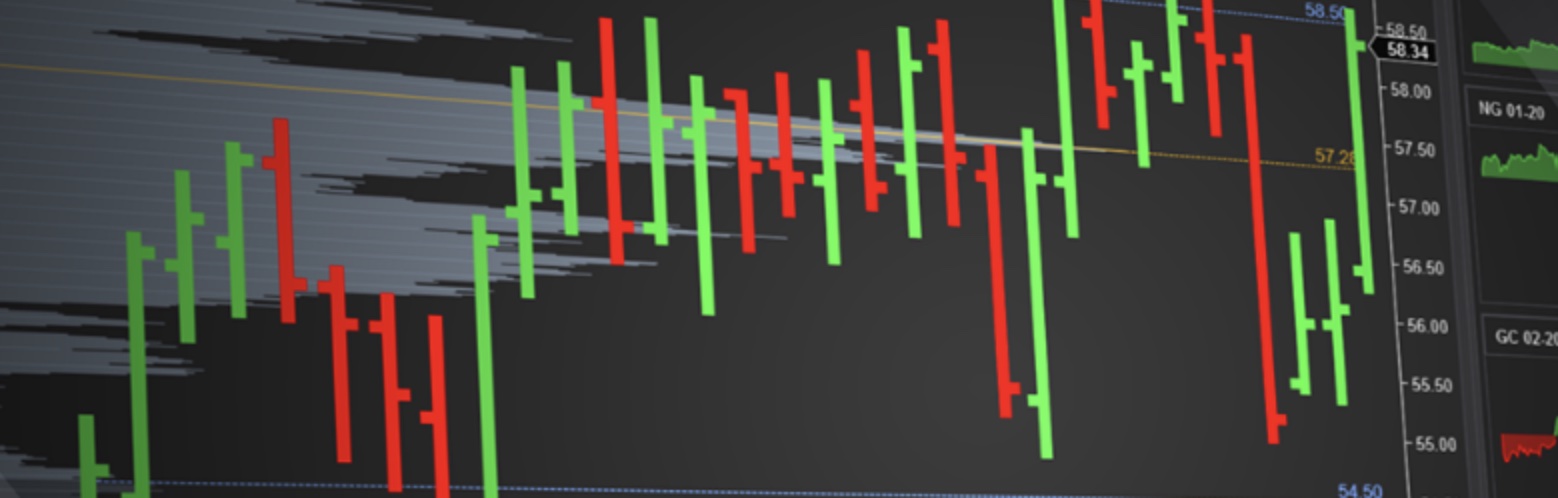1. Pochi giorni fa sulle pagine del «Guardian» ho letto questo articolo dove veniva riportata la notizia che alcuni scienziati e ricercatori hanno prodotto un’Intelligenza Artificiale a cui è stata fatta leggere la Commedia di Dante, e che questa IA è riuscita, a sua volta, comporre poesie, declamate da lei stessa. La IA ha in un certo senso “appreso” Dante, lo ha inglobato nel suo deposito di conoscenze e ha prodotto alcune poesie.
1. Pochi giorni fa sulle pagine del «Guardian» ho letto questo articolo dove veniva riportata la notizia che alcuni scienziati e ricercatori hanno prodotto un’Intelligenza Artificiale a cui è stata fatta leggere la Commedia di Dante, e che questa IA è riuscita, a sua volta, comporre poesie, declamate da lei stessa. La IA ha in un certo senso “appreso” Dante, lo ha inglobato nel suo deposito di conoscenze e ha prodotto alcune poesie.
Sono poesie? Questa è la domanda che mi sono fatto in primo luogo. Sono così andato a prendere uno dei manuali del biennio delle superiori e leggo che la poesia potrebbe essere definita una sorta di espressione dell’anima del poeta (una definizione certamente datata, ma in qualche modo efficace). La poesia, soprattutto la lirica, è espressione dell’animo e del sentimento del poeta. Quindi la risposta, alla domanda precedente, parrebbe facile: quella della IA non è una poesia perché non c’è animo, non c’è vita interiore. Non posso, però, negare che leggendo i versi riportati dal giornale qualcosa mi ha turbato: c’è un tono, c’è uno stile, c’è una rielaborazione; qui versi non sono una mera produzione di frasi di senso compiuto, cioè non c’è solo logica e correttezza grammaticale, ma qualcosa in più; è come se la IA avesse prodotto un pensiero, una comprensione del mondo o qualcosa di simile. Come se il risultato di quella poesia fosse molto più complesso del semplice calcolo combinatorio delle parole, messe insieme tramite leggi grammaticali e sintattiche, ma avesse appreso qualcosa dalla lettura della Commedia.
Quindi, senza entrare nei paradossi e negli esperimenti mentali, per i quali (perché no?) noi potremmo essere a nostra volta dei semplici androidi o simili, usati da altri esseri senzienti che hanno creato noi per comprendere come si sente e così all’infinito, la verità che è che non possiamo sapere cosa produca in noi la scintilla della poesia; potremmo pensare che essa nasca dal nostro cervello tramite una serie di impulsi elettrici che si regolano e si modificano a vicenda. Vista in questa ottica, ad esempio, quale differenza può esserci tra l’impulso elettrico del mio cervello, ad esempio i miliardi di impulsi che in questo momento produco per scrivere la parola che sto digitando sulla tastiera, e i miliardi di impulsi che la IA ha prodotto per scrivere la sua poesia? Che differenza c’è, se c’è, tra la mia esperienza di scrittura e quella della IA?
 2. Legge bene chi intravede in queste righe le perplessità – ermeneutica, speculativa e culturale – di un vecchio umanista che vede il suo paradigma andare a pezzi, il dubbio profondo che qualcosa debba modificarsi e il convincimento che la letteratura debba prendere atto quanto sia centrale fare i conti con le scienze dure e il dato scientifico. Illuminante per chi scrive fu, ad esempio, la lettura alcuni anni or sono di un saggio di Alberto Casadei dal titolo Biologia e letteratura (il Saggiatore, Milano 2018), che già poteva chiaramente al centro del tema questa necessità.
2. Legge bene chi intravede in queste righe le perplessità – ermeneutica, speculativa e culturale – di un vecchio umanista che vede il suo paradigma andare a pezzi, il dubbio profondo che qualcosa debba modificarsi e il convincimento che la letteratura debba prendere atto quanto sia centrale fare i conti con le scienze dure e il dato scientifico. Illuminante per chi scrive fu, ad esempio, la lettura alcuni anni or sono di un saggio di Alberto Casadei dal titolo Biologia e letteratura (il Saggiatore, Milano 2018), che già poteva chiaramente al centro del tema questa necessità.
Con maggior forza, questa tensione a rivedere e cambiare i paradigmi della visione delle humanae litterae è ribadita dal saggio di N. Katherine Hayles, L’impensato. Teoria della cognizione naturale (Effequ, Firenze 2021 con la traduzione di Silvia Dal Dosso e Gregorio Magini): libro complesso, ma che veramente apre la possibilità di provare a guardare ai fenomeni del pensiero e ai fenomeni delle neuroscienze da un punto di vista nuovo, e che può portare notevoli modificazioni nell’ambito degli studi umanistici.
3. Dobbiamo chiederci: Che cosa è l’impensato prima di tutto? Per Hayles è necessario dividere tra coscienza e cognizione. La coscienza, scrive, «rappresenta non tanto la totalità della sfera cognitiva» ma «la sua abilità nel creare narrazioni che danno senso alle nostre vite e che sostengono i nostri assunti di base sulla coerenza del mondo che ci circonda». La cognizione è, invece, «una capacità molto più ampia, che si estende ben oltre la coscienza e investe altri tipi di processi neurologici, ed è altresì presente in altre forme di vita e in sistemi tecnici complessi».
Esiste quindi, per la studiosa, una cognizione che non si risolve nella coscienza, la quale è posseduta da Homo sapiens «in misura maggiore e in forma più sviluppata rispetto alle altre specie». Mentre «la cognizione, al contrario, è una facoltà molto più diffusa e presente in qualche misura in tutte le forme di vita e in molti sistemi tecnici». Sempre usando le parole di Hayles, quindi, l’impensato è l’insieme «di fenomeni cognitivi nonconsci inaccessibili all’introspezione cosciente, e tuttavia essenziali per il funzionamento della coscienza». La scoperta di questo terzo passaggio del nostro essere, conscio, inconscio e nonconoscio, che si risolve nel concetto di impensato, ovvero di qualcosa che non è pensiero ma che lo contiene, che è precedente temporalmente al pensiero, ma non è pensiero ovvero non fa parte di quella coscienza che crediamo ci contraddistingua.
Il saggio di Hayles si sofferma su molte e complesse questioni; tra queste, due sono, a mio avviso, centrali:
a) la fine di ogni visione antropocentrica del mondo. Parlare di impensato e nonconscio modifica il modo di intendere il rapporto dell’uomo e con sé stesso e con gli altri esseri o ambienti; questo s-radicare l’uomo dal suo ultimo centro significa modificare il paradigma degli studi umanistici, accettando l’essere periferico dell’uomo nella storia del nostro pianeta;
b) il concetto di assemblaggi cognitivi. «Quando una persona accende il suo telefono cellulare diventa parte di un assemblaggio cognitivo nonconscio che include ripetitori e infrastrutture di rete, interruttori, cavi di fibra ottica e/o router wireless e altri componenti». Detto altrimenti, un assemblaggio cognitivo può essere anche un drone, la macchina che parcheggia automaticamente o controlla che tu non invada la carreggiata opposta ecc., ma l’assemblaggio cognitivo è anche l’algoritmo che produce immagini, predizioni e pensieri per il futuro, come ad esempio nei derivati finanziari.
4. Prendiamo quest’ultimo caso. In che modo analizzare i processi dell’assemblaggio cognitivo dell’algoritmo futures può essere utile a chi studia le scienze umane? Ad esempio, può portare a riflettere sullo statuto narrativo, linguistico e formale della profezia. I futures non sono, infatti, diversi da una profezia. Noi sappiamo che la profezia è la proiezione nel futuro, fatta da un attore presente, in riferimento a qualcosa che è già avvenuto. Gli algoritmi, tramite una lunga sequela di dati, prezzi, e quotazioni del passato, producono ora nel presente, una previsione di qualcosa – un dato di valore – che accadrà in un futuro. In entrambi i casi questo movimento di “pensiero” non è per nulla diverso a quello che facciamo noi quando diciamo: “Nel pomeriggio avrò pitturato tutto il cancello”. Anche questa è una forma di profezia, che si produce grazie alla forma verbale del futuro anteriore. La frase è costruita su una strana idea di temporalità. Da un lato indica un’azione che si sta compiendo, il parlante dice (presente) che sta pitturando ora e che nel (entro il) pomeriggio il suo lavoro si concluderà (futuro); nello stesso tempo è come se il parlante immaginasse, nella sua frase, il lavoro concluso, e quindi lo proiettasse nel passato, ma ciò potrà avvenire solo se l’azione avrà luogo tra il tempo in cui la frase viene detta (presente) e quello in cui si immagina compiuta (futuro).
I programmatori di algoritmi per i futures e gli autori dei libri profetici della Bibbia, in tempi e in modi diversi, hanno affrontato lo stesso problema logico e sintattico: rendere futuro nel presente un passato; la differenza è che questi algoritmi producono profezie con una velocità e una precisione impressionante e questo dato, senza contare le possibilità di eventuali cigni neri (ovvero un evento inaspettato e non prevedibile), non può che modificare il modo con cui guardiamo al futuro. Gli esempi nel saggio di Hayles, che analizza anche alcuni romanzi, sono vari, ma conducono tutti a una riflessione: ovvero che occuparsi dell’impensato, per i letterati, o per gli umanisti, significa indagare una rottura epistemica.

5. Leggendo le pagine de L’impensato mi è tornata più volte alla mente una affermazione di Wittgenstein. Chiuso il saggio mi sono stupito che Hyales non ne abbia mai fatto cenno, perché sarebbe stato interessante conoscere la risposta della studiosa alla logica della proposizione 5.61 del Tractatus logico-philosophicus: «Ciò che noi non possiamo pensare, noi non lo possiamo pensare; né, di conseguenza, noi possiamo dire ciò che noi non possiamo affermare». Il concetto segue, numericamente, la famosa sentenza 5.6, nella quale si enuncia come i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. L’impensato non è pensabile, dice Wittgenstein, e quindi è ineffabile: è una sorta di tautologia, la tautologia – per Wittgenstein – dice il nulla (Tractatus 5.142), come faccio a pensare qualcosa che non è nel pensiero? Non lo penso, ma se non lo penso, non lo posso neppure dire. Eppure verrebbe da sostenere che sì, corrisponde a verità: non possiamo pensare l’impensato, non possiamo dirlo – cosa avviene nel momento in cui pensiamo a ciò che è prima del pensiero che stiamo formulando – ma possiamo scriverlo, possiamo produrre una situazione limite che diviene il paradosso di scrivere l’impensato. La sentenza 5.61 del Tractatus mi è sempre parsa come il momento “limite”, in cui si traccia il confine di ciò che può essere detto. Se c’è uno scrittore che ha pensato sempre al limite, questi è Kafka, che nella totalità della sua opera spinge la propria lingua a quel confine di pensiero. Curiosamente, neppure Kafka viene mai citato nel corso della trattazione del saggio. Eppure ci sono almeno due testi che avrebbero potuto essere analizzati alla luce delle teorie di Hayles.
Quando la studiosa parla di assemblaggi cognitivi, scrivendo «comunque andrà, è ormai evidente che gli esseri umani e i sistemi tecnici sono coinvolti in complesse relazioni simbiotiche […]. Più si va avanti nella simbiosi, più sarà difficile per uno dei due simbionti prosperare senza l’altro», a me viene in mente la stretta e complicata relazione che Nella colonia penale si instaura tra il torturatore e la macchina, tra la macchina e l’esploratore; e di come la presenza dell’erpice, nell’economia del racconto, non sia meramente funzionale, ma divenga altro. Infatti la macchina della tortura non è solo un oggetto di scena, ma nel corso di quelle pagine diventa viva, anzi, “prende vita” proprio come un personaggio, come un attore della scena, che agisce, fa, cambia e modifica le situazioni.
Non è questo il luogo e, forse chi scrive non ha le competenze, per analizzare sotto questo aspetto di assemblaggio cognitivo Nella colonia penale; certo è che l’inquietudine che domina l’intera lettura del racconto è attribuibile anche a questo nonconscio della macchina di tortura, nell’abilità di Kafka di farci sentire le cognizioni di questa macchina. La domanda “che statuto ha un personaggio all’interno del racconto?” si è quindi rispecchiata nel domandarsi, alla fine del saggio di Hayles, quale statuto d’essere hanno gli assemblaggi cognitivi. È vero, il pilota e il drone sono due “realtà” diverse, ma quando il pilota guida il drone, questa unione pilota+drone è “qualcosa”, e se è qualcosa cosa è? Ma anche il drone, che da solo decide (badate bene, decide!) in base a una serie di variabili dove lanciare il missile e dove no, se è qualcosa, e lo è in quanto agisce, cosa è?
Ancora una volta ci viene in aiuto Kafka: potremmo definire questi assemblaggi tanti piccoli o grandi Odradek. Odradek è il misterioso personaggio di un breve racconto dal titolo Il cruccio del padre di famiglia. Odradek «ha l’aspetto di una spoletta per il filo, piatta e a forma di stella e sembra davvero coperta di filo, si deve trattare, però, solo di alcuni pezzi di filo strappati, vecchi annodati fra loro». Questo enigmatico e terribile personaggio è a parer mio la forma più simile e estrema di assemblaggio cognitivo che si può trovare in letteratura (è emblematica perché Kafka non pensava certo a un assemblaggio cognitivo, ma nello stesso tempo lo prefigura): può rispondere a certe domande, ride, è senza polmoni, condivide qualcosa delle piante (risuona come un fruscio di foglie, è muto come un legno). Tramite la figura di Odradek, Kafka pone la domanda limite: «Può morire?», la domanda giustifica il cruccio del titolo, che riguarda appunto un interrogativo che non pare avere una risposta certa o di così facile lettura.
6. Per rispondere a questa domanda e avviarci alla conclusione, prendiamo un particolare esempio di assemblaggio cognitivo. Siamo in un ospedale, nel letto c’è un bambino di circa 3 anni, non abbiamo nessuna idea se senta o provi qualcosa o abbia pensieri. Non ha reazioni visibili, Se facciamo rumore, non pare sentirci, se accendiamo o spegniamo la luce non pare accorgersene, non parla; il bambino è attaccato ad alcune macchine, una pompa per i polmoni, un saturimetro per riconoscere il battito, di tanto in tanto, a un’ora prestabilita il tubo della Peg inizia a nutrilo, un tubicino posto nella trachea dopo una tracheostomia serve per aspirare la saliva. La domanda sorge in noi spontanea: è vita questa?
È questo un interrogativo, che tocca la definizione di vita rispetto ad alcune categorie:
– fisica: il corpo del bambino non perfettamente funzionante;
– chimica: il corpo del bimbo esegue una serie di processi come digestione, minzione, respirazione;
– filosofia: siamo davanti a un’esistenza che ignora sé stessa, che non ha nessuna immagine di sé, nessuna consapevolezza.
La risposta più semplice, come quando all’inizio di questo pezzo ci siamo chiesti se le poesie di una IA fossero poesie, starebbe nel suggerire che non è vita. Di questo bambino non sappiamo nulla, non abbiamo mai sentito né voce né pianto, se veda o meno – eppure mangia, eppure alcune volte il saturimetro e le altre macchine registrano dei cambiamenti, il suo corpo in determinati momenti ha dei movimenti involontari (e se fossero nonconsci?). Forse la riflessione di Hayles ci aiuta a dire che forse questo bambino non ha una coscienza di sé, ma ha in qualche modo una cognizione, una cognizione che gli viene donata tramite il fatto di essere un assemblaggio cognitivo particolare. Il bambino, forse, non ha la coscienza, quella che abbiamo noi, ma possiede, comunque, una cognizione più ampia e diffusa: quella impensata, quella che tramite le macchine in qualche modo giunge fino a noi. Come consideriamo questa esistenza? Se la simbiosi tra macchine e uomini sarà sempre più netta e decisiva, come dice Hayles, questa vita sarà una vita? Forse nel tempo, con il tempo, i fili, i tubi, gli algoritmi, gli sviluppi futuri della tecnologia porteranno a trovare un modo per entrare nella tautologia di questo bambino – è un bambino tautologico: non sente quindi non può sentire, non parla quindi non può parlare – cioè entreranno in quel nulla che ora ci appare come limite. Come posso definire vita qualcosa che non è vita? Eppure l’impensato, il nonconscio, ci porta a mettere in dubbio la nostra convinzione: e se invece lo fosse?
7. Il grande e importante contributo, per gli studi umanistici, del saggio scritto da Hayles è spingere l’interrogarsi letterario in luoghi non suoi, portando la letteratura al limite ultimo del suo domandarsi, del chiedersi, disperando della risposta, ma accettandone, per ora, il silenzio.