
E il giallo dell’estate?
Fino ad alcuni anni fa, qualche incomprensibile nostalgico si lamentava del fatto che non ci fossero più i tormentoni estivi, quelle canzoni dal ritornello fastidiosamente orecchiabile che per due o tre mesi sentivi dappertutto e poi sparivano nel nulla da cui erano venute. Ma adesso direi KARAOKE GUANTANAMERA che questo non costituisce più un problema.
Nessuna notizia invece – e neanche questa ormai è più una notizia – dal fronte della letteratura: il giallo dell’estate è un topos che sembra scomparso per sempre. Sopravvive come caso di cronaca che infiamma la nostra sete di sangue per quindici giorni. Ma che fine hanno fatto invece quei tomazzi tipo Io uccido di Faletti, che in certi anni letteralmente tutti ci portavamo in spiaggia? O i più maneggevoli Montalbàn, o i comodissimi Camilleri, che avevano l’unico difetto di finire troppo in fretta, massimo due o tre bagni?
Quest’anno di disgrazia 2020 un buon candidato poteva essere Riccardino, l’ultimo Montalbano lasciatoci in eredità da Andrea Camilleri, ma non mi pare sia stato mandato a memoria come i dpcm di Conte. Il mio giallo dell’estate è stato Febbre da fieno di Stanisław Lem, lo scrittore polacco famoso per Solaris, una delle più grandi menti di sempre. Pubblicato nel 1976 con il titolo originale di Katar, è uscito per la prima volta in Italia (grazie a Voland e alla traduzione di Lorenzo Pompeo).
 Credevo fosse un libro di fantascienza – se pure coltissima e incline più alla speculazione che alle battaglie di astronavi, come tutti i capolavori di Lem – e invece l’unico collegamento è dato dal fatto che il protagonista è un’astronauta in pensione. E anche dallo scenario di fondo: un universo parallelo in cui gli attentati terroristici sono all’ordine del giorno, e domina un sistema ossessivo di tecnologie e architetture del controllo (scenario che dall’11 settembre fino all’altroieri sarebbe suonato inquietante e profetico, che tenerezza). Ma per il resto, è una storia che potrebbe svolgersi ai giorni nostri, o meglio in giorni qualunque. Una serie di morti misteriose, che potrebbero come non potrebbero essere collegate, che potrebbero come non potrebbero essere intenzionali. Persone che impazziscono all’improvviso, scienziati che sperimentano nell’ombra, indagini che non devono apparire tali. È una vicenda in cui la verità viene ribaltata più volte, anzi in cui più volte viene messa in discussione l’esistenza stessa di una verità. È tutto un complotto di forze oscure e malefiche? Oppure siamo in balia del caos che ci sballotta e strangola in modo altrettanto crudele, e per di più senza neanche un disegno, un’intenzione, una cattiveria?
Credevo fosse un libro di fantascienza – se pure coltissima e incline più alla speculazione che alle battaglie di astronavi, come tutti i capolavori di Lem – e invece l’unico collegamento è dato dal fatto che il protagonista è un’astronauta in pensione. E anche dallo scenario di fondo: un universo parallelo in cui gli attentati terroristici sono all’ordine del giorno, e domina un sistema ossessivo di tecnologie e architetture del controllo (scenario che dall’11 settembre fino all’altroieri sarebbe suonato inquietante e profetico, che tenerezza). Ma per il resto, è una storia che potrebbe svolgersi ai giorni nostri, o meglio in giorni qualunque. Una serie di morti misteriose, che potrebbero come non potrebbero essere collegate, che potrebbero come non potrebbero essere intenzionali. Persone che impazziscono all’improvviso, scienziati che sperimentano nell’ombra, indagini che non devono apparire tali. È una vicenda in cui la verità viene ribaltata più volte, anzi in cui più volte viene messa in discussione l’esistenza stessa di una verità. È tutto un complotto di forze oscure e malefiche? Oppure siamo in balia del caos che ci sballotta e strangola in modo altrettanto crudele, e per di più senza neanche un disegno, un’intenzione, una cattiveria?
Queste domandine da niente porta a farci Lem con Febbre da fieno. (A pensarci bene, in tempi di attivisti russi avvelenati e teorie del complotto che entrano nelle stanze dei bottoni, uno scenario non di meno inquietante e profetico.)
Ma si è fatta ora di pranzo, torniamo coi piedi per terra, parliamo di cibo. A un certo punto il protagonista, che alloggia all’Hotel Vesuvio di Napoli – non l’ho detto ma l’inizio della vicenda ha luogo in Italia, un fatto che ha meno importanza nel libro che nel nostro discorso – va a mangiare nel ristorante dell’albergo. E cosa succede nel locale partenopeo? «Un cameriere zuppo di sudore mi appoggiò di fronte un Chianti, chiesi un piatto di pasta al pesto e caffè per il thermos». Non sorridete, per favore. Ora qui è chiaro che i casi sono due. O Lem, che aveva una cultura vastissima e trasversale ma magari non era appassionato di storia e geografia dell’alimentazione, ha messo insieme una serie di stereotipi sulla cucina italiana, inanellando due o tre cose famose, senza pensare alle tipicità regionali a cui noi Italians mad at food teniamo così tanto (un vino toscano e una pasta genovese, a Napoli? Per non parlare del caffè nel thermos, poi): come se io m’inventassi che in Ucraina ho mangiato storione alla vodka e pierogi in brodo di barbabietola. Oppure, meno probabile ma non impossibile, Lem era bene informato sul menu del grande albergo napoletano (non ho trovato notizie di viaggi in Italia dello scrittore polacco, ma non vuol dire) e davvero negli anni Settanta vi si poteva gustare un gran mix, un best of di italianità a uso e consumo dei turisti, come in certi locali vicino alle stazioni che offrono spaghetti alla bolognese anche se sei a Trieste o a Catania.
Qual è il punto, allora? Il punto ovviamente non è il povero Stanislao, il punto siamo noi. Noi, o meglio la nostra fissa per la tradizione gastronomica, la cucina tipica, la cultura del food. Fissa che ha le sue ragioni d’essere, eh: che il cibo sia cultura non c’è bisogno neanche più di sottolinearlo, credo. Ma l’ortodossia, la difesa dell’ortodossia, è un campo minato: in fondo non si tratta che di livelli di stereotipo, livelli crescenti e sempre più raffinati, ma sempre di stereotipo. Lem che identifica l’Italia con Napoli-chianti-pesto è il livello 1: absolute beginner, diciamo. Poi ci sono io che dico ma va là, il pesto è un piatto tipico della Liguria, vabbè ormai lo fa pure mia nonna di Torre Annunziata, però insomma: livello 2. Dopo magari arriva il genovese che puntualizza ma quale Liguria, il pesto se non lo fai con il basilico di Pra appena raccolto non può dirsi tale, e poi dev’essere pestato al mortaio, non col minipimer come fa tua nonna, altrimenti è un frullato: livello 3. A chiudere, ma non è detto, sopraggiunge lo storico dell’alimentazione sottolineando che l’uso del basilico in cucina non è attestato prima del Rinascimento e quindi altro che ricetta tradizionale, la pasta al pesto è un piatto moderno, modernissimo.
Ora qui ci sarebbe tutto un discorso da fare su tradizione e innovazione, sul fatto che l’innovazione solo da pochissimo viene percepita come valore positivo, sulla necessità che soprattutto in certi campi abbiamo di appoggiarci sul passato anche quando – soprattutto quando – lo modifichiamo. Ogni tradizione è un’invenzione, il concetto stesso di tradizione è un’invenzione, come diceva quel grande gastronomo di Eric J. Hobsbawm, il creatore della ricetta del secolo breve, per capirci: «Le “tradizioni” che ci appaiono, o si pretendono, antiche hanno spesso un’origine piuttosto recente, e talvolta sono inventate di sana pianta» (L’invenzione della tradizione). Ma è un discorso già accennato altrove, troppo teorico e che ci porterebbe troppo lontano. Preferisco spiegarmi con un esempio. Anzi con un libro.
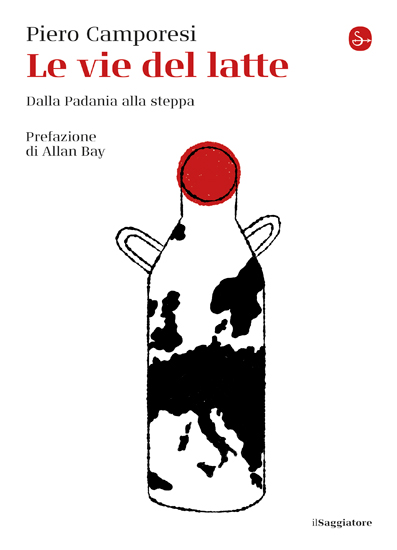 Un altro libro che ho letto quest’estate è Le vie del latte di Piero Camporesi, filologo e antropologo, un gigante: anche questo è un libro uscito per la prima volta anni fa, nel 1996, e ora riproposto dal Saggiatore con prefazione di Allan Bay. Dalla Padania alla steppa è il sottotitolo, e La via lattea è il primo dei tre saggi che lo compongono, distinti ma tenuti insieme da un filo molto solido: lo specifico alimentare dei popoli della pianura padana, e della Mitteleuropa, e dell’Asia centrale.
Un altro libro che ho letto quest’estate è Le vie del latte di Piero Camporesi, filologo e antropologo, un gigante: anche questo è un libro uscito per la prima volta anni fa, nel 1996, e ora riproposto dal Saggiatore con prefazione di Allan Bay. Dalla Padania alla steppa è il sottotitolo, e La via lattea è il primo dei tre saggi che lo compongono, distinti ma tenuti insieme da un filo molto solido: lo specifico alimentare dei popoli della pianura padana, e della Mitteleuropa, e dell’Asia centrale.
La scrittura di Camporesi è meravigliosamente fuori moda: rapsodica, quasi oracolare; eruditissima, per nulla didascalica, e però comprensibile, scorrevole, catchy; non procede per nozioni ma per connessioni, non se ne esce istruiti ma storditi, ammirati, felici. Guardate che incipit: «Ogni liquido è acqua e ogni acqua è latte». Non ha spiegato niente, ha detto tutto.
Nel terzo capitolo o saggio, Dieta padana e Mediterraneo, Camporesi si lancia in un’intemerata contro la dieta mediterranea. A suo dire una moda, peggio un’operazione di marketing, peggio un grimaldello per scardinare le tradizioni regionali e piallare tutta l’Italia sotto un piatto di pasta con la pummarola. La dieta mediterranea nella sua visione è uno strumento del mercato e della globalizzazione, al fianco dei centri commerciali e dei fast food.
Innanzitutto, argomenta Camporesi, la dieta mediterranea neanche esiste: che dallo stretto di Gibilterra al canale di Suez ricorrano gli stessi ingredienti base – vino e olio, pomodoro e formaggi ovini, pesce e impasti a base di grano duro – non vuol dire nulla, non è sufficiente a costruire una unità culinaria, una cultura gastronomica omogenea. Troppe differenze tra gli speziatissimi antipasti mediorientali e le paste ai sughi semplici del sud Italia, per non parlare delle ricette del Nordafrica e del fatto che la cucina tipica di un’isola come la Sardegna quasi non conosca il pesce.
Quindi, scrive Camporesi, la dieta mediterranea è una tradizione inventata, al solo scopo di uniformare i gusti degli italiani, e in particolare di costringere quelli del nord ad abbandonare risotti e polente per abbracciare pizza, rigatoni al basilico, paste industriali al pomodoro. E poi tutti sti benefici per la salute e la longevità, questa dieta a base di grassi vegetali non è detto che li porti, chiedetelo a Manzoni, chiedetelo a Casanova, divoratori di polpette e burro che hanno campato fino a 80, 90 anni, sostiene Camporesi. Fino a spingersi ad affermazioni dal vago retrogusto leghista: «Il mediterraneo pesce spada ormai arriva dappertutto e si è acclimatato (come la mafia) anche nel Settentrione».
Adesso. Io non mi voglio mettere in competizione con Camporesi, sarebbe come invitare Bolt a fare una corsetta. Penso però che certe prese di posizione contengano una trappola dovuta, appunto, alla prospettiva. Una prospettiva senz’altro curiosa, e che oggi fa un po’ sorridere, è quella per cui la dieta mediterranea viene messa “nel lato oscuro” insieme alla globalizzazione, al cibo industriale, agli alimenti in scatola, ai supermercati e ai fast food, quando ora la maggior parte di noi non avrebbe dubbi a infilarla nella squadra dei “buoni”, accanto a Slow Food, al biologico, alle piccole coltivazioni, alla biodiversità eccetera (e lo sappiamo benissimo, che queste come quelle sono semplificazioni, che pescare un tonno fa più male a noi e al mondo che consumare un burro d’alpeggio in malga).
Penso che, okay, il marketing e il condizionamento dell’industria e di Big Food, che riesce a piegare i nostri gusti alla sua convenienza: io sono il primo a notare quanto la nostra vita e le nostre scelte siano eterodirette, in generale. Ma insomma, vogliamo negare completamente il libero arbitrio gastronomico? Dire che la diffusione di alcuni piatti, e il lento declino di altri, siano frutto solo ed esclusivamente di un complotto, e non dipendano dalla bontà, o almeno dalla maggiore adattabilità ai gusti e alle circostanze? Come dice il mio amico e gastro-letterato Federico di Vita, se il mondo è pieno di pizzerie, mentre a sud del Rubicone non c’è neanche una polenteria, un motivo ci sarà.
Ma soprattutto, penso che Camporesi sia in questo caso caduto nella trappola della tradizione, applicando nell’esaltazione della dieta padana la stessa fallacia che rimprovera ai cantori della dieta mediterranea. Che cosa sarebbe questa dieta padana, in effetti? Certo, burro e birra vs olio e vino. Carne vs pesce? Già qui qualcosa traballa. Grano vs altri cereali? Mah. Come al solito quando si parla di tradizioni, di cucina tipica di un luogo, la domanda è: cucina tipica, ma di quando? Per esempio, prima o dopo il 1400? È risaputo, e lo racconta lo stesso Camporesi, che il riso non fu introdotto in maniera massiccia nella pianura padana fino alla seconda metà del XV secolo: quindi fino al rinascimento niente risotti, e anche dopo, probabilmente, per qualche altro secolo solo zuppe di riso nel latte o altri pastoni che oggi riterremmo immangiabili.

dipinto preparatorio per l’opera “Polenta a fuoco duro”, 1922
Oppure, la mitica polenta. È noto che il mais viene dal nuovo mondo. Ma l’usanza di cuocere una poltiglia semi solida a base di farina risaliva almeno all’epoca romana, se non prima: venivano usati dei macinati di cereali all’epoca diffusissimi nel nord, come miglio, panìco, sorgo, e anche di non cereali come fave e castagne. Migliaccio si chiamava quella di miglio, panissa o paniccia quella di panìco: oggi sono sopravvissuti solo i nomi, che però indicano tutt’altri piatti. Solo dalla fine del secolo XVII il granturco o formentone un po’ alla volta rimpiazzò le altre farine (e fu una benedizione e una maledizione, come dice Camporesi, perché tanti ne salvò dalla fame, ma altrettanti ne piagò con la pellagra, una malattia dovuta alla carenza di vitamina B, perché dalle Americhe il mais era arrivato senza la ricetta, cioè non ci s’era preoccupati di osservare come i nativi trattassero il cereale, mentre quel trattamento a base di calce – detto nixtamalizzazione – è fondamentale, oltre che per ragioni tecniche, ossia avere una farina più lavorabile, per rendere disponibili alcuni nutrienti essenziali: altro che disturbi intestinali, è stata questa la vera maledizione di Montezuma?).
«Milano fu probabilmente la prima grande città del Settentrione ad adottare e gustare l’amerindo tomatl, ma la prima anche a “tradire” gli ortaggi classici delle sue campagne, i legumi tradizionali». Ecco il tradimento della tradizione. Ma quali erano poi ‘sti legumi tradizionali? Leggiamo nomi bellissimi: basgian, erbion, fasoeu, lautig, scisger. Ovvero, in ordine di apparizione: fave, piselli, fagioli, lenticchie, ceci. Vale a dire, i legumi centrali nell’alimentazione del sud Italia, la cosiddetta carne dei poveri, insomma: uno dei pilastri della dieta mediterranea. Legumi che infatti, insieme ai cereali come grano orzo e farro, sono stati le prime coltivazioni quando 10.000 anni fa è stata “inventata” l’agricoltura in Mesopotamia. Davvero: quando si parla di tradizioni gastronomiche, a volte conta più il quando che il dove. Camporesi: «Che cosa direbbero i Pugliesi, i Campani, i Siciliani se venissero a scoprire la filiazione delle loro cucine da quella magrebina e medio-orientale?». Mah, io personalmente sono solo contento, e voi?
Ma chiudiamo rifacendoci la bocca, e tornando alla letteratura: con il meglio che Camporesi sa darci, una pagina deliziosa. Nel saggio di mezzo parla di Francesco Petrarca, Il padano Petrarca, il poeta che, negli ultimi anni di una lunga e girovaga vita, decise di stabilirsi nella pianura. E un po’ si adattò, un po’ no: soprattutto ai cibi, agli eccessi di carne e grasso cui la cucina locale lo invitava, lui morigerato e amante delle verdure, quasi vegetariano, o pitagorico come si diceva allora. C’è la descrizione di una festa, una cena con sette portate, tutte caratterizzate da una sovrabbondanza che oggi diremmo barocca, e da accostamenti arditi: maiale con storione, quaglie con trote, anatre con carpe. Ma soprattutto dall’accostamento fra i gusti acido e dolce, che ancora oggi sono caratteristici di cucine esotiche più che della nostra. Qui Camporesi fa un parallelo tra l’agrodolce in cucina e la figura retorica dell’ossimoro in letteratura, è un’agnizione. Non saprei come riassumerlo, quindi:
L’agrodolce non gli era mai piaciuto, eppure anche lui si era stranamente abbandonato al gusto del suo tempo, alla precettistica invisibile alla quale obbedivano, senza nemmeno accorgersene, ars dictandi e ars coquinaria. Aveva abusato d’accostamenti verbali peregrini e contraddittori (vere spezie piccanti), coniugando lo sciocco con l’acuto alla stessa maniera dei cuochi scellerati, criminali maestri nell’amalgamare aceto e zucchero, il mielato con l’asprigno; aveva costruito ossimori su ossimori, mescolando in nozze stranamente assortite termini ripugnanti fra loro come «viva morte» o «dilettoso male». Incominciava a capire che l’agrodolce rappresentava la versione culinaria, il tropo commestibile della figura ossimorica. Se lui trovava repellente l’agrodolce – e a questo punto si sentì avvolto da una malsana vampa di calore – come avrebbero apprezzato i mangiatori di versi, i consumatori di metafore le sue male assortite acutezze? (…) Anche lui, giullare di lusso, ne aveva, ahimè, composte di quelle lunatiche e cervellotiche frottole: «De’ passati miei anni piango et rido… / Del presente mi godo, et meglio aspetto, / Et vo contando gli anni, et taccio e grido…».
Che dire? Viva il latte di Camporesi e viva il pesto frullato di mia nonna, viva il Chianti di Lem e l’agrodolce di Petrarca. Viva l’Italia? Purché se magna…

