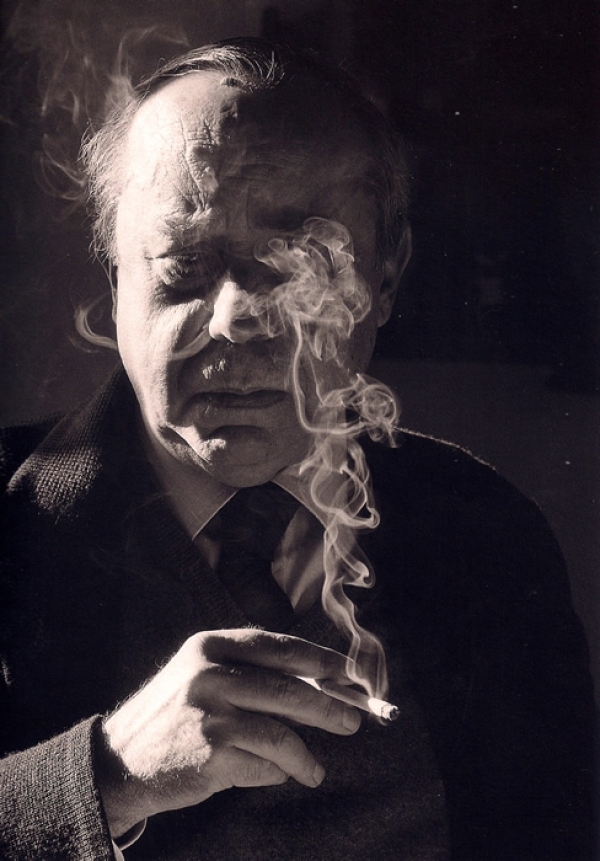
Sul centenario di Sciascia c’è un’innocente impostura.
Svelata da Salvatore Picone e Gigi Restivo[1], la recente rivelazione riguarda l’incongruenza fra la dichiarazione della nascita l’8 gennaio 1921 all’ufficiale di stato civile di Racalmuto di Pasquale Sciascia, padre dello scrittore, e quella per l’iscrizione di Leonardo alla scuola elementarem dove si legge 31 dicembre 1920.
Non sappiamo se il paradosso fosse conosciuto dallo scrittore. Certo è che in Occhio di capra lui stesso rivela come fosse pratica frequente in Sicilia, almeno fino alla fine della seconda guerra mondiale, quella di «Rubare un anno al re»:
Arrubari un annu a lu Re. Si diceva quando un bambino nato negli ultimi giorni di dicembre veniva denunciato all’ufficio di stato civile come nato nei primi del nuovo anno: sicché sarebbe andato alla leva militare con un anno di ritardo.[2]
Ma la Sicilia, si sa, ha sempre fatto emergere proprio nelle pagine letterarie le sue contraddizioni e i suoi paradossi, come afferma Italo Calvino in una lettera a Sciascia del 10 novembre 1965, quando gli arriva il dattiloscritto di A ciascuno il suo:
E stavolta ti dico questo: da un po’ di tempo m’accorgo che ogni cosa nuova che leggo sulla Sicilia è una divertente variazione su un tema di cui ormai mi sembra di sapere già tutto, assolutamente tutto. Questa Sicilia è la società meno misteriosa del mondo: ormai in Sicilia tutto è limpido, cristallino: le più tormentose passioni, i più oscuri interessi, psicologia, pettegolezzi, delitti, lucidezza, rassegnazione, non hanno più segreti, tutto è ormai classificato e catalogato.[3]
Dalla risposta di Sciascia non traspare disappunto; anzi, le affermazioni sulla Sicilia gli sembrano condivisibili e accendono le sue riflessioni. Del resto, ogni lettera di Sciascia al suo consigliere e mentore Calvino rivela disponibilità al confronto e alla discussione critica[4]:
della Sicilia si sa ormai tutto, assolutamente tutto; la letteratura ne ha dato un’immagine nitida, compiuta (che è anche la gloria della letteratura siciliana, ma al passato). Però questa compiutezza e chiarezza non vengono anche dal fatto che la Sicilia è, nella sua realtà, morta? L’ipotesi della desertizzazione, che Compagna formula per gli anni Novanta, qui è già in atto. Quando di domenica vado al mio paese veramente trovo il deserto; e così è in tutti i paesi dell’interno. Ormai c’è più Sicilia a Parigi che a Racalmuto, nella Torino razzista che nella Palermo mafiosa. Bisogna avere il coraggio di seguire questa Sicilia che sale verso il Nord, per trovare ragione più valida (almeno per oggi) di scrivere. Restando nel deserto, altro non abbiamo che il piacere, come tu dici, e l’amarezza, come io aggiungo, di combinare all’infinito un numero finito di pezzi. E allora, giuocare per giuocare, non è meglio cercare i pezzi negli archivi?[5]
Conscio che il prototipo per eccellenza rimane la Storia della colonna infame di Manzoni, Sciascia si serve dei «pezzi negli archivi» non per reclamare la giustizia non ottenuta dal magistrato, ma come humus per quel «riscatto» e quello «strazio»[6] che è proprio della riscrittura, tant’è che «anche quando la verità è nota, e l’indizio è lì a confermarla, non solo l’andamento della ricerca è deviato e tortuoso ma l’esito è lasciato aperto, si badi, aperto non sul dubbio tollerante, ma sulla ‘ambigua’ verità».[7]

Per questo Sciascia non ama «coloro che, come Mallarmé, ‘aggiungono oscurità’», benché lui stesso riconosca che «anche di tante oscurità mi sono nutrito. Lo scrivere è imprevedibile quanto vivere»[8]. Non a caso, Antonio Di Grado ci ricorda che «Sciascia parte sempre più da lontano per catturare una verità sempre più sfumata e sempre più iscritta nel sapere letterario».[9]
Al bivio tracciato da Pirandello fra lo «stile di parole» di D’Annunzio e «lo stile di cose» di Verga, la strada intrapresa da Sciascia è quest’ultima, perché gli interessa la «costruzione da dentro» e le cose che «nascono e vi si pongono innanzi sì che voi ci camminate in mezzo, vi respirate, le toccate: terra, pietre, carne, quegli occhi, quelle foglie, quell’acqua».[10]
Basterebbe osservare l’incipit di Una storia semplice per capire come «lo stile di cose» emerga dal susseguirsi di oggetti reali: il telefono che suona, i roghi dei mobili vecchi, le poche falegnamerie rimaste in città, gli uffici della polizia illuminati. Sono tutti elementi che «si pongono innanzi» tangibili, ma narrati con diverse variazioni tonali, quasi parodiche, che ne isolano le reciproche relazioni.
Il telefono squillante è raccontato in uno stile burocratico da verbale di polizia (a), i mobili arsi ci appaiono in un tripudio primordiale di festa nei quartieri popolari (b), la scomparsa delle botteghe dei falegnami si incunea come una sciabolata sociologica sulla fine dell’artigianato (c) e infine, le stanze del comando di polizia deserte, seppur illuminate «per dare l’impressione» di una sorveglianza attiva, chiudono il paragrafo sui toni dell’ironia (d):
La telefonata arrivò alle 9 e 37 della sera del 18 marzo, sabato, vigilia (a) della rutilante e rombante festa che la città dedicava a san Giuseppe falegname: e al falegname appunto erano offerti i roghi di mobili vecchi che quella sera si accendevano nei quartieri popolari, (b) quasi promessa ai falegnami ancora in esercizio, e ormai pochi, di un lavoro che non sarebbe mancato (c). Gli uffici erano, più delle altre sere a quell’ora, quasi deserti: anche se illuminati, l’illuminazione serale e notturna degli uffici di polizia tacitamente prescritta per dare impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza si vegliava (d). [11]
Si pensi a quella «rutilante e rombante festa» di San Giuseppe nei quartieri popolari che suggella in due soli aggettivi, e quindi con una grande capacità di sintesi, il senso del saggio Feste religiose in Sicilia scritto anni prima. Lì, Sciascia spiegava che «è tutto, tranne che una festa religiosa», piuttosto è «innanzi tutto, una esplosione esistenziale»: solo nelle feste «il siciliano esce dalla sua condizione di uomo solo […] per ritrovarsi parte di un ceto, di una classe, di una città»[12].
E non solo esplosione esistenziale: «Questo modo, assolutamente irreligioso, di intendere e professare una religione – precisava ancor meglio Sciascia – che pure è fermamente, rigorosamente e minuziosamente codificata in ogni atto del culto interno ed esterno, ha radice in un profondo materialismo, in una totale refrattarietà a tutto ciò che è mistero, invisibile rivelazione, metafisica»,[13] tanto che della «cultura popolare di grado infimo, Gramsci […] faceva il punto di partenza per una spiegazione del mondo pirandelliano».[14]
L’ironia chiude il primo paragrafo di Una storia semplice, una dote appropriata a giudizio di Brancati per gli scrittori della Sicilia orientale, ben distinti dagli scrittori occidentali «gravi e metafisici»[15]. Erano, quest’ultimi, i notabili di Caltanissetta dediti a particolari speculazioni filosofiche e dotati di tutte le virtù «tranne la semplicità»[16], come lascia intendere Brancati, che in quella città aveva insegnato.

Eppure, dalla sua agrigentina contrada La Noce di Recalmuto, Sciascia sembra bilanciarsi nel centro esatto di questa ilare dicotomia geografica e risentire di entrambe le anime.
Da un lato ci sono i suoi racconti d’indagine, che partono sempre da un’apparente chiarezza, tanto che s’intuisce facilmente chi ha commesso il delitto, ma finiscono per inoltrarsi, poi, nel mistero e nella riflessione filosofica e politica sulla giustizia. Dunque, solo all’apparenza dei gialli: meglio sarebbe definirli racconti “problematici” secondo l’espressione di Giuseppe Petronio.
Dall’altro lato, c’è l’ironia tanto cara a Voltaire, Pirandello e Brancati, tre autori sempre di riferimento, e che diventa sia un utile strumento nel disvelamento del reale (ne è un esempio evidente Il consiglio d’Egitto), sia una privilegiata strategia narrativa, a partire dai singoli paragrafi come abbiamo visto nell’incipit di Una storia semplice.
 Scritto direttamente a macchina nel 1989, durante dieci giorni milanesi e dieci palermitani intervallati da sedute di chemioterapia e poi di dialisi, Una storia semplice avrebbe dovuto essere di 300 cartelle, ma finisce per concentrare l’opera in una cinquantina di pagine, come un ‘calepino’ «da tenere in tasca, un taccuino»[17], secondo il pensiero del brigadiere Lagandara, che si trova di fronte al volume, invece corposo e pesante, di un antico Calepinus nella soffitta del morto assassinato.
Scritto direttamente a macchina nel 1989, durante dieci giorni milanesi e dieci palermitani intervallati da sedute di chemioterapia e poi di dialisi, Una storia semplice avrebbe dovuto essere di 300 cartelle, ma finisce per concentrare l’opera in una cinquantina di pagine, come un ‘calepino’ «da tenere in tasca, un taccuino»[17], secondo il pensiero del brigadiere Lagandara, che si trova di fronte al volume, invece corposo e pesante, di un antico Calepinus nella soffitta del morto assassinato.
Centomila copie vedranno la stampa in sole tre settimane, ma il giorno in cui il libro approda in libreria è proprio il 20 novembre 1989. Lo stesso in cui Sciascia muore.
La storia inizia con il ritorno al natio Monterosso sui Monti Iblei, dopo quindici anni in Scozia, del diplomatico Giorgio Roccella, per recuperare da una dimenticata cassapanca in soffitta alcune lettere che Garibaldi aveva scritto al bisnonno, e altre indirizzate al nonno da Pirandello (autore di cui Sciascia terrà un ritratto in ogni casa in cui abiterà). In soffitta scopre però, anche un quadro rubato, dipinto che potrebbe alludere alla scomparsa nel 1969 di una tela di Caravaggio dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo. All’insaputa di Roccella, nell’abitazione è stato istallato anche un telefono e il diplomatico se ne serve per chiamare la polizia, che arrivata solo l’indomani mattina lo trova morto con un colpo di pistola alla tempia. Si lascia intuire al lettore fin dal secondo capitolo che il Roccella possa aver aperto fiduciosamente a un poliziotto e, in effetti, l’assassino è il commissario, membro insospettabile di una banda criminale. A scoprirlo è il brigadiere Lagandara, seguendo i preziosi suggerimenti del vecchio amico di Roccella, il professore in pensione Carmelo Franzò.
Evidenziata subito «l’irriducibile disparità di punti di vista fra le due istituzioni: l’arma dei carabinieri, il corpo di polizia»[18], appare evidente che per il commissario che quella morte sia una «storia complicata»,[19] per il questore al contrario «un caso semplice»[20].
Di fatto, di “semplice” c’è ben poco in questo racconto testamentario, a cominciare da quella Festa di San Giuseppe che è la prima spia del tema complesso della paternità, che corre sotterraneo.
Il primo a comparire è il padre biologico di Lagandara, un bracciante morto sul lavoro che ha trasmesso al figlio la voglia di “elevarsi” dalla propria condizione: «Il brigadiere Antonio Lagandara era nato in un paese contadino tanto vicino alla città che ormai se ne poteva considerare parte. Il padre, bracciante che aveva saputo elevarsi al rango di potatore – esperto, ricercato –, era morto, strapiombando da un alto ciliegio che stava rimondando dai seccumi, che lui era all’ultimo anno di un corso di economia e commercio»[21].
Con Giorgio Roccella entra in scena il padre prescelto per affinità elettiva: «Con mio padre spesso pensavamo di tornare, di far vita qui». «Con tuo padre!» disse sarcasticamente la donna. «Vuoi dire che non era mio padre?… Guarda: le madri non si possono scegliere, che io di certo non ti avrei scelto… D’altra parte, tu sicuramente non mi avresti scelto come figlio… Ma i padri si scelgono: e io ho scelto Giorgio, l’ho amato, piango la sua morte. Era mio padre»[22]. Una scelta perentoria, che non viene motivata. Qual era la statura morale di Roccella? Di lui sappiamo solo che è nato il 14 gennaio 1923, data che curiosamente coincide con la nascita della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (e in Sciascia nessuna coincidenza è casuale), cioè le mussoliniane camicie nere.
Il cognome Roccella, poi (in francese Rochelle), potrebbe riecheggiare per assonanza, come ha ipotizzato Paolo Squillacioti, Pierre Drieu de la Rochelle morto nel 1945. Autore di Socialisme fasciste e aderente alla Repubblica di Vichy, era stato un simpatizzante del nazismo. Dunque, la scelta di quel cognome potrebbe alludere a una paternità politica di destra, liberamente scelta dal figlio di Roccella.
Infine, c’è il padre della comunità, pronto però a tradirla, che in questo caso è «Padre Cricco – bell’uomo, alto e solenne nella veste talare – affermò che mai aveva avuto le chiavi: guardava da fuori la casa di città e il villino: e le sue notizie si limitavano ad assicurare che erano ancora all’impiedi, senza crepe vistose e senza irreparabili erosioni»[23].
La complicità del prete nel furto del quadro e nell’uccisione del capostazione lampeggia per caso nell’ultima pagina del racconto e resterà impunita, come del resto avviene in tutti i libri di Sciascia. L’unico che muore in Una storia semplice è il commissario corrotto, ucciso per legittima difesa da Lagandara, che tuttavia sarà costretto dai superiori a dichiarare un colpo inavvertitamente partito della pistola durante la pulizia, così che le responsabilità del commissario rimangono insabbiate.

Il lettore abituale di Sciascia sa che i suoi racconti d’inchiesta innescano la riflessione politica e filosofica sulla giustizia e non è irritato dalla mancanza di punizione dei colpevoli che invece è prevista nei racconti polizieschi.
Tutto è accennato. Mai esplicitato. E anche un solo dialogo scarnificato può bastare per raccontare le storture e i mali dell’Italia, a partire dalle sue posizioni apicali:
Il magistrato si era intanto alzato ad accogliere il suo vecchio professore.
«Con quale piacere la rivedo, dopo tanti anni!».
«Tanti: e mi pesano» convenne il professore.
«Ma che dice? Lei non è mutato per nulla, nell’aspetto».
«Lei sì» disse il professore con la solita franchezza.
«Questo maledetto lavoro… Ma perché mi dà del lei?».
«Come allora» disse il professore.
«Ma ormai…».
«No».
«Ma si ricorda di me?».
«Certo che mi ricordo».
«Posso permettermi di farle una domanda?… Poi gliene farò altre, di altra natura… Nei componimenti d’italiano lei mi assegnava sempre un tre, perché copiavo. Ma una volta mi ha dato un cinque: perché?».
«Perché aveva copiato da un autore più intelligente».
Il magistrato scoppiò a ridere. «L’italiano: ero piuttosto debole in italiano. Ma, come vede, non è poi stato un gran guaio: sono qui, procuratore della Repubblica…».
«L’italiano non è l’italiano: è il ragionare» disse il professore.
«Con meno italiano, lei sarebbe forse ancora più in alto».
La battuta era feroce. Il magistrato impallidì. E passò a un duro interrogatorio.[24]
Serrato e incisivo è lo scontro di vedute tra Franzò e l’ex allievo. Un dialogo che non ha interlocuzione, né partecipazione umana: i due rimangono sempre più distanti dopo ogni battuta e nessuna di queste è mai esaustiva. La successiva spiega qualcosa della precedente, ma non tutto, come se s’innescasse fra i due un’implacabile e inesausta quête.
Non è difficile cogliere dietro a Carmelo Franzò un alter ego di Sciascia, visto che è costretto alla «periodica e inalienabile dialisi, pena per giorni l’intossicata immobilità»[25] e visto che come lui ama i libri e la limpida comunicazione delle idee («l’italiano non è l’italiano: è il ragionare», dice nel dialogo).
Come in un prisma, Sciascia proietta qualcosa di sé anche in altri personaggi.
Ad esempio, la vicenda del rappresentante di case farmaceutiche, venuto dal Nord con una Volvo, e che per aiutare un capotreno diventa testimone ignaro dell’assassinio del capostazione, s’ispira a un evento capitato realmente a Sciascia, mentre in auto con la famiglia stava viaggiando da Palermo a Racalmuto. Avevano trovato un treno bloccato in mezzo alla campagna da uno stop e il capotreno li aveva pregati di andare alla vicina stazione di Campofranco per vedere se il capostazione si fosse addormentato, cosa che realmente era successa.
Anche in Lagandara si proietta l’alter ego dello scrittore, come capiamo nel momento in cui stila il rapporto dell’omicidio Roccella: «curiosamente, il fatto di dover scrivere delle cose che vedeva, la preoccupazione, l’angoscia quasi, dava alla sua mente una capacità di selezione, di scelta, di essenzialità per cui sensato ed acuto finiva con l’essere quel che poi nella rete dello scrivere restava. Così è forse degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie: nonostante il liceo, l’università e le tante letture»[26].
Nella “rete dello scrivere” di Sciascia restano quei «minuti avvenimenti, tanto minuti da essere a volte impercettibili, che in un moto di attrazione e aggregazione corrono verso un centro oscuro, verso un vuoto campo magnetico in cui prendono forma»[27] e trovano necessità. È un’idea che desume da Savinio: «bisogna far caso al caso, alle corrispondenze e coincidenze le più vaghe e quasi impercettibili».[28]
Sono comunque, corrispondenze sempre rivelatrici.
E talvolta diventano casualità profetiche. Basterebbe pensare al 21 settembre 1990. È trascorso quasi un anno dalla morte di Sciascia e dalla pubblicazione di Una storia semplice, in cui si raccontava dell’ignaro testimone alla guida di una Volvo bianca.
Sulla statale per Agrigento, a pochi chilometri dalla casa di Sciascia, Rosario Livatino viene ucciso: unico testimone dell’uccisione del giudice “ragazzino”, un commesso viaggiatore su una Volvo.
Note
[1] S. Picone, G. Restivo, Dalle parti di Leonardo Sciascia, Zolfo, Milano 2021.
[2] L. Sciascia, Occhio di capra, Einaudi, Torino 1984, p. 27.
[3] I. Calvino, Lettere 1940-1985, a cura di L. Baranelli, introduzione di C. Milanini, Mondadori, Milano 2000, p. 897.
[4] Cfr. V. La Mendola, Leonardo Sciascia e la scrittura delle idee: l’illuminismo siciliano in casa Einaudi, in Libri e scrittori di via Biancamano, EDUCAT, Milano 2009, pp. 163-203.
[5] Lettera di Sciascia a Calvino del 22 novembre 1965 è stata pubblicata su «La Stampa – Tuttolibri» il 25 novembre 1989, poi in M. Collura, Il maestro di Regalpetra, La Nave di Teseo, Milano 2019, PDF e-book.
[6] «Tutto è legato, per me, al problema della giustizia: in cui si involge quello della libertà, della dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo. Un rapporto che si assomma nella scrittura, che nella scrittura trova strazio e riscatto. E direi che il documento mi affascina – scrittura dello strazio – in quanto entità nella scrittura, nella mia scrittura, riscattabile», L. Sciascia, 14 domande a Leonardo Sciascia, a cura di C. Ambroise, in Opere 1956-1971, Milano, Bompiani1989, pp. XIII.
[7] G. Giarrizzo, «Tutta un’impostura. La storia non esiste...», in La teatralità nelle opere di Leonardo Sciascia, Palermo, Assessorato Regionale ai Beni Culturali, 1987, p. 6.
[8] L. Sciascia, 14 domande… cit., p. XV.
[9] A. Di Grado, Leonardo Sciascia, Pungitopo, Marina di Patti, 1986, p. 26.
[10] Il Discorso di Catania dedicato a Verga di Pirandello viene utilizzato in L. Sciascia, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Sellerio, Palermo1989, p. 158.
[11] L. Sciascia, Una storia semplice, Adelphi, Milano 1989, p. 9.
[12] L. Sciascia, Feste religiose in Sicilia, in La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, Einaudi, Torino 1970, p. 199.
[13] Ivi, p. 193.
[14] Ibidem.
[15] V. Brancati, Lettera al Direttore. Gli amici di Nissa, «Omnibus», 5 marzo 1938, poi in Il Borghese e l’immensità. Scritti 1930-1954, a cura di S. De Feo e G.A. Cibotto, Bompiani, Milano 1973, pp. 81-84.
[16] Ibidem.
[17] Sciascia, Una storia semplice cit., p. 18.
[18] Ibidem.
[19] Ivi, p. 31.
[20] Ivi, p. 24.
[21] Ivi, p. 40.
[22] Ivi, p. 46.
[23] Ivi, p. 49.
[24] Ivi, p. 44.
[25] Ivi, p. 30.
[26] Ivi, p. 15.
[27] Sciascia, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo 1978, PDF e-book.
[28] Sciascia, Cruciverba, in Opere cit., II, p. 1204.

