
Nell’aprile 2019 viene diffusa la prima immagine di un buco nero, localizzato a 55 milioni di anni luce dalla Terra nella galassia M87. È un grosso ammasso di gravità che non emette luce e che anzi risucchia ogni particella, come aveva spiegato negli anni Sessanta il fisico John Archibald Wheeler, sviluppando un’ipotesi teorica di Einstein. L’immagine nasce per computer graphics dalla sincronizzazione e dall’incrocio dei dati di otto radiotelescopi, distanziati sul globo terrestre, e viene battezzata Põwehi, cioè “sorgente oscura di creazione senza fine”.
Buco nero di Auschwitz è uno degli ultimi articoli di Primo Levi pubblicato su «La Stampa» il 22 gennaio 1987 e, se anche il titolo fosse redazionale, nel testo la definizione è comunque presente, là dove Levi afferma che Treblinka e Chelmno «non fornivano lavoro, non erano campi di concentramento, ma ‘buchi neri’ destinati a uomini, donne e bambini colpevoli solo di essere ebrei». La soppressione avveniva con una tecnologia industriale, che ingoiava tutti i nuovi arrivati come il vortice a spirale di un buco nero.
Il termine “buco nero” è una metafora coniata da Wheeler nel 1967, ma Levi la ricontestualizza in un ambito extra-scientifico, esattamente come aveva fatto con gli elementi della tavola di Mendeleev in Il sistema periodico, quando il Nascosto, lo Straniero, l’Inoperoso, il Pesante, il Luminoso, l’Impervio ridiventano nei 21 racconti paradigmatici caratteri umani.
I concetti chimici mantengono la loro esattezza scientifica e al tempo stesso assumono un valore polisemico nella prosa. Si dice, per limitarci a un solo esempio, che lo Zinco sia arrendevole agli acidi, ma che diventi resistente quando è molto puro. Dalla reazione dello zinco, elemento chimico, parte la macchina narrativa di Levi, che allarga la visione a un elogio dell’impurezza:
Perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vogliono le impurezze, e le impurezze delle impurezze: anche nel terreno, come è noto, se ha da essere fertile. Ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale e di senape: il fascismo non li vuole, li vieta e per questo tu non sei fascista; vuole tutti uguali e tu non sei uguale. Ma neppure la virtù immacolata esiste e se esiste è detestabile. (Levi 2016, I, pp. 884-885).
Non saremmo capaci di pensare al puro e all’impuro, al fascismo e ad Auschwitz con tanta «misteriosa chiarezza», dice Domenico Scarpa, se non avessimo i libri di Primo Levi. In modo simile, potremmo dire che se la scienza in Levi cerca di dare ordine al disordine, la scrittura diventa capace di farci vedere l’indistinto, anche nei suoi contrasti irriducibili e nella contraddittorietà dell’umano, rendendocelo però memorabile.
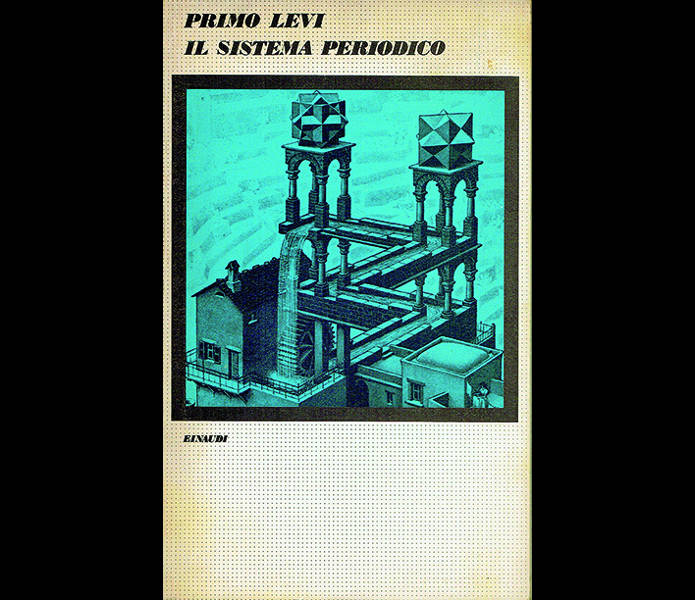
Non è un caso che la cifra stilistica più ricorrente in Levi sia l’ossimoro, e questo perché rimane sempre una contraddizione mai pacificata fra la disperata esperienza umana e l’esorcismo del pensiero razionale e scientifico contro quei vortici oscuri che ingoiano.
Proviamo a fare un’esemplificazione di queste idiosincrasie.
Nnei primi anni Settanta Levi comincia a interessarsi alle ricerche di Stephen Hawking, legge sulla rivista «Le Scienze» (traduzione di «Scientific American»), di cui sia Levi che Calvino erano assidui lettori, un articolo divulgativo The Search for Black Holes di Kip S. Thorne e sull’onda di questa suggestione scrive Le stelle nere, poesia inserita nel 1975 in L’osteria di Brema:
Nessuno canti più d’amore o di guerre.
L’ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto;
Le legioni celesti sono un groviglio di mostri,
L’universo ci assedia cieco, violento e strano.
Il sereno è cosparso d’orribili soli morti,
Sedimenti densissimi d’atomi stritolati.
Da loro non emana che disperata gravezza,
Non energia, non messaggi, non particelle, non luce;
La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso,
E tutti noi seme umano viviamo e moriamo per nulla,
E i cieli si convolgono perpetuamente invano.
(Levi 2016, II, p. 706).
Fin dall’incipit l’armonia del cosmo è rotta e ci sono «orribili soli morti, / sedimenti densissimi d’atomi stritolati», finché i versi si chiudono su un amarissimo doppio avverbio «E i cieli si convolgono perpetuamente invano». A pochi anni di distanza da questa desolante costatazione, Levi inserisce l’articolo di Thorne come capitolo finale in La ricerca delle radici (1981), un’antologia degli autori che più avevano contato nella sua formazione, dandogli un titolo amaro: Siamo soli. Nella breve premessa, però, come per un improvviso ossimoro psicologico, Levi apre alla «nobiltà» del raziocinio e alla speranza, aspetti che il titolo non avrebbe lasciato immaginare:
se la mente umana ha concepito i buchi neri, ed osa sillogizzare quanto è avvenuto nei primi attimi della creazione, perché non dovrebbe saper debellare la paura, il bisogno e il dolore? (Levi 2016, II, p. 229).
Questa complessità poliedrica spicca anche dalla tessitura linguistica e sintattica dei suoi testi. C’è, ad esempio, una polarità forte fra l’abbondanza lessicale di terne aggettivali e di ossimori da un lato e la punteggiatura dall’altro, che tenta di incatenare le parole in una rigorosa scacchiera logica come avviene negli articoli scientifici: una punteggiatura «estremamente ricca, analitica, articolata, – dice Mengaldo – verrebbe da dire ‘manzoniana’» (Mengaldo 1991, p. 338).
Basterebbe estrapolare da Vanadio (Il sistema periodico) un breve passo per capire la ricchezza di terne puntellate da virgole e punti che compaiono nel momento in cui si parla dello scambio epistolare con il doktor Müller, chimico tedesco incontrato nel laboratorio alla Buna ad Auschwitz e ritrovato da Levi realmente a decenni di distanza:
una lettera umile, calda, cristiana, di tedesco redento; una ribalda, superba, glaciale, di nazista pervicace. Ora questa storia non è inventata, e la realtà è sempre più complessa dell’invenzione: meno pettinata, più ruvida, meno rotonda. È raro che giaccia in un piano. (Levi 2016, I, p. 1021).
Nessun sistema difensivo, come è appunto in Levi la punteggiatura, e nessuna diga formale, come lo scrivere chiaro, può annientare le zone d’ombra che riaffiorano perturbanti, simili al riemerge dal nulla di quel chimico tedesco. Come lui stesso dice è raro che la realtà «giaccia su un piano».
Eppure, quando a sedici anni Primo Levi aveva letto L’architettura delle cose di Sir William Bragg ed era rimasto «invaghito dalle cose chiare e semplici» dette dal Premio Nobel, prendendo subito la decisione di studiare chimica, aveva percepito che quelle parole lo spingevano «molto lontano, verso il mondo minuscolo degli atomi e verso il mondo sterminato degli astri», come racconta in La ricerca delle radici (Levi 2016, II, p. 37).
Quella prima impressione lo avrebbe sorretto per anni nella consapevolezza che l’obiettività scientifica e la valenza morale della chiarezza linguistica sarebbero sempre stati strumenti necessari per contrapporsi alla realtà caotica della materia e agli inganni del fascismo:
come poteva ignorare che la chimica e la fisica di cui ci nutrivamo – dirà in Ferro –, oltre che alimenti di per sé vitali, erano l’antidoto al fascismo che lui ed io cercavamo, perché erano chiare e distinte e ad ogni passo verificabili, e non tessuti di menzogne e di vanità, come la radio e i giornali? (Levi 2016, I, p. 891).
Con il trascorrere degli eventi, Primo Levi sente quanto in ogni momento un vortice oscuro possa inghiottire all’istante tutto e come Un passato che credevamo non dovesse tornare più possa sempre riemergere:
Ogni tempo ha il suo fascismo: se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col terrore dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l’ordine, ed in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti («Corriere della sera» 8 maggio 1974).
Proprio negli stessi anni Settanta anche Calvino si stava interessando alle ricerche di Stephen Hawking sui buchi neri e rifletteva sulla violenza. L’implosione (1984) ha addirittura un incipit shakespeariano «Esplodere o implodere […] questo è il problema» (Calvino 2004, II, p. 1268): da un lato affiora tutta la forza vitale dell’esplosione incarnata nel Big Bang («gas e particelle veloci quasi quanto la luce si scagliano da un vortice al centro delle galassie a spirale, straripano nei lobi delle galassie ellittiche, proclamano che il Big Bang dura ancora»), dall’altro c’è il ricordo di «quell’agosto in cui il fungo s’è innalzato su città ridotte a uno strato di cenere», per cui a memoria universale della contemporaneità l’esplosione è diventata «solo simbolo di negazione assoluta».
Per questo Calvino inneggia all’implosione, «Sia lode alle stelle che implodono» (Calvino 2004, II, p. 1270), e ricorda che i buchi neri hanno un soprannome denigratorio, ma «sono tutto il contrario di buchi, con un’ostinazione a reggere la gravità che portano in sé, come stringendo i pugni» e in questo modo «l’implicito, l’inespresso non perdono la propria forza» e «la pregnanza di significati non si diluisce» (Calvino 2004, II, p. 1271).
L’implosione diventa un nucleo di senso con ricaduta stilistica in una scrittura implicita, pregnante e non diluita: piena di subordinate, piena di figure retoriche, piena di enumerazioni e d’incisi, come se fosse un «guscio di parole – secondo la definizione di Priscilla – che noi continuamente secerniamo» (Calvino 2004, II, p. 302). Non possiamo dimenticare che su un mollusco gasteropode, intento a costruirsi il guscio, Calvino scrive uno dei suoi racconti più autobiografici e più belli, La spirale:
mediante certe ghiandole, cominciai a buttar fuori secrezioni che prendevano una curvatura tutto in giro, fino a coprirmi d’uno scudo duro e variegato, […] mi veniva una conchiglia di quelle tutte attorcigliate a spirale (Calvino 2004, II, pp. 212-213).
Anche sulla copertina di La ricerca delle radici compare la Spirale sferica (1958) del matematico olandese M. C. Escher, amatissimo da Primo Levi, che già aveva utilizzato un suo disegno per la copertina di Il sistema periodico (1975). Escher amava disegnare spirali logaritmiche, come in quei Vortici, in cui il dorso dei pesci si muove a spirale fino a un punto asintotico, cioè a un polo irraggiungibile. È la Spira mirabilis, senza inizio né fine, del matematico seicentesco Jakob Bernoulli, la stessa che ispira anche il progetto per il Blocco 21 nel campo di Auschwitz del Memoriale degli Italiani, che nella primavera del 1980 viene aperto al pubblico.

Il visitatore cammina lungo una passerella lignea circondata da una spirale di 23 strisce, dipinte da Pupino Samonà. Il memoriale multimediale nasceva dal frutto di una progettazione collettiva, che oltre al pittore, avrebbe visto il progetto architettonico dello studio milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti e Rogers), la regia di Nelo Risi, la musica di Luigi Nono (Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz) e le parole di Primo Levi, introduttive a quel percorso spiraliforme:
Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la nostra morte. Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Auschwitz valgano di ammonimento: fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né domani né mai.


