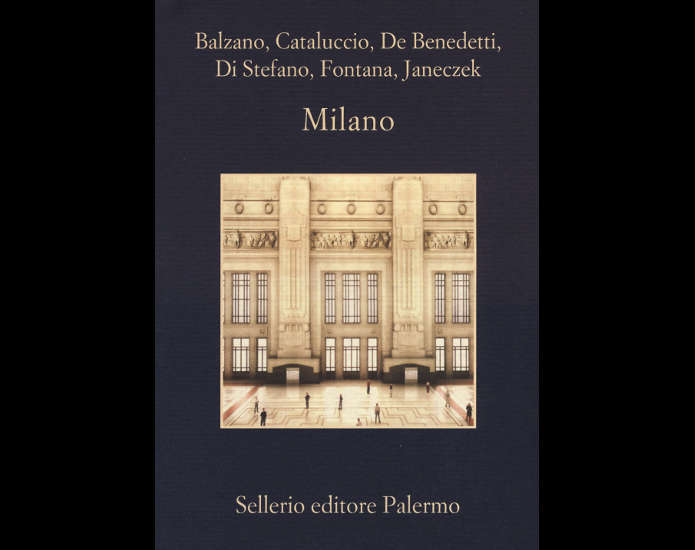La narrazione procede senza alcuna concessione all’ostinata “perforazione dei generi” – per dirla con Gianluigi Simonetti – che caratterizza il panorama della letteratura circostante: la storia comincia nel 1921 a Curon Venosta, un paese che oggi non esiste più, se non nella memoria di pochi e nelle pagine del libro di Balzano, e termina nel 1950, nel momento in cui dell’antico borgo resta solo un campanile, sospeso sull’acqua del Lago di Resia, un indice puntato contro la violenza della storia e del progresso.
Se i turisti frettolosi e distratti, di passaggio nella valle, stentano a comunicare con il passato e preferiscono scattare una foto al curioso campanile e poi assaggiare i piatti tipici della zona – come Tripadvisor conferma -, allo scrittore-palombaro (come si è definito lo stesso Balzano nell’intervista rilasciata durante la serata della proclamazione del vincitore dello Strega lo scorso 5 luglio) in un primo tempo sembra di essere finito in un quadro di De Chirico, poi tocca riportare a galla quello che è successo, recuperando voci ridotte al silenzio.
Come quella di Trina, la protagonista, un personaggio d’invenzione, ma ispirato dalla suggestione di un’immagine: mentre Balzano svolgeva ricerche e ascoltava testimonianze (perché uno scrittore deve ascoltare le storie, prima di raccontarle), la sua attenzione si è soffermata sulla fotografia in bianco e nero di una donna non più giovane che rifiuta di lasciare il suo mondo che sprofonda nell’acqua e nell’oblio, afferrando gli stipiti della finestra della sua casa quando ormai l’acqua la sta sommergendo. Trina deve a questa sconosciuta il tratto fondamentale del suo carattere, ossia l’attitudine a resistere al sopruso, dimostrata non solo nel frangente della costruzione della diga: Trina è una madre che dialoga con la figlia perduta e lotta a lungo per tenerne vivo il ricordo, è «una giovane sposa salita sulle montagne per amore del marito avventuriero, […] una guerrigliera che i tedeschi temevano», è prima ancora «una maestra che aveva messo in salvo i suoi bambini».
Trina, maestra clandestina
Sono gli anni Venti del secolo scorso. La giovane Trina possiede un diploma di maestra, ma l’esercizio della sua professione le è impedito dall’italianizzazione forzata della regione voluta da Mussolini dopo la Prima guerra mondiale. Trina appartiene alla comunità locale germanofona, ma nella valle viene imposto l’italiano, una lingua «esotica», che ben presto si trasforma nella «lingua dell’odio» per chi è cresciuto in quei luoghi seguendo il ritmo delle stagioni e appena sentendo l’eco della storia. Le strade e i centri abitati cambiano i loro nomi, come le scritte sulle lapidi cimiteriali e le insegne dei negozi; arrivano i coloni (pochi, in verità, si spingono fino a Curon) e non solo: da un giorno all’altro arrivano anche insegnanti veneti, lombardi, siciliani.
Trina e le amiche in un primo tempo non si perdono d’animo e studiano l’italiano, sperando di poter essere maestre di italiano, se non di tedesco; ma in «un punto incerto d’Europa dove tutti si guardano di traverso, […] l’italiano e il tedesco erano muri che continuavano ad alzarsi» e Trina può insegnare solo nelle catacombe, nelle scuole clandestine per i bambini e le bambine della comunità tedesca: «era illegale e voleva dire multe, botte, olio di ricino. Si poteva finire al confino su qualche isola sperduta», come accade infatti a un’amica.
Trina viene arrestata ma non si scoraggia, continua a esercitare nelle cantine, nelle stalle e nei prati: «Li guidavo a disegnare le lettere dell’alfabeto, le parole, le prime frasi. All’inizio sembrava impossibile, invece poi, da una sera all’altra, diventavano capaci di sillabare piano, leggendo a voce alta, uno alla volta, accompagnandosi col dito per non sbagliare riga. Era bellissimo insegnare tedesco. Mi piaceva così tanto che a volte mi dimenticavo di essere una maestra clandestina».
Trina insegnerà la lingua italiana a un solo allievo, suo marito Erich: vuole a tutti i costi imparare la lingua del nemico, che ormai è la giovane Repubblica italiana, per capire quali piani gettino un’ombra sul futuro della valle e per reagire con le armi della parola alla violenza della cosiddetta civiltà che vede intorno a sé. Per un uomo adulto e semplice come Erich, si tratta di uno sforzo enorme, purtroppo destinato a non portare alcun frutto e a generare solo disillusione.
Nicola e Giuseppe, professori precari
A ben guardare, nell’opera narrativa di Marco Balzano Trina è solo l’ultima nata di una serie di personaggi che condividono il mestiere dell’insegnante. Fin dal romanzo d’esordio, Il figlio del figlio (Avagliano, 2010), il protagonista è un professore precario, Nicola Russo, che racconta in prima persona un viaggio Milano-Barletta, propriamente un nóstos nei luoghi d’origine della sua famiglia e alla ricerca di sé stesso: «non più un campagnolo inurbato», come il nonno migrante analfabeta, né un diplomato alle scuole serali, come il padre, Nicola è un figlio del boom economico, è «il primo ad essere nato in ospedale», il primo a essersi laureato, «un insegnante di città», che pure, con disincanto, dichiara che «fare questo lavoro oggi significa fidarsi solo di un’intuizione giovanile». Nicola è infatti pienamente consapevole che il valore del lavoro intellettuale oggi è sempre più messo in discussione, come si evince da una conversazione con nonna Caterina, donna bizzarra e di poche parole, che lo invita comunque a non desistere: «Be’? È proprio vero che sei professore?» «Sì, ma senza lavoro». «Arriverà».
La figura del professore precario torna nel racconto I primi giorni di scuola (nella silloge di vari autori Milano, edita da Sellerio nel 2015) e nel romanzo Pronti a tutte le partenze (Sellerio, 2013), evidentemente come metafora della condizione presente, in cui non è facile orientarsi nel gioco indecifrabile della realtà: come scrive Cinzia Ruozzi, autrice di Raccontare la scuola (QdR / Didattica e Letteratura #2, Loescher, 2014), Giuseppe Savino, il protagonista autodiegetico del romanzo del 2013, è «antiepico», «subisce l’ambiente e viene agito dalla storia», ma alla fine diventa attore del suo destino e sceglie l’impegno dell’insegnamento anche grazie alle parole del professor Ramino.
Quest’ultimo, accademico di lungo corso che ha anche cercato di spianare la strada nel mondo dell’università al suo allievo, confida al giovane pupillo: «Tornassi indietro mi occuperei di divulgazione, parlerei di letteratura a più gente possibile, la smetterei coi tecnicismi e con la critica puntigliosa. […] Sa che farei se potessi tornare indietro? Andrei anch’io a insegnare in carcere, o alla radio a fare una trasmissione molto seria, mica quelle pagliacciate che si sentono, “un libro in un minuto”. […] La divulgazione è importante e appena si abbassa la guardia veniamo scalzati dai più furbi, che generalmente sono degli ignoranti, o peggio dei mascalzoni».
Un autobiografismo costruttivo
In una conversazione che ho avuto il piacere di avere con Marco Balzano in chiusura del Congresso dell’ADI-sezione didattica tenutosi a Firenze lo scorso settembre, in parte incentrata proprio sul ruolo dell’insegnante, è emerso che il personaggio del professor Ramino è ispirato alla figura di Franco Brioschi, studioso esemplare e indimenticato, che non ha avuto evidentemente il solo merito di avviare agli studi leopardiani il giovane dottorando Marco Balzano, ma ha lasciato un’impronta ben più profonda, almeno se dobbiamo prestar fede a quanto dichiarato dallo stesso Balzano: «Io sono stato l’alunno che i miei maestri erano».
Un’affermazione a cui va dato il peso e l’importanza che merita, visto che Marco Balzano è anche docente di ruolo nella scuola secondaria, pienamente consapevole della sua duplice responsabilità, di insegnante e di scrittore: «occuparsi di letteratura non vuol dire stare sulle nuvole» perché «la letteratura è strumento di connessione e di comprensione di ciò che altrimenti è frammentato».
Proprio in chiusura del romanzo Pronti a tutte le partenze il protagonista Giuseppe Savino, dai tratti marcatamente autobiografici, ormai pacificato con sé stesso, propone una definizione del mestiere che ha scelto, nonostante tutte le difficoltà pratiche:«Un insegnante è uno studente un po’ più grande: sa più cose dei suoi compagni e ha sempre voglia di raccontarle».
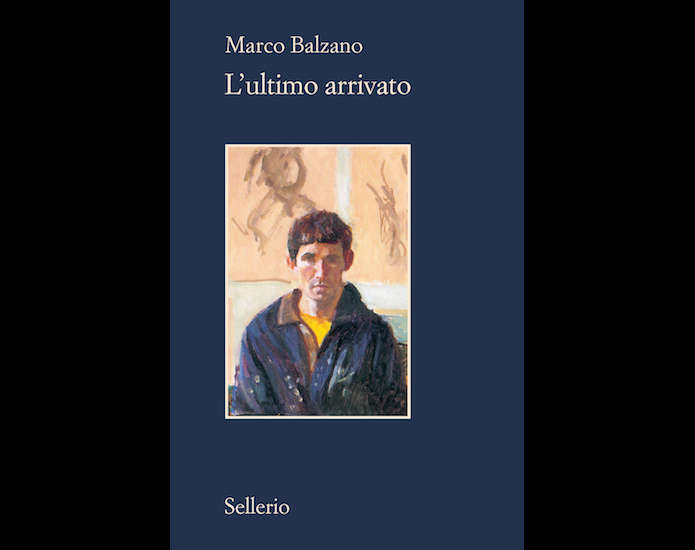
Il maestro Vincenzo
Forse per questo, se avesse potuto scegliere, Ninetto, oltre che poeta, avrebbe voluto essere insegnante, come il suo maestro Vincenzo: almeno così avrebbe potuto continuare a studiare e avrebbe legittimato il suo desiderio di raccontarsi. Ninetto è il protagonista de L’ultimo arrivato, il romanzo che ha vinto nel 2015 il Premio Campiello; nella scuola elementare di San Cono in Sicilia era un alunno del maestro Vincenzo di Cosimo, amante delle teorie di Rousseau e delle poesie di Pascoli, che faceva imparare a memoria ai suoi alunni.
Il maestro affida al piccolo migrante in partenza per Milano, dove certo non sarebbe più andato a scuola, un quaderno su cui scrivere le cose che non può confidare a nessuno. Anche quando, adulto e operaio tornitore all’Alfa Romeo, tornerà sui banchi per prendere la licenza elementare e media, nessun insegnante potrà cancellare il ricordo del suo primo maestro: «Il maestro Vincenzo me lo vedo in cielo che insegna agli angeli, oppure nel Limbo a quelli sbattezzati perché a lui piaceva lavorare nei posti difficili ed era convinto che dove c’è più miseria, lì c’è più bisogno di scuola».