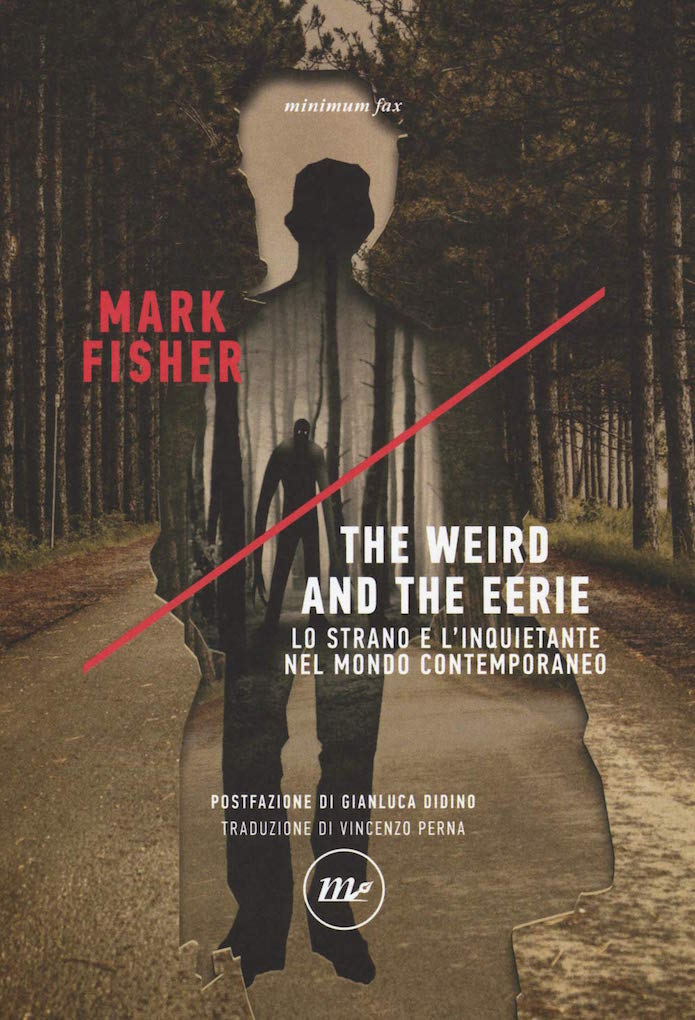
Mark Fisher, morto suicida nel 2017 a quarantotto anni, è stato una delle figure di punta della scena controculturale inglese dei primi tre lustri degli anni Duemila, anche grazie al fortunato pamphlet socio-politico Realismo capitalista.
L’ultimo libro da lui pubblicato in vita, The Weird and the Eerie. Lo strano e l’inquietante nel mondo contemporaneo (Minimum Fax, Roma 2018; traduzione di Vincenzo Perna), per l’argomento trattato può essere letto in continuità con una certa tradizione di indagine sul fantastico – inevitabile pensare al classico di Todorov del 1970 – ma anche trovar posto nell’articolato dibattito di questi ultimi anni circa le nozioni di realtà, Realtà (in senso psicoanalitico, post-lacaniano), realismo.
Non si tratta, occorre precisarlo subito, di un lavoro di impianto accademico: la forza, e in parte il limite, della scrittura di Fisher risiede in un metodo che combina liberamente stimoli concettuali di varia origine ed emozioni culturali, stabilendo relazioni anche ardite capaci di produrre coraggiosi sconfinamenti di campo (si legga in tal senso l’acuta e informatissima postfazione di Gianluca Didino).
Il volume edito da Minimum Fax indaga due categorie, o meglio due modalità di esperienza estetica di straordinaria fortuna negli ultimi cento anni, quando tutto un immaginario, anche attraverso il recupero di culture “minori” (miti pagani, tradizione gnostica, esoterismo e molto altro), ha cospirato per disfare il fragile tessuto della realtà, o per mostrarcene l’illusoria saldezza.
Le due categorie in questione sono, come da titolo, il weird e l’eerie, due termini che in inglese suonano quasi sinonimici: dico quasi perché in realtà esiste una sfumatura di senso che li distingue, ed è in questa divaricazione che Fisher si incunea per articolare il proprio discorso.
Weird è ciò che provoca una sensazione di non correttezza, l’ormai proverbiale anello che non tiene nell’ordine dell’esistente, l’irruzione in questo mondo di qualcosa che proviene dall’esterno.Per weird l’autore intende il misterioso, lo strano, l’insolito, il soprannaturale nel senso di qualcosa che non si trova al proprio posto, qualcosa caratterizzato da una stranezza che disorienta. Weird è insomma ciò che provoca una sensazione di non correttezza, l’ormai proverbiale anello che non tiene nell’ordine dell’esistente, come nel caso di due entità non appartenenti alla stessa dimensione ma che si trovano a coabitare sul medesimo piano di realtà. Scrive Fisher: «È l’irruzione in questo mondo di qualcosa che proviene dall’esterno a fare da marcatore del Weird» (p. 23).
Nel corso del libro l’autore estende piuttosto liberamente tale categoria a opere e personalità anche molto lontane tra loro, dai bisticci logico-ontologici di Escher al weird cognitivo (quando capita che, caduta ogni sensazione di realtà, lo straniamento abbia per esito la frattura psicotica: si pensi ai romanzi di Philip K. Dick), fino a proporre, per Lacan, la definizione di psicoanalisi weird. La forzatura potrebbe lasciare perplessi, e tuttavia risulta innegabile che tale azzardo, se interpretato come stimolo ermeneutico e non come indebita e un po’ approssimativa semplificazione concettuale, non manca di aprire interessanti prospettive euristiche, ad esempio circa i nessi tra letteratura e dinamiche dell’inconscio.

Ma è soprattutto sulla weird fiction che Fisher concentra la propria analisi, e in particolare sulla figura di Howard Phillips Lovecraft, cui è dedicato il capitolo forse più bello del volume. La presenza incongrua di eccessive, brulicanti forme non umane che sfondano le barriere della realtà e mettono drammaticamente in contatto tra loro dimensioni incommensurabili è un elemento costante dei racconti del maestro di Providence e un esempio perfetto di meccanismo letterario weird, tanto più seducente quanto più Lovecraft gioca ad accentuare le istanze di sublimazione del negativo che le sue visioni mostruose sollecitano. In generale, osserva Fisher, le soglie, i limiti che separano l’universo dei vivi da quello dei morti, o il mondo abituale da quello dell’incubo, rappresentano un perfetto motore di weirdness.
Esemplari, in tal senso, i lavori di David Lynch, nei quali la dimensione dell’“in mezzo” (traduzione dell’espressione inglese in-between) gioca un ruolo determinante, come testimoniano le suggestive pagine dedicate all’interpretazione di Mulholland Drive e Inland Empire – ma certo non sarebbe difficile estendere il discorso alla terza stagione di Twin Peaks, dove il massimo del domestico (una comune presa elettrica) diventa il varco interdimensionale che fa transitare oggetti, entità e persone dalle metafisiche Logge verso il piano di realtà (?) entro cui si muovono Cooper e soci.
Fisher non affronta testi di letteratura grafica, ma certo sarebbe interessante verificare la tenuta della sua proposta anche sulle opere di alcuni maestri del fumetto anglosassone: penso a figure quali Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison, Charles Burns.

Cos’è invece l’eerie? L’inquietante, l’angoscioso, certo, ma soprattutto, sostiene l’autore, ciò che viene percepito come irreale e innaturale perché frutto di un’alterazione dei processi di agentività, ossia, per dirla in altri termini, in ragione di un vuoto (o di un troppo pieno) inspiegabile, disorientante quando non agghiacciante. È eerie lo scoprire qualcosa là dove non dovrebbe esserci niente (fallimento di assenza), o viceversa non trovare niente quando dovrebbe esserci qualcosa (fallimento di presenza). «L’enigma di fondo dietro ogni manifestazione dell’eerie», sintetizza Fisher, «contiene la questione dell‘agency» (p. 74). È eerie lo scoprire qualcosa là dove non dovrebbe esserci niente, o viceversa non trovare niente quando dovrebbe esserci qualcosa.Un esempio su tutti: da dove viene, cosa è, perché esiste il monolite di 2001? Quella nera e liscia lastra cui gli interpreti hanno attribuito cento significati diversi (un manufatto alieno? una divinità?) è eerie proprio nella misura in cui apre uno squarcio d’abisso sull’ignoto assoluto, ossia sull’assolutamente inconoscibile. Il film di Kubrick infatti si limita a mostrarci il monolite e non ci rivela mai perché esista, quale esatta relazione abbia con l’umanità e con le vicende dell’astronauta David Bowman, né ci offre indizi su chi possa averlo creato, ammesso che sia una creazione (si veda, su questo, l’ultimo suggestivo libro di Andrea Inglese, Ollivud, uscito nel 2018 per Prufrock).

Oltre a 2001 c’è naturalmente una lunga tradizione, ancor oggi molto significativa, di eerie fantascientifico, che va dagli interrogativi sull’agentività dell’estraneo-alieno agli incontri con l’insondabile cosmico nel cinema di Tarkovskij (cosa “vuole” il pianeta di Solaris? Cos’è davvero la Zona di Stalker?) fino ai tanti libri e film che hanno per oggetto oscuri processi di de-umanizzazione o post-umanizzazione. Ma l’eerie non è prerogativa della sola science fiction: per tornare ancora a Kubrick, eerie è il mistero alla base di Shining (il cui vero protagonista è un luogo prigioniero di una schizo-simultaneità, controllato da forze occulte), eerie sono gli Uccelli di Du Mauriac e poi, sia pure in diversa declinazione, di Hitchcock. Eerie può essere il paesaggio circostante (così nell’opera di Margaret Atwood, cui pure sono dedicate pagine molto convincenti), e più in generale le tante opere che inscenano una disgiunzione tra la coscienza e l’apparato materiale che rende possibile l’esistenza stessa di tale coscienza (penso, avanzando un esempio che non so quanto Fisher avrebbe approvato, ai revenants de L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares).

Eerie è, infine, la miriade di oggetti di cui ignoriamo tutto a eccezione della loro immediata datità. È questa forse la più vertiginosa declinazione dell’eerie: la eerieness del mondo che ci circonda. E qui è interessante notare come sfere culturali tra loro lontanissime possano incrociarsi e dialogare anche a grande distanza, di spazio e di tempo. Scrive Fisher:
I casi di Stonehenge e dell’Isola di Pasqua indicano che esiste una dimensione irriducibilmente eerie in certe pratiche archeologiche e storiche. Archeologi e storici, specie quando trattano di un passato molto lontano da noi, elaborano delle ipotesi, ma la cultura a cui fanno riferimento e che avrebbe la capacità di sostenere tali ipotesi non potrà mai essere (di nuovo) presente (p. 74)
Se operando una dislocazione arbitraria estrapolassimo queste parole e le ponessimo a esergo di quel documentario ammaliante che è Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog (2010), o di quel libro appassionante che è Il linguaggio delle pietre. Alla scoperta dell’Italia megalitica di Furio Jesi (1978) che cosa otterremmo? Otterremmo una circolazione di idee tra testi che si illuminano a vicenda. E capiremmo che l’eerie non si annida solo nelle fantasie più o meno a basso costo di civiltà aliene e di mondi invisibili ma anche, se non soprattutto, tra i graffiti di Lascaux, in fondo ai loculi di Pantalica e dentro le arcane forme delle statue-stele della Lunigiana, insomma nella vertigine di ciò che della nostra specie resterà per sempre ignoto.

