
C’è un verso di una canzone partigiana montenegrina che recita pressappoco così: «Compagna, guarda, guarda come spara Ricci con il Breda». Racconta Eric Gobetti di averla udita qualche anno fa, citata a un convegno a Pistoia dallo storico montenegrino Slavko Burzanovic: un ricordo d’infanzia che accompagnava il lungo elenco di famigliari imprigionati o fucilati dalle truppe italiane di occupazione in Montenegro. Alla fine dell’intervento, un uomo si era alzato: «Buongiorno, mi chiamo Ricci: il mitragliere di cui parla era mio padre».
Ebbene, nel breve spazio di una frase sono racchiuse due storie. Una è quella di una terra e del suo popolo: il Montenegro è l’area del Regno di Jugoslavia che in proporzione ha dato il maggior contributo alla Resistenza. I caduti sono cinquantamila, un ottavo della popolazione della regione: «è l’area più devastata del paese più devastato della guerra più devastante che sia mai combattuta a memoria d’uomo», sottolinea ancora Eric Gobetti.
La seconda è quella di un pezzo dell’esercito di occupazione italiano. Si tratta di una vicenda che a sua volta si biforca: contiene un’oppressione, in larga parte rimossa, e una Resistenza, anch’essa dimenticata. Ma i protagonisti coincidono: carnefice e liberatore hanno gli stessi volti. E l’insieme di questi volti dà vita a una divisione partigiana, che avrebbe preso il nome del patriota Giuseppe Garibaldi.
Eric Gobetti è lo storico torinese che ne ha riportato alla luce la storia, intrecciandola a quella del luogo dove essa ha combattuto. Alla divisione Garibaldi ha dedicato un documentario, Partizani, un reportage in tre puntate per la serie Research di Rai Storia, infine il saggio La Resistenza dimenticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945), Salerno editrice, dove trae le fila di anni di ricerche, incrociando la prosa del romanzo e il rigore del saggio storico.
Con questo volume vorrei dare il mio contributo alla divisione Garibaldi. Cerco di farlo con uno sguardo esterno, ma non estraneo, mai neutrale. Perché questo non è solo un lavoro di ricerca, condotto con gli strumenti della conoscenza, da studioso; è anche un omaggio personale, fatto col cuore, per questi uomini che si sono trovati di fronte a decisioni difficili, immensamente più grandi dei ragazzi che erano. Ragazzi che si sono trovati ad essere vittime e carnefici al tempo stesso: hanno occupato una terra straniera, oppresso una popolazione, rubato, incendiato, fucilato, ma poi, messi i fronte a una scelta, hanno saputo imboccare la strada giusta, quella della libertà. (E. Gobetti, La Resistenza dimenticata, p.10)
La storia dei carnefici
L’alba del giorno dopo è velata da una leggera nebbiolina. Comincia a far freddo la notte. Un po’ di brina sulle canne dei pezzi, i cannoni brillano nella prima luce del mattino. L’alpino Tarcisio Pelosin osserva la strada avanti a sé, i campi coltivati da entrambi i lati; sente nell’aria l’odore della terra grassa, viva. […] Sono le otto. In fondo al lungo rettilineo, prima della curva, appare qualcosa, come una polvere, che si confonde con la nebbia che si sta alzando. Poi il sole fa capolino dalla collina e si riflette come uno specchio sul metallo di un autoblindo. Non ci sono dubbi, una colonna motorizzata sta avanzando lungo la strada. Qualcuno ha dato l’allarme tutti si agitano attorno ai cannoni, il comandante ha già dato ordine di tenersi pronti. La colonna avanza, in un grande polverone. «Sono tedeschi!» grida qualcuno.[…] Nessun ordine è arrivato stamattina e nessuno sa come vada interpretato lo strano annuncio di ieri. Però bisogna agire rapidamente, serve una decisione. Francesco Perello, il comandante della batteria non ci pensa due volte. Una colonna corazzata sta entrando sul territorio controllato dalle sue truppe. Va fermata subito. L’artigliere Tarcisio Pelosin infila il proiettile in canna. Poi accarezza il rosario che tiene nel taschino. «Te ga el fusil, te ga el canon…» gli ha detto la mamma prima di partire, «ma ricordati che la tua sola arma di difesa sarà questo rosario: devi recitarlo tutti i giorni!».[…] «Fuoco!» grida il comandante. «Io per primo ho sparato il primo colpo», scrive nel suo diario Pelosin. «Fuoco!». «Fuoco!». (E. Gobetti, La Resistenza dimenticata, pp. 49-51)
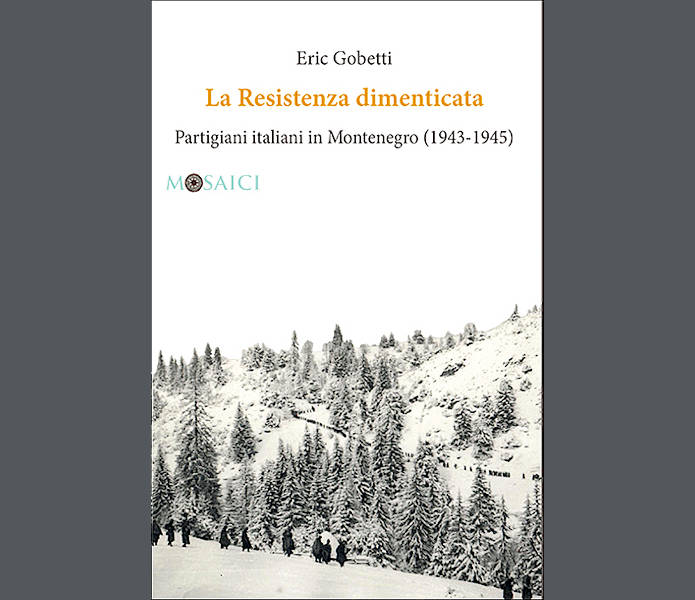
9 settembre 1943, periferia di Niksic. Quando la 6° batteria della divisione Taurinense incrocia la colonna tedesca ha come unica bussola di riferimento le sibilline parole del capo di governo Badoglio che la sera precedente avevano annunciato l’armistizio con gli angloamericani: reagire «a eventuali attacchi di qualsiasi provenienza». Centinaia di migliaia di militari italiani sono abbandonati in mezzo a una guerra spaventosa. Nel Montenegro sono sessantamila i soldati che devono decidere autonomamente come porsi di fronte alla nuova situazione (cosa ancor più difficile per chi da venti anni non conosceva la libertà). In molti casi i comandanti non danno ordini, si lasciano travolgere dagli eventi che significa un destino di deportazione nei campi di prigionia tedeschi. La batteria del tenente Perello invece spara. È il primo atto della Resistenza italiana al nazifascismo in Montenegro.
Ma la storia di quella che sarebbe diventata la divisione Garibaldi non comincia l’8 settembre. Si deve tornare indietro di due anni e una manciata di mesi, quando il Montenegro finisce tra le spoglie italiane del Regno di Jugoslavia, smembrato dopo la conquista lampo della Wermacht. Il 12 luglio 1941, nella capitale, Cetinje viene dichiarata un’indipendenza fittizia, camuffata sotto i legami dinastici della consorte di Vittorio Emanuele III, la regina Elena – o meglio Jelena – figlia del deposto re montenegrino Nikola.
Il giorno seguente il Montenegro insorge. Il governo fascista risponde schierando centomila soldati per una popolazione di 400000: un soldato ogni quattro abitanti. I metodi utilizzati sono quelli feroci dell’antiguerriglia, ratificati dalla famigerata circolare 3C del generale Roatta. La strategia occupazionale segue un doppio registro: reprime con la violenza il movimento di resistenza, mentre tenta di stabilire una collaborazione con le realtà politico-militari del luogo.
Le divisioni che avrebbero costituito il grosso della Garibaldi in questo momento svolgono missioni differenti: la Venezia, almeno a partire dalla primavera del 1942 controlla un territorio relativamente pacificato. I suoi soldati possono permettersi amori fugaci con ragazze del posto o un ozio che improvvisamente può essere letale.
Alla Taurinense, composta di alpini, tocca una vita raminga tra «mulattiere, imboscate, marce estenuanti e combattimenti improvvisi. Gli alpini fanno (quasi) la vita dei partigiani dormono nei boschi, mangiano freddo» (E. Gobetti, La Resistenza dimenticata, p.35). Le sono affidate le operazioni più rischiose e difficili. Ma anche le più brutali: è impiegata nella politica del terrore nei confronti della popolazione che sostiene i ribelli, fatta di fucilazioni, rappresaglie e internamenti. Il soprannome di palikuci, “brucia-case”, spetta anche a loro.
La storia dei liberatori
L’armistizio cade sopra questi due anni di violenze, rancori, ma anche relazioni strette con le popolazioni locali. Nel disorientamento generale i comandi di ciascuna delle quattro divisioni italiane di occupazione avrebbero deciso di comportarsi in modo diverso. Due si rifiutano di obbedire agli ordini del nuovo comandante del gruppo Armate est di Tirana imposto dai tedeschi, Renzo Dalmazzo, che dispone l’autodeportazione in Germania.
Nella divisione Taurinense, già protagonista del primo scontro a fuoco, il generale Vivalda si adatta alla nuova situazione con una scelta sorprendente: legge l’ordine di autodeportazione e sottopone la questione ai suoi alpini. La grande maggioranza decide di combattere contro i tedeschi. Dopo i primi scontri la divisione si sfalda in battaglioni autonomi: incalzati dai nuovi nemici, alcuni si ritirano nell’interno, nei luoghi controllati dalla divisione Venezia.
La divisione Venezia si trova nel ventre più riposto dei Balcani. La posizione le avrebbe garantito un mese aggiuntivo di relativa pace. Sotto il comando di Giovanni Battista Oxilia (fratello del più celebre autore di Giovinezza, morto durante la prima guerra Mondiale), dopo alcuni giorni di incertezza opta per l’alleanza con il comando partigiano di Drapcevic. Un vecchio generale sabaudo e un giovane generale comunista di trent’anni – dei quali molti vissuti in clandestinità –, spinti dalle circostanze, si ritrovano alleati contro il comune nemico tedesco.

Il 2 dicembre dall’unione delle due divisioni nasce la Garibaldi. Il nome tiene insieme due esigenze simboliche, quella patriottica e quella internazionale della lotta antifascista, legata alle memoria delle brigate che avevano combattuto in Spagna. La nascita della divisione cela in realtà una resa al comando partigiano jugoslavo. Ai soldati italiani sono lasciate le stellette, ma si tratta di un segno d’autonomia solo esteriore: da questo momento sono sottoposti all’autorità jugoslava. Inoltre, per ridurne il peso numerico, il numero dei partigiani in armi viene drasticamente ridotto a meno di cinquemila uomini. Due terzi degli italiani sono disarmati e arruolati nei battaglioni dei lavoratori.
Tre giorni dopo la Garibaldi è travolta dall’offensiva tedesca a Pljevlja: 600 uomini rimangono sul campo, 1500 sono fatti prigionieri. La divisione va subito in pezzi come una granata. Si sarebbe ricostituita in maniera unitaria, fino a raddoppiare gli effettivi, solo nell’agosto del 1944, raccogliendo sbandati di varia provenienza.
In mezzo passa il terribile inverno 1943-44: un inferno nel quale fame freddo e tifo sono nemici non meno fatali della repressione tedesca. Manca tutto: coperte, giacche, pantaloni, scarpe, munizioni, cibo, medicinali. I soldati combattono ricoperti di stracci, sperando nell’aiuto di un cielo ancora avaro: il ponte aereo dall’Italia avrebbe cominciato a rifornire i soldati italiani in Montenegro con una regolarità accettabile solo a partire dalla tarda primavera. Chi sopravvive lo deve all’ospitalità contadina, in un territorio scarso di risorse, vessato da tre anni di requisizioni e distruzioni.
Al tempo stesso, i soldati italiani sono catapultati in una guerra difficile, di movimento, dove devono adeguarsi rapidamente alle strategie della guerriglia alle quali non sono abituati. Pesa su di loro la diffidenza dell’alleato partigiano che non dimentica la precedente repressione. Alla disciplina draconiana, identica per tutti i partigiani, che punisce con la fucilazione piccoli furti alla popolazione o rapporti scorretti con le donne, per gli italiani si aggiunge la lesina nella distribuzione di cibo e armi e le indagini nei confronti di alcuni ufficiali per crimini di guerra. Undici sarebbero stati condannati a morte: data l’assenza di una Norimberga italiana saranno gli unici a pagare i crimini commessi durante l’occupazione nei Balcani.
La storia dell’oblio
Ad attendere i primi ufficiali italiani, rimpatriati via aereo nel corso del 1944, quando la situazione bellica comincia a migliorare, è un interrogatorio. Tra i vertici dell’esercito italiano la scelta di resistere accanto ai partigiani comunisti suscita molta diffidenza.>
E l’incomprensione avrebbe accolto i reparti della divisione Garibaldi che, a partire dall’8 marzo 1945, cominciano il rientro da un Montenegro libero. Prima tocca loro l’internamento in un campo di quarantena, per il timore che portassero con sé un’epidemia di tifo petecchiale. Poi, anziché gli onori, l’oblio. Nell’Italia della guerra fredda il loro sacrificio non trova posto. La loro esperienza non è spendibile né presso il governo democristiano, per la lotta condotta accanto a un esercito comunista, né tra i partiti di sinistra, perché l’esercito comunista è quello del deviazionista Tito, che ha rotto con Stalin. Le porte delle associazioni d’arma rimangono chiuse: non possono entrare in quelle partigiane, perché hanno combattuto con i segni dell’esercito, non in quelle militari, perché hanno operato sotto un comando straniero. Sono uomini che restano «ingabbiati in categorie politiche che non hanno scelto: prima percepiti come occupanti fascisti, poi considerati partigiani del re, infine trattati come comunisti una volta rientrati in patria» (E. Gobetti, La Resistenza dimenticata, p.10).
Dove il ricordo del sacrificio della divisione Garibaldi continua a rinnovarsi è in Montenegro. Qui dicembre diventa una sorta di mese della memoria: il primo del mese si ricorda la battaglia di Pljevlja, del 1941, lo scontro più duro sostenuto dalla resistenza montenegrina contro l’esercito di occupazione italiano. Il 2 si commemora la nascita della divisione partigiana Garibaldi. Il 10 dicembre, infine, si fa memoria di un terribile naufragio avvenuto nel 1944, quando il Montenegro era ormai liberato: tra le vittime c’è anche il mitragliere Ricci.

Appena fuori dal centro di Pljevlja, ai partigiani italiani è dedicata un’opera d’arte concettuale: dall’alto dovrebbe configurarsi una colomba stilizzata, a rappresentare l’abbraccio di due popoli. Il giorno dell’inaugurazione, nel 1983, fu una festa popolare: parteciparono migliaia di cittadini, le autorità dello Stato, qualche decina di reduci. Tra i presenti ci sarebbero state anche alcune autorità italiane: su tutti il presidente della Repubblica Sandro Pertini.
In Italia solo negli ultimi anni la memoria ha cominciato a mettere insieme alcuni grani: un cippo, qualche lapide, infine un piccolo museo ad Asti, aperto nel 2015. Il lavoro di Eric Gobetti rappresenta un altro passo di un ideale risarcimento:
Nonostante la sobrietà e l’umiltà della maggior parte dei reduci, nel corso dei lunghi mesi di ricerche e di interviste ho cominciato a considerarli degli eroi. Eroi semplici, senza una motivazione forte, senza un colore politico. Forse proprio per questo mi appaiono ancora più eroici. Sono uomini con una storia comune: carne da macello per la megalomania fascista; poi abbandonanti nel nulla e costretti a schierarsi; infine dimenticati nel vortice della politica dei blocchi contrapposti nel dopoguerra. La loro scelta di campo non è ideologica e non ha niente di eroico in sé; tuttavia evidenzia una capacità di comprensione più profonda, un rifiuto della logica dell’odio politico e razziale. Questi uomini sentono, percepiscono il bisogno di schierarsi con chi lotta per la propria libertà e contro il nazismo. (E. Gobetti, La Resistenza dimenticata, p. 118)
Eppure l’opera di restituzione non è finita. Di tutti i tasselli mancanti ve n’è uno fondamentale: il documento più importante di una divisione militare è il suo diario storico. Consegnato dall’ultimo generale della divisione, Carlo Ravnich, alla Fondazione Umberto Secondo di Savoia, è qui segregato, inaccessibile a chi lo volesse consultare per volontà della sua fondatrice, la principessa Maria Gabriella di Savoia.

