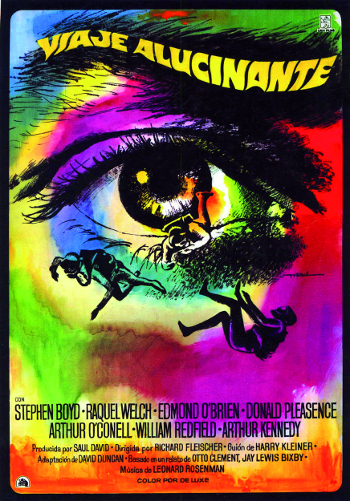
I cineasti, affermava Gilles Deleuze, «sono paragonabili a pensatori, più che ad artisti. Essi pensano, infatti, con immagini-movimento e con immagini-tempo, invece che con concetti». Deleuze, una delle figure più originali e importanti della filosofia francese del secondo dopoguerra, sottolineava così che il cinema non è soltanto una forma di arte (l’ottava Musa, come tante volte si è affermato), e meno ancora solamente una forma di intrattenimento. Esso è piuttosto un modo per esprimere un “pensiero”, anche se mediante una forma diversa da quella nella quale tradizionalmente si articola il discorso filosofico. Di conseguenza, cinema e filosofia non rappresentano attività distinte, né ancor meno opposte l’una all’altra, visto che entrambe sono manifestazioni dell’attività del pensare, l’una mediante le immagini, l’altra attraverso i concetti. In un’intervista pubblicata nella raccolta intitolata Pourparler 1972-1990, lo stesso Deleuze affermava che «il cinema è anzitutto immagine-movimento[… ]. Poi, quando il cinema fa la sua rivoluzione kantiana, quando cioè cessa di subordinare il tempo al movimento…, allora l’immagine cinematografica diviene un’immagine-tempo, un’autotemporalizzazione dell’immagine».In questo modo, l’autore francese riprendeva quanto era già stato espresso in un importante passaggio del “dittico” sul cinema, allorché egli aveva sostenuto che, in opere cinematografiche come quelle realizzate a partire dal secondo dopoguerra, «vediamo anzitutto il tempo, delle falde di tempo, un’immagine-tempo diretta. Il che non vuol dire che il movimento sia cessato, ma il rapporto tra il movimento e il tempo si è rovesciato. Il tempo non è più il risultato della composizione delle immagini-movimento (montaggio), è viceversa il movimento che consegue dal tempo».
Due idee del tempo
Dal punto di vista filosofico, l’idea che il tempo possa essere assunto non come un dato rigido e obbiettivo, ma come una variabile dipendente da operazioni che su di esso si possono compiere, non è certamente nuova. Già nel pensiero arcaico, ci troviamo in presenza di due distinte, e per certi aspetti contrapposte, concezioni della temporalità. Da un lato, chronos, la cui caratteristica fondamentale secondo Anassimandro sarebbe la taxis, la capacità ordinatrice, l’imposizione di un ordine, al quale nessuna cosa in divenire può sottrarsi. Un tempo lineare e irreversibile, scandito inesorabilmente dalla trasformazione del futuro in passato, attraverso un presente che costantemente transita dall’una all’altra dimensione, senza mai poter essere immobilizzato nella fissità dell’istante. Dall’altra parte, il “sempre-essente” (aei-on) aión, il «bambino che gioca disponendo le pedine sulla scacchiera», come afferma Eraclito, la durata indifferente al mutamento, l’eterna permanenza nel sempre uguale, la virtuale percorribilità in ogni direzione, senza alcun andamento prestabilito. Il tempo come incessante divenire versus il tempo come durata. La “freccia del tempo” (dal futuro al passato attraverso il presente) versus la mancanza di una direzionalità univoca, e dunque la possibilità di ripercorrere più volte a ritroso lo stesso percorso. Pur essendo indiscutibilmente l’autore che più e meglio di ogni altro ha analizzato la qualità filosofica dell’opera filmica, Deleuze non è stato né il solo né il primo filosofo a richiamare l’attenzione sull’importanza del cinema. Già nei primi anni del Novecento, Henri Bergson individuava nel cinema una conferma della propria concezione del tempo come «durata reale», vale a dire come un continuum la cui realtà era irriducibile alla pura e semplice traduzione geometrica del tempo misurato dagli orologi.
Il tempo qualitativo del cinema
Come accade nella coscienza, anche in un’opera cinematografica il tempo è qualitativo, più che quantitativo, non obbedisce rigidamente alla irreversibilità, non è irrevocabilmente distinto in tre dimensioni fra loro nettamente distinte. Esso si contrae o si dilata, appare più “lungo” o più “breve”, a seconda delle circostanze e degli stati d’animo. Allo stesso modo, è possibile che passato e futuro si rovescino l’uno nell’altro, in una struttura circolare nella quale è impossibile distinguere nettamente l’inizio dalla fine, come avviene (solo per citare alcuni esempi molto noti) in film come Pulp Fiction di Quentin Tarantino o, fra i più recenti, Mulholland Drive di David Lynch o Femme fatale di Brian De Palma. D’altra parte, è opportuno riconoscere che l’interesse per la valenza in senso lato “filosofica” del cinema, a parte i casi citati di Bergson e Deleuze e pochissime altre eccezioni, raramente ha prodotto risultati convincenti.Troppo spesso si è creduto che il modo migliore per coniugare cinema e filosofia consistesse nel realizzare film nei quali comparivano come protagonisti alcuni filosofi del passato, con esiti caricaturali o noiosissimi (si pensi alle opere dedicate da Liliana Cavani a Galileo o a Nietzsche, ad esempio). Sull’altro fronte, troppo spesso ci si è convinti che fosse necessaria e sufficiente una buona dose di dilettantismo, per consentire ad alcuni filosofi di improvvisarsi critici cinematografici. In entrambi i casi, si è completamente travisato il significato profondo del rapporto fecondo che può e deve essere riconosciuto fra cinema e filosofia, secondo quanto emerge dalle pagine di Deleuze, ma che già era stato anticipato quasi due millenni e mezzo or sono nella Poetica di Aristotele. Sostenendo che «la poesia è la cosa più seria e più filosofica», lo stagirita sottolineava infatti che la poesia (e il cinema è anch’esso indiscutibilmente una forma di póiesis, anzi ne rappresenta l’espressione più compiuta), a differenza della storia che si occupa solo del particolare, si rivolge invece all’universale, e quindi è quella che più e meglio di ogni altra cosa ci avvicina alle “conoscenze fondamentali”.
Il piacere delle immagini
Di qui il fatto che, attraverso la póiesis, sia possibile raggiungere contemporaneamente due importanti obiettivi: da un lato assaporare quella intensa forma di piacere che è “il piacere delle immagini”, e dall’altro sylloghízesthai e manthánesthai, “ragionare” e “imparare” su tutte le cose. In altre parole, non si tratta di giustapporre o di correlare estrinsecamente due cose fra loro distinte, quali sarebbero cinema e filosofia, ma di ritrovare e far emergere nelle opere cinematografiche, che sono indubbiamente opere di póiesis, una trama concettuale, una filigrana di pensiero, che è sempre presente, anche se talora il linguaggio in cui è espresso questo pensiero, vale a dire le immagini, può risultare difficile da comprendere e da interpretare, perfino più di quanto lo sia quello strettamente filosofico. Per quanto l’argomento appaia comunque delicato e difficile da liquidare in poche battute, si può affermare che accostarsi al cinema con l’atteggiamento appena descritto (vale a dire cercando di comprendere quale “pensiero” sia in esso racchiuso) non implica affatto privarsi del “divertimento” che da esso ci attendiamo, ma esattamente al contrario vuol dire mettersi nelle condizioni di “godere” in maniera più matura e compiuta ciò che un film (qualunque film, e non solo quelli “seri”, come pure si potrebbe credere) è in grado di offrire. Da questo punto di vista, è insensato (o puramente “difensivo”) continuare a correlare estrinsecamente i due termini, parlando dunque di “cinema e filosofia”. C’è da chiedersi, difatti, perché si ponga una con-giunzione, quasi si tratti di mettere insieme, più o meno arbitrariamente, universi fra loro del tutto differenti o addirittura eterogenei, ribadendone così indirettamente la diversità, nell’atto stesso in cui li si connette. Perché la medesima pruderie non è all’opera, perché non si adopera la stessa cautela, riflesso di una sorta di cattiva coscienza, quando ci si riferisce all’ambito delle arti figurative o anche della musica? E ancora: per quali ragioni il filosofo che si occupi di cinema è tuttora considerato, più o meno apertamente, poco “serio”, alla stregua del dilettante perditempo, o del chierico infedele? Perché ormai nessuno trova più nulla da eccepire se in una rivista di filosofia ci si imbatte in un saggio su Van Gogh o se in uno studio si citano Richard Wagner o Arnold Schöenberg, mentre è scandalo se l’attenzione è rivolta ad Alfred Hitchcock o a Baz Luhrmann? E per quali ragioni, soprattutto, almeno in Italia, è ancora tenacemente presente la convinzione che, per quanto ci si possa sforzare di congiungerli, l’ambito del cinema e quello della filosofia restino irrimediabilmente distinti, al punto tale da imporre a chiunque a essi si accosti una opzione precisa e irrevocabile: o cinema o filosofia, o “critico” cinematografico, oppure filosofo?
Le ragioni di un pregiudizio
Come è intuitivo, le risposte a questi interrogativi potrebbero disporsi su molti piani, da quello storico a quello sociologico, giungendo a lambire la sfera della psicologia (o della patologia) sociale. Limitandosi a quelle più stringenti, e anche meno peregrine, si può osservare che le obiezioni più meritevoli di considerazione (che non vuol dire tuttavia necessariamente più fondate) scaturiscono dal rilevamento della natura per così dire “doppia” dell’opera cinematografica: opera d’“arte”, da un lato, e insieme prodotto industriale, mirante al “diletto” che è proprio della creazione artistica, ma nel contempo orientata a finalità commerciali, «apparizione unica di una lontananza» (per dirla con Walter Benjamin), e prodotto di principio illimitatamente riproducibile. In una parola, se nello statuto dell’arte (qualunque cosa si voglia intendere con questo termine) sembra essere incluso quale requisito imprescindibile l’unicità e inimitabilità del “gesto” che la pone, nel caso del cinema ci si trova alle prese con qualcosa che sembra collocarsi esattamente all’estremo opposto, visto che ogni film è, per definizione, costantemente “ripetibile” (nello spazio e nel tempo) ed è in tale misura il contrario dell’evento, di qualcosa che, in quanto è id quod cuique evenit, è confitto nell’hic et nunc. Ma nell’ostilità, o nella vera e propria indisponibilità, a riconoscere nel cinema qualcosa di cui possa valere la pena occuparsi dal “punto di vista filosofico” (altra espressione sostanzialmente priva di senso!), vi è qualcosa di molto più profondo, anche se perfino di ancor più fuorviante. Si tratta della constatazione per la quale l’andare al cinema di-verte, suscita piacere, mentre è implicita la convinzione che, di principio, la filosofia, e con essa le arti “serie”, richiedano un movimento contrario, vale a dire che esse semmai con-vertono, esigono impegno, dedizione, e magari anche una quota di afflizione, se non di vero e proprio sacrificio.
Un approccio aristotelico
Evidentemente non è possibile illudersi che un’avversione così radicata, e tanto variamente motivata, possa dissolversi più o meno magicamente, qualunque sia il rigore degli argomenti addotti, e quale che ne sia l’intima carica persuasiva. Pur con questa consapevolezza, un ribaltamento dell’atteggiamento intellettuale abitualmente assunto nei confronti del cinema, e più in particolare nei confronti della qualità specificamente filosofica delle opere cinematografiche, potrebbe essere se non altro resa più facile ove ci si riferisca a un testo in ogni senso “classicamente” filosofico, quale è la Poetica di Aristotele. Considerato a lungo, per quasi duemila anni, e soprattutto nei primi secoli dell’era moderna, alla stregua di un manuale contenente precetti inviolabili, ai quali il poeta era tenuto comunque a sottomettersi, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo il testo aristotelico è stato poi inghiottito dal sopravvento delle teorie romantiche della creatività. A un’egemonia indiscussa, acriticamente accolta e trasmessa con esponenziale capacità di diffusione, si è così sostituito un rifiuto altrettanto pregiudizialmente immotivato, col risultato che raramente il testo è stato letto e studiato juxta propria principia, come è invece accaduto per gli altri scritti del corpus aristotelico. Né si può dire che maggiore fortuna sia arrisa alla Poetica negli anni più recenti, visto che i peraltro sporadici e isolati tentativi di “rivalutazione”, hanno per lo più cercato di scagionare il testo da ogni sospetto di voler costituire un manuale di precettistica, con ciò contraddittoriamente condividendo l’impostazione, se non l’assunto, di coloro che ne hanno tenacemente respinto la validità. In altre parole, a quest’opera aristotelica è toccato in sorte di non essere pressoché mai considerata per quello che in realtà è, vale a dire un testo filosofico, denso di problemi e di temi di riflessione, e non un breviario contenente articoli di fede, o un trattato dal quale prelevare “regole per ben condurre il proprio ingegno”.
Il mito e il racconto
Viceversa, se si disimpegna il richiamo all’opera aristotelica da qualunque intento pregiudiziale, nel senso della condanna o dell’apologia, si avrà la possibilità di evidenziare le potenzialità ermeneutiche implicite in un testo che esige d’essere comunque affrancato dall’ingombrante tutela delle controversie accademiche. L’elemento di gran lunga più importante della tragedia, secondo Aristotele, è il mýthos, vale a dire ciò che potremmo tradurre col termine “racconto”. È vero, infatti, che elementi della tragedia (e a maggior ragione di un film) sono anche lo “spettacolo” (ópsis) e la musica (e inoltre, il linguaggio, i caratteri e il pensiero), ma il mýthos è talmente preponderante rispetto agli altri, che si può giungere ad affermare che la “potenzialità” (dýnamis) della tragedia resta intatta, anche «in assenza di scena e di attori». Spinta all’estremo (ma è lo stesso Aristotele a raggiungere tale limite), questa affermazione implica che anche senza il “vedere”, senza l’ópsis, pur in mancanza dello “spettacolo”, ma solo “leggendo” il mýthos, esso riesca a indurre il “piacere” che è specifico della tragedia, vale a dire il terrore e la pietà.
La forte valorizzazione del racconto, come elemento decisivo e caratterizzante di quella forma di póiesis che è la tragedia, consente di mettere a fuoco un aspetto essenziale del ragionamento aristotelico. È il mýthos, e più in particolare il modo con cui esso è costruito, ciò che conferisce a un’opera poetica (a una concretizzazione di quella forma del fare che è la póiesis) la capacità di suscitare il coinvolgimento emotivo liberatorio negli spettatori (o negli ascoltatori). A essere fonte di páthos non sono, dunque, elementi puramente sussidiari, e comunque estrinseci rispetto alla composizione del racconto, quali sono appunto quelli che colpiscono i sensi della vista e dell’udito, ma piuttosto un aspetto strutturale, pertinente alla razionalità dell’impianto narrativo, riguardante le modalità con le quali i fatti descritti sono connessi in una trama ben organizzata. D’altra parte, l’enfasi su criteri capaci di evidenziare l’intelligibilità intrinseca della struttura narrativa, a scapito di requisiti connessi con l’ambito della sensibilità, discende consequenzialmente, almeno in Aristotele, da ciò che egli sostiene in generale riguardo alla póiesis. Occorre ricordare, infatti, che la superiorità attribuita alla poesia, rispetto alla storia, è motivata col fatto che la prima «dice gli universali», mentre la storia si limita ai particolari. Philosophóteron, dunque, “la cosa più filosofica” è la poesia, in quanto essa si riferisce a ciò che è “verosimile” (éikos), e che perciò intrattiene una relazione con l’universale nella forma della probabilità, mentre la storia si occupa soltanto di cose effettivamente accadute, in quanto tali inevitabilmente particolari. Tradotte sul piano delle opere cinematografiche, ossia in riferimento a opere nelle quali proprio alla vista e all’udito viene molto spesso affidato il compito di coinvolgere lo spettatore, queste osservazioni possono apparire, e in larga misura sono, perfino dirompenti. D’altra parte, almeno in quelle produzioni cinematografiche, per le quali si può ripetere quanto Aristotele affermava a proposito della tragedia, e cioè per quei film nei quali l’elemento di gran lunga più importante sia il racconto, le modalità di costituzione della trama (non quindi il suo contenuto, ma la sua forma) risultano essere davvero decisive.

