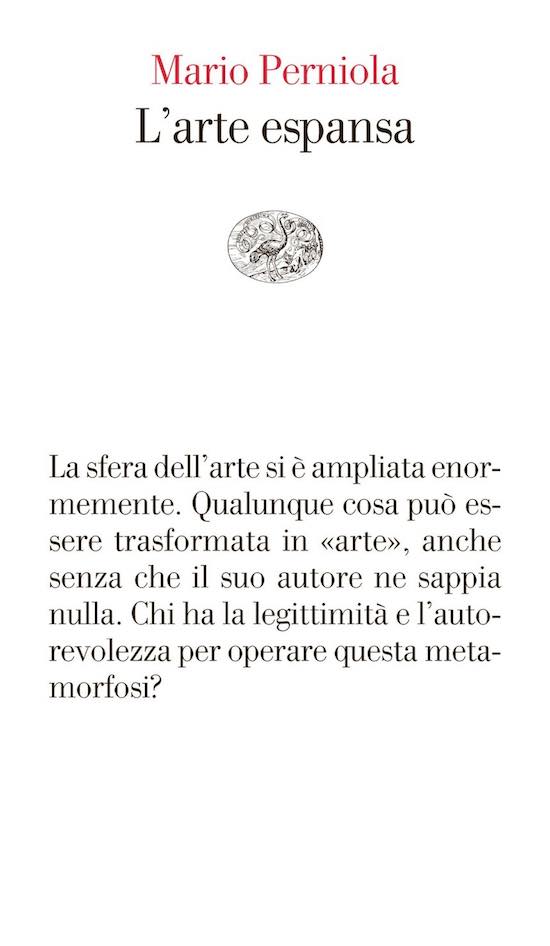
Se questo accade è perché non vi è nessun segno che identifichi e connoti le opere d’arte contemporanea in quanto tali. Forse non tutte, ma una buona parte di esse sì: basta toglierle dal piedistallo o dalla vetrina in cui sono state esposte ed elevate ad arte per renderle indistinguibili dal comune ciarpame. Se così stanno le cose, sarà vero anche il contrario: basta disporre in un luogo deputato all’esposizione – museo, galleria, mostra temporanea – un manufatto per farne un oggetto artistico tout court.
Non vi è nessun segno che identifichi e connoti le opere d’arte contemporanea in quanto tali.Come si è arrivati a una situazione del genere e quali implicazioni comporta per chi vuol fare arte, per chi si definisce artista e quindi in generale per lo statuto filosofico e ontologico di una disciplina che fino al Novecento prevedeva sistemi di accreditamento, modelli di apprendimento e quadri di riferimento estetici ben precisi?
Questa è la domanda intorno alla quale ruota il pamphlet di Mario Perniola, dal tono in parte polemico in parte propriamente descrittivo di uno stato di fatto che non suscita l’entusiasmo dell’autore, ma non sembra nemmeno passibile ai suoi occhi di un’alternativa prescrivibile.
I due fenomeni ai quali Perniola dedica maggior spazio sono la Biennale di Venezia del 2013, curata da Massimiliano Gioni e la Galleria d’arte londinese Saatchi. Entrambi sono visti come momenti di rottura rispetto a meccanismi consolidati a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, per cui alcuni artisti, in numero piuttosto limitato, avevano accesso alle gallerie, alle mostre e ai contributi critici che li avrebbero canonizzati e che avrebbero determinato un loro posizionamento sul mercato artistico con quotazioni crescenti.
Questo sistema del tutto autoreferenziale ha trovato un alleato formidabile, forse la propria forma consona nel tardo capitalismo dei paesi industriali, e affonda le proprie radici nella tabula rasa operata dalle avanguardie con la tradizione. Duchamp e i suoi ready made inaugurano il secolo in cui l’artisticità di un’opera non è data dalla sua fattura intrinseca, materica ed estetica, bensì dall’affermazione tautologica di essere arte e dal flusso comunicativo cui si lega; da lì in poi, fino alla Pop Art, la tendenza a dissolvere l’opera nel gesto, nell’atto teorico o comunicativo, sarà sempre forte e dominante.
Da Duchamp in poi, fino alla Pop Art, la tendenza a dissolvere l’opera nel gesto, nell’atto teorico o comunicativo, sarà sempre forte e dominante.Ne hanno sofferto con evidenza qualità che erano ritenute strettamente legate alle pratiche artistiche, come la manualità, il rapporto con il sapere erudito, la durevolezza delle opere stesse, spesso concepite come effimere o difficili da conservare perché fatte di materiali organici, deperibili, poco atti alla conservazione. Si tratta di aspetti che anche lo studioso francese Jean Clair aveva illustrato in molti suoi lavori, e soprattutto in Critica della modernità.
Ma Perniola si rapporta con fenomeni di lunga durata ed episodi recentissimi che ne riflettono le dinamiche. Secondo lo studioso, la Biennale di Venezia del 2013 da un lato rompe il cortocircuito fra grandi nomi – brand più che artisti – e platea espositiva, assemblando i materiali più vari: disegni di bambini, libri, opere di malati mentali, che vanno a comporre un ‘palazzo enciclopedico’ in cui non esistono gerarchie, ma forse solo corrispondenze analogiche, dall’altro radicalizza l’idea populistica secondo la quale l’arte può essere fatta da tutti, implicita già nelle Neovanguardie.
Perniola indica questo cambio di paradigma come una svolta fringe, termine che significa ciò che sta sui bordi, sui confini. Inglobando e superando tante discussioni che hanno percorso il Novecento – da quella sull’artistiticità delle opere prodotte da malati psichiatrici alla pretesa dell’Art brut che esistesse una produzione incolta, autentica, al riparo dal mondo esterno e dalle valutazione mercantile –, la Biennale del 2013 però non risolve, anzi estremizza, una domanda fondamentale: chi e come stabilisce ciò che è arte?
La domanda fondamentale è: chi e come stabilisce ciò che è arte?A un’analoga domanda inevasa porta la strategia messa in moto dalla Saatchi Gallery di Londra, storica antagonista politica della Tate Gallery. La Saatchi Gallery ha prima realizzato una galleria virtuale in cui chiunque poteva registrarsi ed esibire le proprie opere, democratizzando e allargando il mercato dell’arte fino ad avere più di 60.000 artisti visibili online, poi ha reintrodotto un criterio di selezione affidandolo, tuttavia, a cento curatori scelti senza specifiche garanzie scientifiche, titoli di studio o esperienze che ne accreditassero le competenze. Anche in questo caso il venire meno di un contesto critico in dialogo reale con gli artisti è funzionale a un allargamento del mercato – più opere si trovano disponibili e senza i tradizionali filtri –, ma ciò giova veramente all’arte come è stata intesa dalla modernità, ossia come un’espressione che non basta a se stessa, ma ha sempre bisogno di una forma di legittimazione teorica?
Non esiste più un’accezione univoca di arte, né un mondo dell’arte, ma diversi e coesistenti mondi.Proprio in risposta a questi movimenti la Biennale veneziana del 2015 ha segnato un ritorno all’Accademia, nel senso che moltissimi degli artisti esposti erano a loro volta studiosi, curatori, mediatori d’arte. La conclusione cui giunge l’autore è dunque che non esiste più un’accezione univoca di arte, né un mondo dell’arte, ma diversi e coesistenti mondi. “Una grande parte della produzione artistica del Novecento è un’arte senza opera come l’ha giustamente definita Jean Galard”, e sotto il segno di questa espansione infinita dell’arte, il cui rovescio è l’estetizzazione costante e superficiale della realtà, sembra muoversi ancora il nostro tempo.
L’arte espansa, di Mario Perniola, Einaudi, Torino 2015

