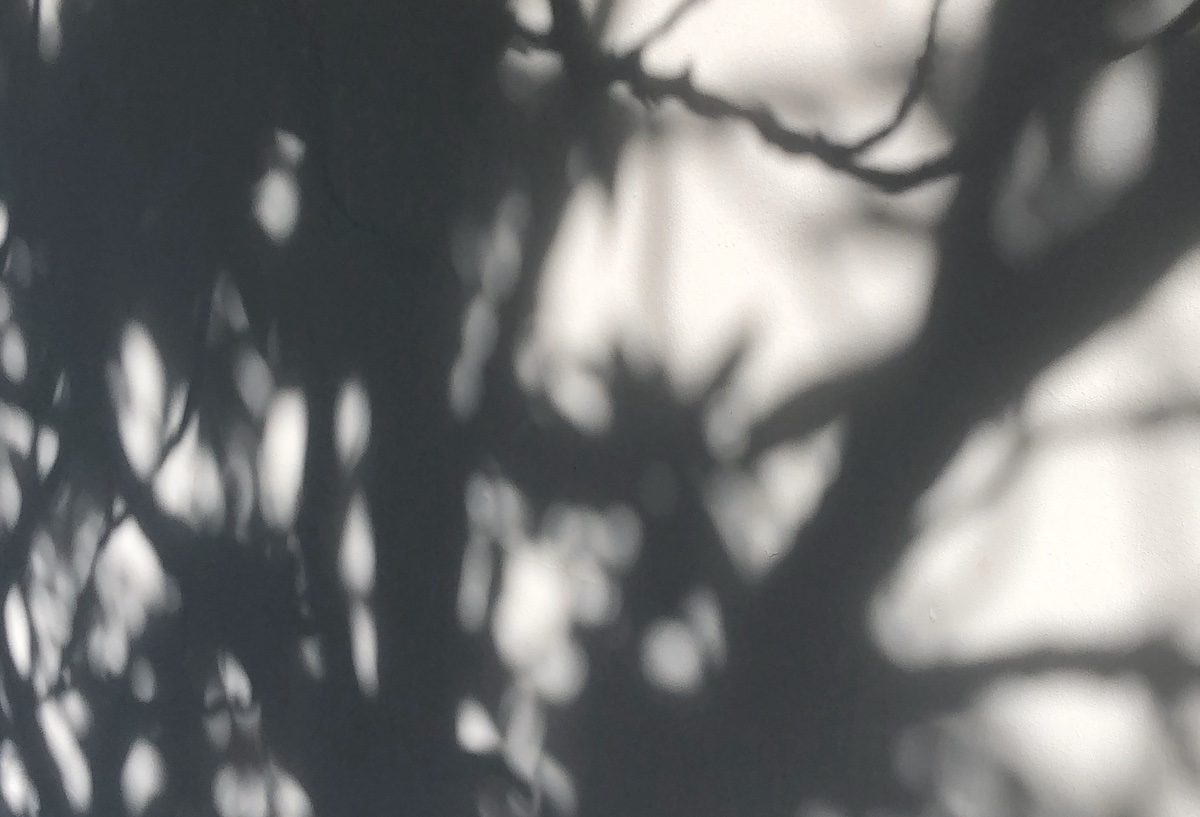Immaginatevi in una tenda, in campeggio. Alle prime ore del mattino, la luce cerca di entrare. Non riesce a farlo direttamente. Quindi si divide, si diffrange. Si insinua tra gli spazi infinitesimali del tessuto, della plastica. La poesia di Antonella Anedda si comporta allo stesso modo. Funziona per diffrazione. Non per collezione. Non mette insieme ordinatamente. Ma si dà come un corpo sul balcone, vede, enumera, collega, conosce, interpreta, secondo principi a volte sconosciuti, a volte interiorizzati nel tempo. La geometria delle cose non è più quella euclidea, ma forse iperbolica, ellittica o, fors’anche, proiettiva.
Geometrie (da Historiae, 2018)
Davanti alla dismisura delle cose cerco di provvedere,
scendo nel loro baratro. Ogni volta riemergo
con il metro, il compasso, la mente piena di cifre.
Mi struggo per la geometria, mi ostino inutilmente
a calcolare l’area del cubo, del parallelepipedo,
del prisma, nomi di un’aria di cristallo priva di veleno.
È un sogno infantile di teorema,
un innesto di mondo su un segmento di radice.
Se la osservi rimanda a un’equazione, al suo quadrato,
con l’ala dei numeri che svetta su ciò che è smisurato.
Le cose – le res e i realia – si pongono davanti nella loro essere fuori misura, senza proporzioni e senza possibilità di essere misurate. Di fronte a ciò la poeta sa cosa deve fare, per provvedere, usato qui nel suo senso più colloquiale: prendere delle decisioni mirate di fronte a una necessità, un bisogno. Questa decisione consiste nello scendere del baratro, che ricorda il gorgo montaliano del Mottetto II o quello pavesiano di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Un baratro che si dà con consapevolezza. Devo scendere nelle cose, nel profondo, inabissarmi per poter risalire con il metro, il compasso e la mente piena di cifre: per cercare di farmi geomètra.
Qual è geomètra che tutto s’affige
Per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova.
Di fronte alla dismisura delle cose, la poeta manifesta una volontà di conoscenza che ricorda quella dantesca, pur in un contesto laico. Anedda compie – si direbbe quotidianamente – un viaggio nella profondità della realtà, che si dà davanti al balcone del suo corpo, in una consapevole consistenza topologica. L’io lirico sa dov’è, è cosciente di cosa sta vedendo. Fatica a misurarlo e a dare misura a ciò che la sua vista osserva. Questo è lo sguardo diffrattivo. Chi è capace di dire, fino in fondo, ciò che vede? Chi saprebbe enumerare anche la più piccola particella sotto i suoi occhi? Nessuno: perché, ogni volta che lo accettiamo, si manifesta di fronte a noi «la dismisura delle cose». L’ineluttabilità di comunicarla è segno di un pensare adulto, che lascia all’infanzia la possibilità di un «teorema», di una «vista» superiore e di un linguaggio che forse saprebbe descrivere la smisuratezza del reale.
La poesia di Antonella Anedda apre spazi di riflessione, accogliendo la bellezza e il dramma della dismisura, che caratterizza il reale. Alimenta domande che sembrano tessere fili con altre esperienze letterarie (Lucrezio, Dante, Leopardi, Celan, Plath, De Angelis) e artistiche (Friedrich, Bruegel, Ray, Hopper, Fontana).
Che cosa vede l’occhio umano? Che cosa può descrivere? Che cos’è la realtà? Quale relazione può esserci tra essere umano e realtà? Quali limiti ha la parola?
Bibliografia
A. Anedda, Tutte le poesie, Garzanti, Milano 2023.
A. Anedda, Geografie, Garzanti, Milano 2021.
E. Morra, Scomporre quadri, immaginare mondi. Dinamiche figurative e percezione nella poesia di Antonella Anedda, in «Italianistica», 3, settembre-dicembre 2011, pp. 167-184.
A. Bongiorno La scienza di Antonella Anedda, in «Polisemie», 4, 2023, pp. 67-83.
R. Donati, Apri gli occhi e resisti. L’opera in versi e in prosa di Antonella Anedda, Carocci, Roma 2020.