
«Un classico – secondo Calvino – è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire». Alla ricerca di letture estive per i miei studenti che, con mio grande sconforto, ho scoperto essere prossimi al traguardo della maggiore età sapendo poco o nulla di epica classica, ho pensato che avrei potuto fare un’operazione a ritroso, mostrando loro la presenza di un classico per antonomasia, l’Odissea, nelle scritture, ma soprattutto nell’immaginario e nelle esperienze di vita di questo nostro tempo. Perché, sempre riprendendo Calvino, «è classico ciò che tende a relegare l’attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non può fare a meno»; e ancora, «classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona».
Verificherò il prossimo settembre se le letture consigliate saranno riuscite a creare la nostalgia di un’assenza nei miei studenti, ma intanto ho pensato di condividere con i lettori de «La ricerca» il piacere di ritrovare in libri molto recenti l’impronta di un’opera necessaria, di una bussola irrinunciabile per le navigazioni di ogni tempo.
Di mogli e di mariti
Nel 1997 Luigi Malerba pubblicò un fortunato romanzo: Itaca per sempre. Ulisse e Penelope in monologhi alternati, quindi secondo un duplice punto di vista, ripercorrono le vicende che hanno seguito il ritorno a Itaca dell’eroe, con qualche libertà rispetto al racconto omerico. La più interessante, forse, è quella che riguarda la protagonista femminile. Penelope, infatti, ha immediatamente riconosciuto il marito, nonostante vestisse i panni di un mendicante, e la sua diffidenza è solo un espediente femminile: ciò per far pesare al suo uomo i tanti anni di solitudine, solo in parte imputabili agli obblighi militari, ma soprattutto per vendicarsi della mancanza di fiducia dimostrata nel rivelarsi prima ad altri che a lei.
Se Ulisse antepone la complicità di Euriclea, Telemaco ed Eumeo a quella della sua sposa, Penelope, donna orgogliosa e saggia, a sua volta capace di macchinazioni (come quella della proverbiale tela), con la sottile psicologia di una donna moderna, differisce ad arte il momento dell’agnizione che avviene attraverso uno stratagemma (il riferimento al letto nuziale costruito nel tronco d’ulivo).
La storia coniugale, pur sprofondata nel passato assoluto dell’epica, viene riscritta da Malerba aprendosi a dinamiche di coppia e a profondità introspettive che appartengono più al nostro presente che al mondo omerico, ma senza per questo tradire il modello con maldestre operazioni attualizzanti.

Maria Grazia Ciani pubblica ora un nuovo romanzo intitolato La morte di Penelope (Marsilio, 2019) nel quale pure, come in Malerba, si ripercorrono i fatti seguenti l’arrivo di Ulisse a Itaca, ancora con una struttura fatta prevalentemente di brevi monologhi in prima persona dei due protagonisti. Ma questa volta i personaggi principali non sono Penelope e Ulisse, bensì Penelope e Antinoo, il capo dei Proci, un uomo e una donna divorati da una passione reciproca e sconveniente che li condurrà alla rovina.
Anche in questo libro Penelope non appartiene alla categoria di donne relegate in un cono d’ombra dalla società patriarcale, oneste, fedeli, prudenti e obbedienti, ma riveste il ruolo della donna libera e autonoma, bella e astuta (qualità normalmente estranea al mondo femminile, almeno nell’antichità). In altre parole, una minaccia per l’ordine costituito.
Ciani, seguendo una variante del mito tramandata nell’Epitome della Biblioteca di Apollodoro, narra di una sposa regina che medica la ferita dell’abbandono lasciandosi sedurre da un nuovo amore e che viene uccisa a causa della sua la infedeltà dal marito tradito, che pure del tutto fedele non le era stato. Ulisse, nei panni di uno straniero mendicante, non solo consuma la sua vendetta nei confronti dei pretendenti, ma usa l’ultima freccia dell’Arco del Re per eliminare la moglie fedifraga. Un delitto d’onore, un femminicidio in piena regola, dunque. Questo potrebbe essere il commento di un osservatore ingenuo, mentre il lettore accorto apprezza che la scrittrice contemporanea si sia fatta carico di una nota questione filologico-interpretativa e abbia seguito la trama sottile degli indizi che rendono Penelope un personaggio ambiguo e complesso, contraddittorio e volubile: a parte i dubbi insistenti sulla paternità di Telemaco sollevati qua e là nel poema, la regina di Itaca appare donna per nulla disinteressata, che accetta i doni dei Proci di buon grado e che è in procinto di risposarsi nonostante profezie e sogni suggeriscano un diverso esito della sua vicenda coniugale.
Ma la Penelope di Maria Grazia Ciani non è una donna spregiudicata: piuttosto è misteriosa e inquieta; impotente e incredula di fronte alla nascita di passioni e sentimenti ineludibili, fatica ad accettare i cambiamenti imposti dal tempo e dalle prove della vita, e diventa una fragile vittima: «contro l’impenetrabile sposa di Ulisse i Greci hanno giocato a modo loro, fantasiosi, cinici, bugiardi e detrattori quali erano per indole».

Di padri e di figli
L’Odissea ha dimostrato di essere strumento molto efficace per la lettura della relazione fra padri e figli, confermando che dal mito, dalle sue possibili risemantizzazioni e riscritture, possiamo ricavare una grammatica universale per la definizione dinamica e mai compiuta della nostra identità individuale e soggettiva.
Usciva nel 2013 Il complesso di Telemaco, un saggio di Massimo Recalcati edito da Feltrinelli basato sull’intuizione che la figura paterna, passati i tempi in cui poteva essere efficacemente rappresentata da un Edipo autoritario e da un Narciso inconsistente e incapace di reggere rapporti a-simmetrici, è oggi evaporata al pari di Ulisse per il giovane Telemaco, fattosi uomo con l’ingombrante peso di un padre assente.
Recalcati si ispira al figlio di Ulisse, al tormentato protagonista nei primi libri dell’Odissea – la cosiddetta Telemachia – per riferirsi al viaggio del giusto erede alla ricerca del proprio padre, allo scopo di ristabilire un ordine simbolico nell’incerto presente.

Il libro, d’ispirazione odissiaca fin dal titolo, su cui mi voglio soffermare è un’opera ibrida, che contamina le forme (fiction e auto-fiction, romanzo e saggio, biografia e diario di scuola). Si tratta di un’opera di Daniel Mendelsohn uscita in edizione originale nel 2017 ed edita in italiano da Einaudi l’anno successivo: Un’Odissea. Un padre, un figlio e un’epopea; essa promette pertanto, fin dal titolo scopertamente metaletterario, di proiettare in una prospettiva universale una storia unica (quella del rapporto fra l’autore e il padre, ma anche fra l’autore e i suoi allievi, figli a loro volta in un certo senso) ma non irripetibile, ossia governata da leggi che la letteratura fin dai suoi albori si è incaricata di fissare in forma di racconto.
«Sento di non aver mai davvero conosciuto mio padre finché non ho cominciato a leggere seriamente i classici» confessa lo scrittore americano: il libro racconta di Jay Mendelsohn che a ottant’anni decide di rileggere l’Odissea, una passione giovanile che le vicende della vita lo hanno costretto ad accantonare, partecipando ad un seminario tenuto al Bard College dal figlio Daniel.
I due protagonisti, che di professione sono rispettivamente un matematico (il padre) e un critico letterario di formazione classicista (il figlio) – mi pare interessante darne conto – a conclusione del corso, forti di una nuova consapevolezza come padre e come figlio, decidono di partire per una crociera a tema sui luoghi del poema omerico, propriamente un nóstos, in cui le tappe del viaggio di Ulisse restituiscono ai due viaggiatori la pienezza della loro relazione. Un viaggio, vale la pena di sottolinearlo, che, a differenza di quello narrato da Omero, non giungerà mai a destinazione: per ragioni contingenti Jay e Daniel non raggiungeranno mai la meta e Itaca rimarrà quindi un traguardo, un obiettivo a cui tendere, una risorsa dell’immaginazione e una potenzialità per cui vale la pena di mettersi in cammino.
Proprio come nella poesia di Costantino Kavafis, Itaca, che Daniel legge e commenta per i compagni di crociera, delusi per non essere sbarcati come da programma nella patria di Ulisse e incapaci di cogliere in prima battuta il significato simbolico di quel mancato approdo.
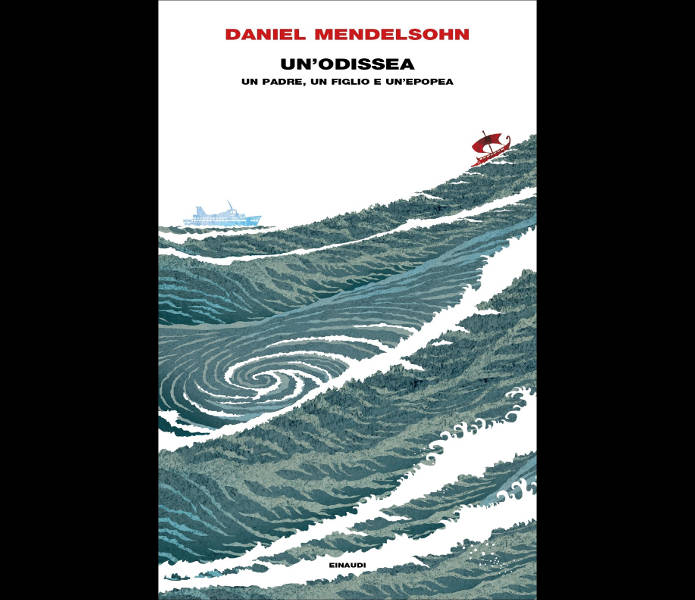
Di insegnanti e allievi
Di recensioni entusiaste a questo libro ne sono state scritte davvero molte; unendomi al coro dei consensi rischierei solo di dire peggio quello che è già stato scritto più autorevolmente da altri. Ma nella lettura affidata agli studenti di un testo così ricco e denso mi piace valorizzare un aspetto per niente secondario, anche se meno appariscente: non è solo il rapporto padre-figlio, ma anche quello maestro-allievo ad essere oggetto di un’indagine serrata dell’autore. Un’Odissea è il racconto di un percorso di educazione letteraria in cui il professor Mendelsohn agisce una pratica ermeneutica che si giova dell’ascolto e del dialogo, in cui il maestro, la figura di autorità, è disposto a lasciare la scena ai suoi allievi, a rinegoziare di conseguenza il proprio sapere, ad allargare il proprio orizzonte interpretativo non solo del testo in esame, ma soprattutto della realtà. Ripete così il gesto di Socrate, che nel Simposio spiega a Agatone che non è l’allievo a dover essere riempito dal maestro stando il più possibile prossimo a lui (cioè riproducendo passivamente un sapere già definito, chiuso), ma quest’ultimo a giovarsi della prossimità con l’allievo, che, compiendo il proprio percorso originale di ricerca di senso e di verità, offre al maestro la possibilità di cambiare la rotta del suo viaggio esistenziale perché gli impone di ridiscutere le relazioni con gli Altri (in special modo con il padre), gli fa scoprire una parte di sé sconosciuta e inespressa fino ad allora, gli fa guardare il mondo con un nuovo sguardo. Soprattutto gli rivela una parte di sé sbilanciata verso il futuro e non ripiegata verso il passato, una parte vitale e appassionata perché «gli insegnanti migliori sono quelli che ti spingono a trovare un significato nelle cose che hanno dato loro piacere, così che l’apprezzamento di quella bellezza sopravviva alla loro esistenza» (p. 217).

Leggere i classici
A settembre non chiederò ai miei studenti se dopo aver letto Un’Odissea è capitato loro di riflettere sul rapporto con i rispettivi padri, se sono d’accordo con lo scrittore americano quando afferma, ad esempio, che «i nostri genitori sono misteriosi ai nostri occhi in modi in cui noi non potremo mai esserlo per loro» (p. 153). Violerei in modo intempestivo con psicologismi maldestri un territorio troppo intimo e personale: meglio lasciar decantare e far affidamento sui possibili effetti a lento rilascio dell’assunto del libro. A settembre non chiederò nemmeno ai miei studenti se, nella ricostruzione delle vicende che hanno avuto come protagonisti Ulisse e Penelope, sia più credibile la versione di Omero, quella di Malerba o quella di Ciani: le storie sono tutte vere, soprattutto quelle inventate perché sono espressione metaforicamente, per via narrativa, della complessità della realtà e delle molteplici prospettive con cui la si guarda. Li inviterò piuttosto a ripensare il rapporto che hanno con quello che viene loro proposto nelle aule di scuola, soprattutto nelle ore di italiano: «leggere i classici [nel nostro caso l’Odissea omerica] è necessario per riconoscere il perenne della storia, ma anche per comprendere quanto resta ancora da fare per rispondere alle domande inevitabili. I classici sono un segno di pienezza, ma hanno sempre al loro interno una carenza, che è la richiesta ultima di risposta ai lettori di varie epoche». Per questo sono state scritte “altre” Odissee. E altre ancora ne verranno.

