![]()
Già noto per le sue ricerche sulle competenze digitali e sul rapporto tra apprendimento e utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, l’autore, che insegna Sociologia della cultura dei media all’Università di Milano-Bicocca, mette le basi per un nuovo approccio a quella media education che dovrebbe essere – analogamente a quanto è accaduto per l’educazione interculturale negli anni Novanta del secolo scorso – lo “sfondo integratore” della didattica degli anni Duemila.
Simone Giusti: Perché a dieta di media? Significa che siamo sovrappeso o addirittura obesi?
Marco Gui: In un certo senso sì, c’è questo rischio. Nel libro parlo di “obesità mediale” che, come quella alimentare, deriva da un accesso di quantità e da una cattiva selezione della qualità. In generale, nell’epoca che noi sociologi chiamiamo “modernità”, dalla rivoluzione industriale in poi, le persone sono state esposte sempre di più a una sovrabbondanza di prodotti di ogni tipo. Per molti tipi di consumo le competenze per gestire l’abbondanza sono diventate più rilevanti di quelle per far fronte alla scarsità. Il consumo di cibo e quello di comunicazione mostrano però somiglianze particolarmente interessanti. Sia il cibo che la comunicazione sono pratiche di consumo ordinarie, messe in atto più volte al giorno, con le quali quindi dobbiamo sempre fare i conti. In entrambi i casi poi rileviamo che alcuni nostri gusti (per il dolce, il grasso, il salato ma anche per le scene forti come quelle di violenza o per le notizie sensazionali) ci spingono a consumi impulsivi che dobbiamo essere in grado di dominare. Infine i problemi di gestione della sovrabbondanza sia di cibo che di comunicazione li troviamo più presenti nelle fasce deboli della popolazione.
SG: Il sottotitolo del libro fa riferimento alla qualità della vita. Puoi approfondire questo aspetto del tuo ragionamento?
MG: Sappiamo che i media digitali sono molto più pervasivi dei mezzi di comunicazione audiovisivi tradizionali, che avevano “colonizzato” solo il nostro tempo libero. I media digitali sono invece strumenti universali, e quindi la loro influenza sulla nostra vita è molto importante. Alcune rilevazioni americane hanno stimato che la permanenza media giornaliera davanti a uno schermo supera le 10 ore al giorno. Conseguentemente, dal nostro uso dei media dipendono sempre di più la nostra produttività nel lavoro, la gratificazione che deriva dal tempo libero, la significatività delle relazioni con amici e conoscenti. Ma anche il successo dell’organizzazione di una cena o di una vacanza. È sotto gli occhi di tutti che la Rete offre in tutti questi ambiti opportunità enormi e in gran parte inedite, ma è anche un fatto che la maggior parte degli utenti dei media manifesta difficoltà nel gestire tale abbondanza di opportunità. Una buona parte degli utenti di Internet afferma di stare online più di quanto vorrebbe, ha la sensazione di perdere tempo con informazioni non significative, lamenta problemi nell’organizzazione del tempo e nella produttività al computer, segnala frustrazione nel dover continuamente cambiare il focus della propria attenzione da uno stimolo ad un altro. La disponibilità immediata e permanente di informazioni e relazioni mediate rende il controllo di questi effetti collaterali sempre più importante per stare bene.
 SG: Il libro fornisce anche indicazioni pratiche. Cosa significa mettersi a dieta di media, esattamente? Ci sono delle esperienze condivisibili, dei consigli utili da dare soprattutto agli adulti?
SG: Il libro fornisce anche indicazioni pratiche. Cosa significa mettersi a dieta di media, esattamente? Ci sono delle esperienze condivisibili, dei consigli utili da dare soprattutto agli adulti?
MG: Il libro innanzitutto identifica quali sono nello specifico le aree che presentano una difficoltà di gestione, che sono essenzialmente quattro: la limitazione della quantità dell’uso, la scelta dei contenuti, la capacità di concentrarsi in un contesto di stimoli sovrabbondanti, la gestione delle relazioni umane mediate dalla tecnologia.
A ben vedere si tratta di dimensioni che si ritrovano anche nel rapporto col cibo: mangiare il giusto, mangiare bene (cibi sani), mangiare con gusto e senza trangugiare il cibo, essere conviviali cioè saper mangiare con gli altri…
Per ciascuna dimensione è importante prima di tutto effettuare un’auto osservazione, in modo da individuare le proprie abitudini e da misurare il nostro livello di soddisfazione (utile farsi aiutare da strumenti software, per esempio Rescue Time, che registra come spediamo il nostro tempo online).
L’auto osservazione è già un notevole passo avanti in direzione del miglioramento della qualità della vita. Se per esempio ci accorgiamo di frammentare molto le nostre attività online tra lavoro, svago, social network e un continuo controllo dell’email potremmo valutare se questo comportamento ci rende più o meno soddisfatti al termine di una sessione al computer o al tablet (di solito meno). Ma la dimensione individuale non è sufficiente, soprattutto se si vuole che la consapevolezza degli effetti collaterali del digitale si diffonda largamente nella popolazione e non resti appannaggio di chi ha già capacità di adattamento maggiori. Da sociologo mi interessa molto l’aspetto collettivo di queste problematiche e il loro rapporto con la disuguaglianza sociale.
SG: In questo particolare momento storico, molte istituzioni pubbliche nazionali e internazionali si impegnano nella lotta all’obesità. Succede qualcosa di analogo per l’obesità mediale? Ci sono delle misure pubbliche che tu giudichi più utili e opportune?
MG: Come è stato fatto con l’emergenza dell’obesità, ma anche nel caso del nostro rapporto con l’ambiente, occorre veicolare l’idea che il benessere si costruisce anche con un rapporto equilibrato con la tecnologia. L’obesità di media deve diventare un problema sentito collettivamente. Questo può essere fatto con la comunicazione di pubblica utilità ma anche con misure concrete, come sono state in altri ambiti le norme che limitano il bis nelle mense scolastiche o che incentivano il consumo di frutta durante gli intervalli. Perché non prevedere in famiglia, ad esempio, qualche momento net-free, mentre si mangia o durante un viaggio in macchina? Oppure durante le riunioni di lavoro? Rispetto al cibo e all’ambiente siamo oggi molto più informati e consapevoli di vent’anni fa. Nel campo dei media la strada è ancora all’inizio.
Fondamentale è anche la contrattazione da parte dei cittadini e delle istituzioni con i produttori di tecnologie affinché queste ultime siano costruite in modo da favorire la qualità della vita. Faccio un esempio pratico: esiste nell’iPhone una funzione che si chiama “non disturbare”, che blocca automaticamente tutte le notifiche e le chiamate se non quelle provenienti da persone particolari. E’ un esempio banale ma importante di una possibilità tecnologica che ci aiuta a preservare una sfera protetta. Il fatto poi che le persone attivino effettivamente questa funzione quando incontrano un amico importante o quando ascoltano un bel brano musicale dipende dal cambiamento culturale di cui parlavo prima.
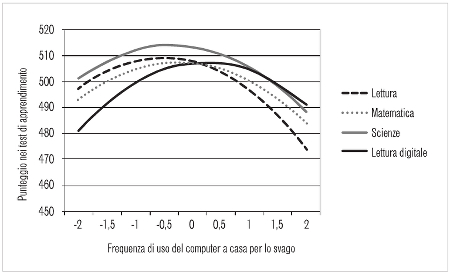
SG: E per la scuola, emergono dalle tue ricerche delle indicazioni particolari?
MG: La scuola è lo strumento più importante per costruire misure pubbliche sull’uso consapevole dei media. La scuola è certamente il luogo migliore per formare i giovani a un uso critico delle nuove tecnologie, che finora sono nate e si sono sviluppate completamente al di fuori degli ambienti intenzionalmente educativi.
Bisogna però distinguere tra un uso dei media nella didattica e un’educazione all’uso consapevole dei media nella vita quotidiana. Entrambe sono frontiere per la scuola in questo momento, ma nel libro mi sono concentrato più sulla seconda. Secondo me l’emergenza non è tanto quella di usare tecnologie avanzatissime dentro le classi ma piuttosto di educare gli studenti a saper sfruttare l’ambiente comunicativo digitale in cui sono inseriti per avere più chance nella loro vita futura e per vivere meglio. Per esempio, da docente mi preoccuperei di più di discutere con i miei studenti di come pianificare un pomeriggio di studio a casa sfruttando le opportunità della Rete senza diventarne schiavo piuttosto che di fare lezione con la tecnologia.
SG: Sul versante della didattica con le tecnologie però ferve il dibattito. Si parla di “total tablet”, cioè di totale sostituzione dei libri con i tablet: sei favorevole ad andare in questa direzione?
MG: Secondo me l’uso dei tablet può essere molto utile in classe, ma è fondamentale essere consapevoli che il suo uso generalizzato fa perdere qualcosa; per esempio l’abitudine a saper approcciare un testo privo delle caratteristiche attrattive dei contenuti multimediali. Il rischio è che ci si abitui ad avere costantemente una stimolazione attraente, che però non sempre si sposa con la profondità dell’analisi e dello studio. In alcuni istituti tecnici che sto visitando per una ricerca [si tratta di una ricerca che stiamo svolgendo insieme sull’impatto delle nuove tecnologie sulla didattica, N.d.A.] abbiamo trovato insegnanti soddisfatti dell’uso intensivo delle tecnologie a scuola ma anche sorpresi dal fatto che i loro alunni una volta all’università facessero fatica a tornare a studiare intensamente sui libri. La domanda è: vogliamo dare per superata l’importanza di questa capacità? Io rispondo di no. Sulla base delle evidenze ancora frammentarie che esistono su questo, ritengo che la conoscenza umana quand’è complessa abbia bisogno di educarsi alla fatica della concentrazione per produrre innovazione. Credo che l’uomo di cultura del futuro deve sapere navigare nella Rete ma anche scendere in profondità dentro un testo, e il tablet non è lo strumento migliore per sviluppare questa capacità. Il libro di Casati – Contro il colonialismo digitale, Laterza, Bari 2013 [qui un approfondimento su La ricerca, N.d.R.] – mette in luce brillantemente alcune delle ragioni per cui non lo è. Inoltre c’è da ricordare, specie nelle scuole primarie, che lo sviluppo della manualità che si accompagna alla scrittura con la penna è tuttora importante, forse ancora di più nel contesto dematerializzato di oggi. Infine, la lettura sugli schermi fa emergere anche alcuni problemi alla vista. Sarei perciò cauto nel prevedere sostituzioni totali, specie alle primarie e nei licei.

