All’inizio fu Roger Waters. La mia prima esperienza letteraria significativa – se escludiamo un’improvvisa passione da quattordicenne per una poesia di Bertolt Brecht – è stata l’ascolto attento, col dito puntato sul testo scritto all’interno della copertina di 30 centimetri per 30 del vinile di The Wall dei Pink Floyd. A quel testo sono tornato nel corso di tutta l’adolescenza, ossessivamente quasi, alla ricerca di un ordine ai miei pensieri, paure e desideri. Credo di doverlo a Andrea, il mio compagno di banco e sodale di tutta la vita, e quindi a suo fratello Paolo, la nostra guida nella canzone rock degli anni Sessanta e Settanta.
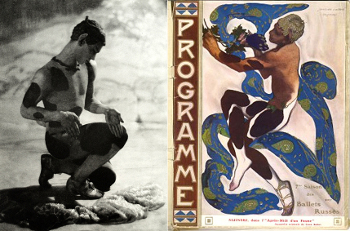
La giovinezza la farei iniziare con l’Après midi d’un faune di Mallarmé letto e riletto nel bagno di Filippo, a Roma. Non ci capivo molto allora – e ancora oggi non migliora la situazione – ma faccio risalire a quell’esperienza il mio modo di avvicinarmi alla poesia: attraverso la mediazione di un rapporto di amicizia e a partire da una lettura disordinata, a apertura di pagina, compitata parola per parola, verso per verso, risalendo dal contatto verso la lettura ad alta voce e poi la comprensione. A quel libro faccio risalire la scelta definitiva del francese come mia lingua d’elezione: la lingua di Parigi, della poesia e della pittura dei miei adorati impressionisti.
La lingua italiana ho cominciato a amarla invece a partire da Fra la via Emilia e il West di Francesco Guccini: chissà che a quel doppio album – che possedevo in forma di audiocassetta e quindi era destinato a essere ascoltato in auto e poi, soprattutto, a essere ripetuto a memoria e cantato in compagnia, come ancora si usava fare almeno fino agli anni della scuola. È con quel testo che ho dato un senso alla mia pianura. E lì dentro devo aver trovato più di uno spunto per la mia scrittura “western”.
All’università, invece, si leggeva (noi letterati specialmente, pensavo un tempo, ma ho imparato che non è poi così vero) di tutto. Per me, che ero un perito agrario di provincia inurbato a Firenze, sono stati anni di continuo smarrimento e ritrovamento nella lettura. Il libro più importante dev’essere stato lo Scheiwiller rosso delle Poesie di Camillo Sbarbaro. Ricordo il momento dell’incontro, in uno scaffale della libreria Le Monnier, vicino all’ora di chiusura. Non conoscevo Sbarbaro se non attraverso il poco proficuo esame di letteratura italiana contemporanea. Ma il giorno dopo incontrai per caso, nella biblioteca di piazza Brunelleschi, il mio maestro Domenico De Robertis, che mi propose – eludendo la mia richiesta di fare la tesi su Caproni – di lavorare sui Trucioli di Camillo Sbarbaro, divenuto da quel momento il libro mio protetto e protettore: il talismano a cui sono rimasto attaccato per buona parte della vita e che ancora oggi consulto come un oracolo quando sento il bisogno di esprimermi a me stesso.
Poesie statiche di Benn l’ho usato per presentarmi in pubblico la prima volta e ancora oggi credo sia il libro in cui più agevolmente riesco a rilassarmi e ritrovarmi. Con alcuni amici avevamo costituito una compagnia teatrale intenzionata a rappresentare sul palco i propri testi: poesie, canzoni e monologhi tenuti insieme da un filo conduttore e da una messa in scena studiata apposta per rendere evidenti le rispettive poetiche, le distinte e tuttavia interagenti visioni del mondo. Io – che ero il regista occulto della messa in scena – stavo in un angolo e, man mano che gli altri rivelavano il proprio personaggio, mi ricoprivo progressivamente di fango, recitando pochi versi modellati sulla poesia conclusiva del libro di Benn (che non si può leggere se non insieme all’altro suo capolavoro Aprèslude).
Una volta è il libro di poesie e fotografie di Wim Wenders. Posseggo la versione italiana autografata dall’autore grazie all’intercessione della mia compagna di allora. È il suo regalo più bello, e io l’ho usato e lo uso ancora per spiegarmi la mia visione dell’arte letteraria come esperienza relazionale situata in un tempo e in uno spazio precisi. Wenders “spara foto” e poi scrive una nota di diario (in versi) che in qualche modo rappresenta il rinculo della macchina fotografica tradotto in forma linguistica. È un modo di lavorare analogo a quello dell’amato Kerouac e di Giovanni Lindo Ferretti e dei suoi CSI (ho combattuto molto con me stesso per non includere nella lista il cd di Ko de mondo, ma non posso non nominarlo!).
Le poesie di Bodini sono il mio livre de chevet salentino: ancora una pianura a cui dare un senso e un amore, quello per la donna che sarebbe diventata mia moglie, da coltivare. Questo è stato ed è ancora il suo libro e quindi il nostro, attraverso il quale rinnovare, a ogni estate, persi tra i dadi bianchi delle case, il nostro patto.
Potrei considerare – e non prendetela per una provocazione – Harry Potter della Rowling il mio libro della maturità. Stavolta è un romanzo, addirittura una saga. I sette romanzi li ho letti tutti d’un fiato: per mio figlio Giovanni, e poi per Maria e, infine, per me, che avevo bisogno, ieri come oggi, di incantesimi per potenziare le mie capacità cognitive e di strumenti per lavorare a scuola, ma anche per giustificare la scuola, per dare un significato alla sua esistenza e al mio essere a scuola.
Ma non voglio deludere gli amici tralasciando Il conte di Montecristo di Dumas (e siamo quindi a nove tra dischi e libri, e appena al secondo romanzo). Ne posseggo sei edizioni e conservo i dvd dei film e degli sceneggiati televisivi. Ci sono andato a vivere per un lungo periodo: sono stato Edmond Dantès nelle sue varie incarnazioni e l’Abate Faria, ho inventato giochi e li ho ripetuti decine di volte con alunni di ogni età. Oggi questo libro è esemplare del mio rapporto con la scuola e della mia ricerca sull’approccio narrativo nell’ambito della formazione e dell’orientamento (e, quindi, del mio rapporto con Federico Batini e con il gruppo di lavoro che si è autonominato “Le storie siamo noi”).
Infine, concludo la rassegna con il primo disco che ho comprato in formato digitale su iTunes: Il pilota e la cameriera di Filippo Gatti. La prima canzone – Country song – conduce dalla mia pianura (più esattamente dal mare di Alberese, di fronte al Giglio e a Montecristo) alle colline che la circondano. Il ritornello di quest’inno epicureo dice: “e tutto quello di cui non ho bisogno lo trovo facilmente e quello di cui ho bisogno non lo trovo mai”. Gli fanno eco, nell’ultimo pezzo del disco, i versi: “Rimani un attimo qui / adesso che c’è un po’ di sole / con questa luce / mi ricordi il giorno che / un seme cresce se / c’è un po’ di acqua e un po’ di sole / abbiamo visto già / troppe nuvole”. E mi viene voglia di leggere un’altra poesia, di ascoltare una canzone, di intrufolarmi ancora in un romanzo a caso.

