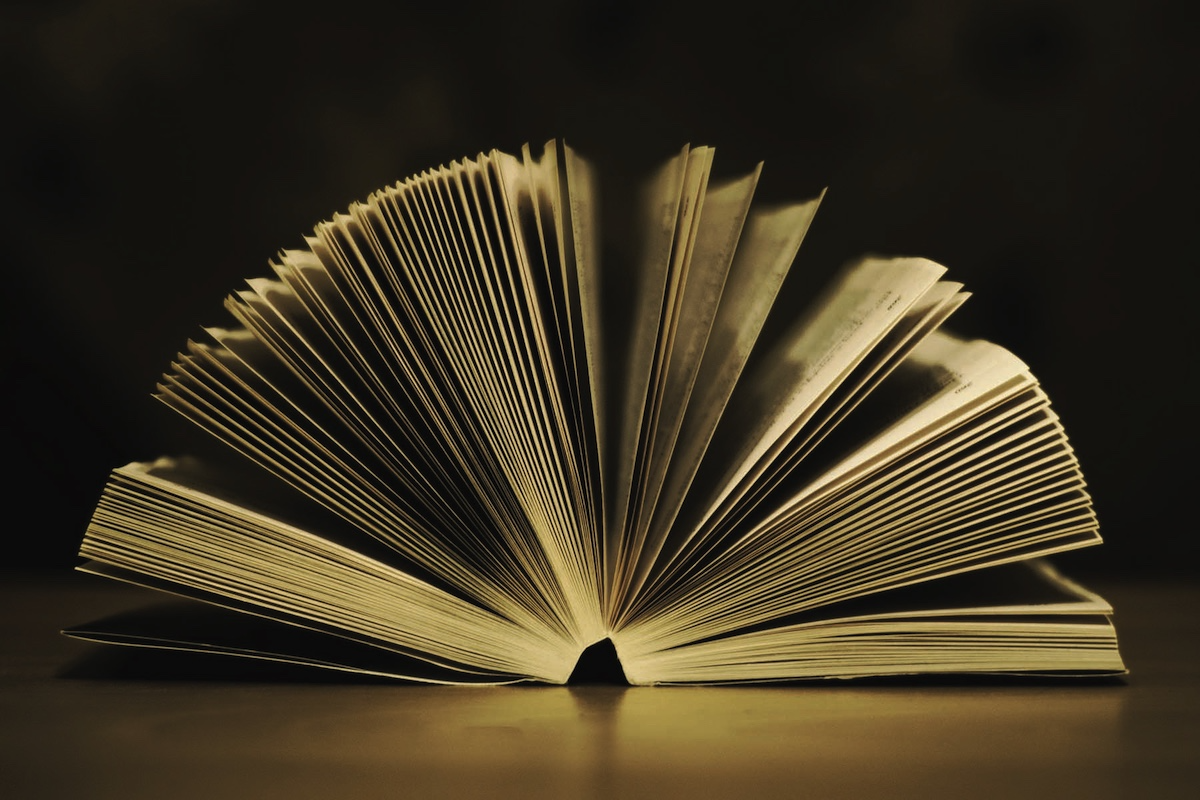
C’è una considerazione semplice dalla quale dovrebbe partire ogni riflessione sulla lettura e rispetto alla quale anche gli addetti ai lavori dovrebbero essere più consapevoli, soprattutto adesso, nel tempo fragile e accelerato che stiamo vivendo1: ogni libro è una comunità. E non solo perché ogni libro racconta una storia che crea un legame tra l’autore e i suoi lettori, ma perché oggi, più che mai, è attorno a una storia che può nascere una rete di persone che è anche una rete di emozioni, di linguaggi condivisi e di riconoscimenti reciproci2.
E questo è importante, perché viviamo un’epoca segnata da una grande contraddizione: sappiamo bene di essere costantemente connessi, ma spesso ci sentiamo terribilmente soli. La solitudine – quella emotiva, relazionale, esistenziale – è una delle sfide invisibili eppure più urgenti del nostro tempo. È la pandemia del tempo in cui viviamo3.
Per questa ragione tutte e tutti noi, che operiamo nel mondo del libro, dovremmo essere consapevoli di un aspetto fondamentale: la lettura non è soltanto un piacere privato, ma è un atto trasformativo con profonde ricadute sociali4. Ecco allora che la parola comunità5 ha un significato molto preciso: per me una comunità è un territorio in cui gli abitanti si legano in un «impegno donativo dell’uno nei confronti dell’altro»6. Sento il bisogno di insistere sull’importanza di una maggiore consapevolezza, perché ho l’impressione che su questo tema ci sia ancora un po’ di confusione. Per questo, vorrei provare a chiarire il cuore della mia idea, passo dopo passo.
Community e comunità
La lettura condivisa è intrinsecamente legata alle storie e all’oggetto libro da sempre, ma nella nostra contemporaneità, se parliamo di “condivisione”, purtroppo la prima immagine che ci viene in mente è quella di ciò che avviene sui social. La parola “condividere” sta ormai a indicare un gesto digitale come cliccare, postare, taggare, anche se ha un’origine e un significato molto più profondi, legati alla relazione umana, alla prossimità, allo scambio reale.
Per spiegare meglio cosa intendo parto una data precisa: è il 20 marzo 2021 quando, sul «New York Times», esce un articolo dal titolo How Crying on TikTok Sells Books, ovvero Quando le lacrime su TikTok fanno vendere libri, e si comincia a dare attenzione al fenomeno #BookTok7. Digitando questo hashtag nell’app di TikTok si accede a una sorta di portale letterario virtuale, fatto di video brevi e veloci per lo più, che soprattutto in un certo periodo ha aiutato migliaia di persone a sentirsi più vicine grazie alla passione per la lettura, specialmente durante i mesi più segnati dalla pandemia, ma anche dopo. E anche oggi. Il mondo editoriale si è accorto di questo osservando i dati, quando cioè sono tornati in classifica libri pubblicati anni prima, come La canzone di Achille di Madeline Miller – che era appunto uno dei libri che fanno piangere – o quando sono diventati fenomeni editoriali libri nati proprio nel contesto della rete e del social reading, come il fabbricante di lacrime8.
Ma cosa accade esattamente all’interno di questi ambienti digitali? Questa è, senza dubbio, la prima domanda a cui è necessario provare a rispondere, sebbene la risposta non sia affatto semplice. I libri che diventano “virali” su piattaforme come TikTok – in particolare all’interno della community #BookTok – sembrano condividere una caratteristica centrale: la capacità di generare una forte reazione emotiva collettiva. Rispetto all’esempio specifico è come se le lacrime fossero diventate un badge di appartenenza a una comunità emotiva. Anzi: a una community. Perché bisogna chiamare le cose nel modo giusto. La comunità è una cosa diversa, e nella parte introduttiva di questa riflessione ho cercato subito di chiarirlo.
È proprio grazie all’analisi di queste community che possiamo iniziare a delineare il profilo di un particolare tipo di lettore: vorace, intensamente partecipe, disposto a mostrare le proprie emozioni. Lettori che piangono, si arrabbiano o gioiscono per un libro, e che condividono queste reazioni in forma pubblica. I creator di #BookTok hanno fatto di questa modalità di fruizione e narrazione una vera e propria estetica, contribuendo a ridefinire i meccanismi della mediazione culturale. Il fenomeno risulta particolarmente interessante perché mette in discussione il concetto tradizionale di “fiducia”. Se in passato erano gli inserti culturali e le recensioni su carta stampata a guidare le scelte dei lettori, qui assistiamo a qualcosa di diverso, di più sottile, che ha a che vedere con l’empatia, con la risonanza emotiva e, appunto, con la condivisione.
I lettori su #BookTok non cercano “il libro giusto” in senso assoluto, ma quello che “parla a loro” in quel preciso momento della loro vita. E il consiglio che funziona non è più quello autorevole, ma quello (percepito come) autentico. TikTok, poi, grazie al suo algoritmo, dimostra una capacità quasi sovrannaturale di selezionare contenuti rilevanti e anche molto specifici per le persone giuste. In fondo, potremmo dire che librai e bibliotecari fanno (o dovrebbero fare) qualcosa di non molto diverso: accompagnare le persone verso le storie che possono toccarle, risuonare con le loro vite, e – in qualche modo – trasformarle.
Per tutte queste ragioni, il fenomeno della community di #BookTok ha smesso di essere percepito come una moda: a lungo è stato guardato dall’alto al basso da una certa editoria, e con una specie di sorrisetto sprezzante, ma a un certo punto si è capito che era diventato qualcosa di dirompente. E quando è successo? Quando la trasformazione ha cominciato a riguardare il mondo analogico, il mondo “reale” – non dico “vero” perché anche quello digitale lo è: in qualche modo, le community hanno cominciato a cambiare il modo in cui le persone scoprono i libri, li vivono, e soprattutto li raccontano agli altri. Porto solo tre esempi: è cambiato lo spazio dedicato a #BookTok nelle fiere, e se guardiamo al Salone del libro di Torino è evidente; è cambiato il ruolo dei creator, che sempre più diventano consulenti di case editrici; infine, è cambiato lo spazio delle librerie9.
Le nuove comunità della conoscenza
L’entusiasmo che circonda il fenomeno dirompente di #BookTok – la sua capacità di generare risonanza emotiva, i dati di vendita, il ruolo crescente dei creator come nuovi mediatori culturali e la trasformazione degli spazi fisici delle librerie – rischia talvolta di oscurare un’altra dinamica, meno visibile ma straordinariamente rilevante: il bisogno diffuso di esperienze tangibili, di connessioni reali, lente, profondamente umane, che i libri letti insieme possono stimolare.
A conferma di questa tendenza, osserviamo in Italia un fenomeno che sta crescendo con forza: l’esplosione dei gruppi di lettura10. Una pratica sociale affatto nuova che non solo resiste alle trasformazioni dell’ecosistema digitale, ma che al contrario sembra trarne nuova linfa vitale. È in questo contesto che si colloca la ricerca nazionale S.T.O.R.I.E. – Storie Trasformative, Opportunità, Relazioni, Inclusione ed Emozioni, promossa dall’Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) e dal Centro per il Libro e la Lettura, e realizzata dal Laboratorio di Biblioteconomia Sociale e Ricerca Applicata alle Biblioteche (BIBLAB) dell’Università Sapienza di Roma, che ho il piacere di dirigere11.
La ricerca, tuttora in corso mentre scrivo, si propone di mappare e comprendere le forme di socialità legate alla lettura condivisa, restituendo uno sguardo approfondito sulle pratiche di gruppo, sulle relazioni che si generano attorno ai libri, sui benefici percepiti e sull’impatto culturale e sociale di queste esperienze, con uno sguardo attento alla bibliodiversità. S.T.O.R.I.E. è il titolo della ricerca, ed è un nome che evoca la meraviglia, ma è anche un acronimo che sta per Storie Trasformative, Opportunità, Relazioni, Inclusione ed Emozioni.
Torniamo allora al punto centrale di questa riflessione: la lettura non è solo un piacere privato, un atto solitario, ma è anche – e sempre più – un gesto trasformativo a valenza collettiva, capace di generare impatti sociali.
Nonostante la forza aggregativa e comunicativa delle community digitali, si va delineando con sempre maggiore chiarezza il limite strutturale dell’esperienza di condivisione online: l’impossibilità di sostituire del tutto la dimensione relazionale incarnata fatta di presenza e reciprocità. Le community nate attorno ai libri – anche quelle più vive e attive sui social – sembrano oggi avvertire il bisogno di luoghi fisici, di spazi tangibili in cui ritrovarsi e riconoscersi. Si tratta di un passaggio rilevante. Anche alcune creator influenti continuano a utilizzare i social come strumento fondamentale per mantenere viva la comunicazione con la propria community, ma al contempo organizzano book club in presenza, rispondendo così a una domanda più profonda: il bisogno umano di relazioni che non siano soltanto connessioni e che si nutrano di sguardi, voci, corpi.
In questa nuova ecologia della socialità legata alla lettura, le biblioteche, le librerie – e più in generale i presìdi culturali di prossimità e tutte le infrastrutture del libro – tornano a occupare un ruolo centrale12.
È a partire da questa intuizione che ha preso forma il mio percorso di ricerca e osservazione all’interno di quelle che definisco le “nuove comunità della conoscenza”13: forme di socialità che si sviluppano intorno alla lettura e grazie alla condivisione di storie. Il punto di partenza è duplice: da un lato, la consapevolezza che la lettura è oggi attraversata da una rivoluzione silenziosa ma profondamente trasformativa, che ne modifica le pratiche, le posture cognitive e i tempi. Un esempio emblematico è lo skimming, ovvero la capacità – e spesso la necessità – di estrarre dai testi solo le informazioni essenziali, in un’ottica di risparmio cognitivo e ottimizzazione del tempo. Dall’altro lato, però, emerge con forza l’idea che la lettura, quando vissuta in forma condivisa, possa essa stessa generare una rivoluzione, proprio per la sua forza trasformativa e per la capacità di generare impatti che vanno ben oltre l’ambito editoriale, e toccano alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo: il contrasto alla solitudine, l’inclusione sociale, la costruzione della salute, lo sviluppo del pensiero critico e dell’empatia.
Quando si parla del valore della lettura, si fa spesso riferimento – giustamente – al suo ruolo nel contrasto all’analfabetismo funzionale; tuttavia, a questo livello andrebbe affiancata con pari attenzione una dimensione ancora poco esplorata ma cruciale: il contrasto all’analfabetismo emotivo, che ha a che vedere con l’incapacità di comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri. In un tempo che spesso ci chiede di semplificare, essere performativi ma senza scendere in profondità, la lettura offre un’opportunità controcorrente: quella di abitare la complessità dell’umano, in tutte le sue sfumature cognitive ed emozionali14. È per questo che parlare di promozione della lettura, oggi, significa anche prendersi cura della qualità delle relazioni, del benessere bio-psico-sociale15 e dell’intelligenza affettiva delle persone.
Il problema del tempo umano
Viviamo in un’epoca in cui la scarsità non è più solo economica, ma esistenziale: la vera risorsa scarsa è il tempo umano. Tempo per sentire, per riflettere, per connetterci davvero con gli altri. Ecco allora che i libri e le comunità che si formano attorno a essi diventano una risposta collettiva a questa mancanza.
La visione di biblioteca come nodo del sistema del benessere16 che propongo ha a che vedere con questo, con la possibilità di “prendere tempo al tempo” e di agire sulle diverse sfumature che caratterizzano il senso di mancanza e di accelerazione a cui tutti siamo sottoposti che erroneamente attribuiamo al volume del tempo – come se ci mancasse in termini di quantità – ma che ha a che vedere invece con due altre due questioni: la disorganizzazione temporale e la densità temporale17.
Uno degli elementi meno visibili ma più determinanti del nostro tempo è la disorganizzazione temporale: una condizione che riguarda la crescente difficoltà nel sincronizzare le nostre attività con quelle degli altri. Ed è proprio su questa difficoltà che si gioca una delle sfide più profonde della contemporaneità, legata al contrasto alla solitudine. Il tempo, infatti, non è solo una misura quantitativa ma ha anche una qualità, un ritmo, che modella profondamente la nostra esperienza del mondo. Siamo, in un certo senso, il ritmo del tempo che viviamo. Quando questo ritmo diventa individuale, frammentato, asincrono, le pratiche collettive che un tempo scandivano la socialità si indeboliscono o si sgretolano. In questo scenario, non sorprende che le infrastrutture culturali sia-
no state a lungo trascurate, percepite come non urgenti. Eppure, proprio per questo, oggi risultano più necessarie che mai18.
Accanto alla disorganizzazione temporale, un altro concetto cruciale è quello di densità temporale, legata all’uso delle tecnologie, ma con una sfumatura diversa: qui non è la sequenzialità delle azioni a essere problematica, bensì la simultaneità. Le tecnologie digitali, infatti, ci consentono – e talvolta ci impongono – di svolgere più attività nello stesso momento. Ma noi non siamo multitasking, e finiamo con l’essere solo molto distratti19.
Conclusioni
Ecco allora perché le librerie, le biblioteche e in generale le infrastrutture del libro agenti di sviluppo di comunità sono così importanti. Non occorre certo dilungarsi ancora sull’importanza della lettura per lo sviluppo sociale e per il benessere, sono temi che tutti conosciamo bene; tuttavia, voglio sottolineare come il mondo della salute e della cura stia guardando alla lettura con crescente interesse. Eppure, le infrastrutture del libro – riconosciute tra i cosiddetti “determinanti sociali della salute” – soffrono di una distribuzione estremamente disomogenea. Dai dati Istat al 2022 emerge che il 30,9% dei comuni in Italia è privo di qualsiasi infrastruttura del libro – librerie, biblioteche pubbliche e scolastiche –, ci sono cioè 2.438 “comuni-deserti del libro”. Circa 4 milioni di persone vivono in questi comuni, mentre oltre 32 milioni risiedono in comuni con una bassa varietà di infrastrutture, ovvero con la presenza almeno di una libreria o di una biblioteca oppure di una biblioteca scolastica20. Ma se pensiamo che ogni libro è una comunità perché ci mette in relazione con qualcosa di più grande di una community – con la nostra interiorità prima di tutto e con il nostro tempo umano – allora migliorare l’accesso ai libri implementando la rete infrastrutturale del libro diventa una priorità che non possiamo più trascurare.
Note
- Cfr. P. Chabot, Avere tempo. Saggio di cronosofia, trad. it. di S. Bertolini, Treccani, Roma 2022.
- Il testo di questo contributo riprende alcune considerazioni elaborate in occasione di “La libreria in sei atti. Parole che raccontano un mestiere. Sei voci, sei esperienze, un’unica passione: la libreria”, l’inaugurazione della XIX edizione della Scuola librai italiani organizzata dall’Associazione librai italiani lo scorso 8 aprile a Roma al teatro Parioli, dove ho proposto una riflessione sulla parola “comunità”.
- N. Hertz, Il secolo della solitudine. L’importanza della comunità nell’economia e nella vita di tutti i giorni, trad. it. di L. Muneratto, Il Saggiatore, Milano 2021.
- Rimando al mio Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza, Bari-Roma, Laterza, 2025.
- L’idea di comunità come migliore manifestazione possibile dei rapporti umani e della vita sociale è approfondita per la prima volta dal sociologo tedesco Ferdinand Tönnies nel 1887 nell’opera Gemeinschaft und Gesellschaft che in Italia esce con il titolo Italia Comunità e Società nel 1963 per Edizioni di Comunità – non a caso.
- Cfr. A. Ferrighi, E. Pelosi (a cura di), La partecipazione della gestione del patrimonio culturale, Sossella Editore, Roma, 2024. Sotto traccia gli studi di Roberto Esposito, in particolare Communitas, Einaudi, Torino 2006.
- L’articolo è disponibile all’indirizzo https://www.nytimes.com/2021/03/20/books/booktok-tiktok-video.html.
- Rimando a C. Faggiolani, M. Vivarelli (a cura di), Le reti della lettura. Tracce, modelli, pratiche del social reading, Editrice bibliografica, Milano 2016.
- Il tema viene seguito in modo molto puntuale dalla testata online ilLibario.it, nella sezione https://www.illibraio.it/news/booktok/.
- La letteratura sui gruppi di lettura è molto ricca. Si veda solo a titolo esemplificativo L. Gavazzi, I gruppi di lettura. Come, dove e perché leggere insieme, Editrice bibliografica, Milano 2019; C. Di Carlo, Gruppo di lettura, AIB, Roma 2021.
- Nato nell’ottobre del 2020, BIBLAB ha l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca interdisciplinari, iniziative culturali e scientifiche, forme di didattica sperimentale e innovativa a sostegno della ricerca applicata in campo biblioteconomico, favorendo le contaminazioni interdisciplinari.
- Questa visione è per me profondamente ispirata dalla storia rivoluzionaria delle biblioteche di Adriano Olivetti, che ho raccontato in Il problema del tempo umano. Le biblioteche di Adriano Olivetti: storia di un’idea rivoluzionaria, Edizioni di Comunità, Roma 2024.
- Faggiolani, Libri insieme, cit.
- Rimando alla lettura del bellissimo libro di C. Benedetti, La letteratura ci salverà dall’estinzione, Einaudi, Torino 2021.
- Il tema della salute si fa ancora più delicato e urgente se guardiamo ai più giovani. Era il 2021 quando l’Unicef denunciava che nel mondo più di un minore su sette, di età compresa tra i 10 e i 19 anni, conviveva con un disturbo mentale diagnosticato. Una fotografia recente pubblicata dall’Unicef nel 2024 sulla condizione della salute mentale di bambini e adolescenti nell’Unione Europea ci racconta uno scenario peggiorato: l’incidenza dei disturbi mentali aumenta con l’età e riguarda circa il 10% delle bambine e dei bambini tra i 5 e i 9 anni e sale progressivamente fino al 19% dopo i 10 anni.
- C. Faggiolani (a cura di), Le biblioteche nel sistema del benessere. Uno sguardo nuovo, Editrice Bibliografica, Milano 2022.
- Sulla articolazione delle tre sfumature del tempo di cui si parla qui si veda J. Wajcman, La tirannia del tempo. L’accelerazione della vita nel capitalismo digitale, trad. it. di D. Restani, Treccani, Roma 2020.
- Questa è una delle cinque tesi per le biblioteche del futuro proposte in C. Faggiolani (a cura di), Libro città aperta. Le biblioteche e lo sviluppo umano. Cinque tesi, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2024.
- Si veda L. Iotti, O. Secondi, Viaggio nell’era della distrazione, il Saggiatore, Milano 2020.
- A. Caramis, A. Federici, Analisi delle infrastrutture librarie in Italia e lo studio di caso di tre regioni: Piemonte, Lazio e Campania, «AIB Studi», 64 (2024) n. 2, p. 203-220, https://doi.org/10.2426/aibstudi-14085. Nel 2022, in Italia erano presenti 989 biblioteche scolastiche nei comprensori statali, 3.919 librerie e 8.131 biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico. I comuni italiani possono quindi essere classificati in base alla varietà delle infrastrutture del libro presenti. Sono state identificate da Istat tre categorie: 1. “Comuni privi di infrastrutture del libro”: senza nessuna infrastruttura; 2. “Comuni con bassa varietà di infrastrutture del libro”: con almeno una biblioteca, una libreria o una biblioteca scolastica; 3. “Comuni con alta varietà di infrastrutture del libro”: con tutte e le tipologie di strutture.

