
Nonostante Collodi, al secolo Carlo Lorenzini (1826-1890), abbia fatto di tutto per ucciderlo, Pinocchio non è mai morto. Passato indenne per l’impiccagione del capitolo XV (che, si è detto, tanto somiglia a una crocifissione), il suo legnoso eroe è restato con noi anche dopo la metamorfosi in bravo ragazzo che chiude Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1881-1883). Del resto, del bravo ragazzo, come è noto, non è mai importato niente a nessuno. Il burattino, invece, ha affascinato e continua ad affascinare tutti, dall’Ottocento a oggi.
E dall’Ottocento – fin dalla sua prima metà, o almeno dagli anni Trenta – provengono anche i pupi, che quasi nascono nello stesso modo del burattino e, soprattutto, con lo stesso genius loci: un sito lontano dalle città, nei freddi paesi della provincia italiana, al Nord e in Toscana per Pinocchio, al Sud e in Sicilia per i pupi.
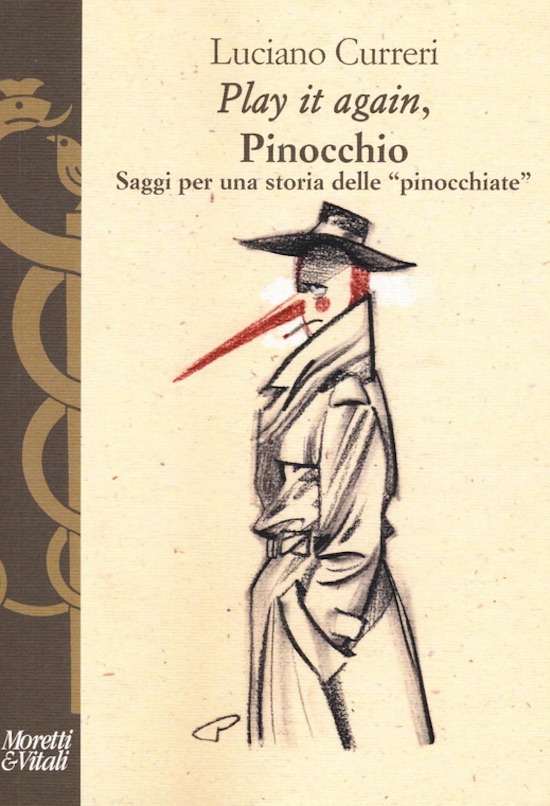 In un libro abbastanza recente di Mimmo Cuticchio (1948)1, maestro dell’Opra e del Cunto, si legge, fra l’altro, che i figli dei pupari nascevano dove nascevano i pupi, in stanzoni che servivano da casa, da bottega, da teatro. Difficile non pensare a Geppetto, alla sua casa-bottega-teatro, e a Pinocchio, figlio e burattino a un tempo.
In un libro abbastanza recente di Mimmo Cuticchio (1948)1, maestro dell’Opra e del Cunto, si legge, fra l’altro, che i figli dei pupari nascevano dove nascevano i pupi, in stanzoni che servivano da casa, da bottega, da teatro. Difficile non pensare a Geppetto, alla sua casa-bottega-teatro, e a Pinocchio, figlio e burattino a un tempo.
Quasi inevitabile, allora, l’incontro dei pupi con Pinocchio, che poi fa parte di quei tanti incontri veri, concreti, che fanno la storia della cultura italiana e dell’Italia tout court, e pure della sua geografia, sempre unitaria per davvero e mai federalista se vista dal basso, dall’angolo visuale dei mestieri, delle passioni. E si badi: la passione cui si allude non è una caramella zuccherata ripiena di nostalgia. La passione dei pupi e di Pinocchio è il contrario dello stare (del riandare per forza a quello stare) e del suo erigersi a identità finita, in tempo e spazio finiti.
Certo, i paladini di Francia, che sono fra i “nostri antenati”, sono spesso lo sfondo per eccellenza, c’è poco da fare, ma Pinocchio non ha davvero paura di confrontarsi con esso né di dilatarlo con la “complicità” di Rinaldo e magari con quella di un samurai.
E per non parlare del repertorio tradizionalmente allargato del teatro dei pupi in cui il burattino finisce per precipitare, anche in seno alla scrittura, e ben al di là di «quaderni, tracciati, scalette e persino canovacci e riduzioni, come quelle delle tragedie di Shakespeare all’opera di Siracusa». In effetti, è così che approdiamo – con una consapevolezza che getta ponti fra la disciplina palermitana di Mimmo Cuticchio e quella catanese, e siciliana tutta – a Fortunato Pasqualino (1923) e pure a Pinocchio alla corte di Carlomagno, reso e raccolto come testualità vera e propria in Teatro con i pupi siciliani2.
Nella storia del teatro dei pupi, il libro ora citato pare essere il primo volume di testi veri e propri – «prodotti e usati in modo specifico» dai fratelli Pino e Fortunato Pasqualino – a venire pubblicato. E nella bella Chiacchierata introduttiva (pp. 7-26), non a caso, si legge: «Si sa che tradizionalmente i pupi siciliani portavano in scena non solo le imprese dei Paladini di Carlomagno, Orlando e Rinaldo, ma l’intera storia del mondo, di prima e di dopo Cristo, da Achille e da Mosè a Garibaldi, da Santa Monica a Santa Genoveffa, da Costantino all’ultimo bandito. Forti di tale libertà originaria, i fratelli Pasqualino hanno sviluppato un proprio repertorio, entro e fuori la falsariga della Chanson de Roland, di là dai limiti dell’improvvisazione tradizionale e del folclore, mirando alla pienezza del gioco teatrale, da prima infanzia del mondo, dove gesto e parola sono totalità, terra e cielo, confronto di ragioni umane, storiche, e di mistero, giusta la lezione della tragedia antica e del teatro d’armi, di amore e di fede spagnolo, del cui stile i pupi sono a loro modo eredi» (p. 9).

E Pinocchio? Pinocchio si confronta con tutto questo e anche di più, perché nasce in seno alla stessa «libertà originaria» – che per gli autori significa anche, e forse soprattutto, una molteplicità infinita di combinazioni – e pure alla medesima «prima infanzia del mondo», ovvero semplicità e innocenza. Certo, a seguire il testo di Collodi da vicino, si pensa magari più ad Apuleio e a Pulci che alla tragedia greca e a certo teatro spagnolo, ma è pur vero che anche il burattino si inscrive in un destino di tragedia, di quel tragico che è categoria occulta e sostanziale del pensiero occidentale3.
Nel caso di Pinocchio alla corte di Carlomagno, Pinocchio sposa non a caso una «morale» e una sfida che vanno in questa direzione: «C’è tanta umanità che, come Pinocchio, vorrebbe godersi la bella commedia della vita, con Arlecchino, Pulcinella e gli altri. Ma ci sono di quelli, della razza di Carlomagno, che vogliono invece tutta una storia di morti, di pianti e di lutti; e, purtroppo, non di rado riescono nelle loro scellerate intenzioni. Pensate che Pinocchio se la caverà con la sua voglia di gioia tra Carlomagno e i Paladini?» (p. 103).
Da un lato, quindi, gli «spropositi» di Carlomagno e dei Suoi, dall’altro Pinocchio che, ad ogni «sproposito», starnutisce. Bref, lo starnuto del naso del burattino rileva ed evidenzia le bugie di tutti. Ottima trovata, quella dello starnuto, che riprende la «sensibilità» del «burattinaio Mangiafuoco» e seppellisce sotto una valanga di «felicità»4 e risate la traccia tragica, che pure riemerge nel testo. Carlomagno, infatti, perde la pazienza quasi subito e ordina ai Paladini di far fuori il burattino (pp. 104-112).
Ma i Paladini, litigiosi, sanguigni e poco propensi alla pacata riflessione, non ne azzeccano una e invece di bruciare Pinocchio, lo gettano nella Senna. Il Nostro, ovviamente, non solo galleggia ma è pure gran nuotatore, come è noto, e si ritrova lontano, in Oriente, dove incontra un samurai e viene a sapere che ci sono bambini che muoiono di fame; quella fame che del resto assilla lo stesso samurai, che ormai è un ronin, «un samurai che non serve più nessuno, e che va in giro per conto proprio» (p. 114).
Pinocchio prende subito la palla al balzo e promette al ronin tutta la pappa che vuole in cambio della sua protezione contro i paladini che lo stanno inseguendo. L’ex samurai accetta, mette in fuga gli avversari, reclama il pranzo e quando il burattino non mantiene propriamente la promessa – dicendo che la pappa c’è ma è lontana – di buon cuore lo lascia andare, suggerendogli: «Quando si fa un dono, caro Pinocchio, bisogna porgerlo alla distanza giusta, perché le mani dell’uomo possano arrivarci e riceverlo» (p. 120).

Per visualizzare, come dire, al di là dei pupi, il corpo testuale di questi Paladini e dell’ex samurai e per trovare un’immagine che sintetizzi al meglio la fertilità di questa combinazione, figlia, certo, di tante fonti storiche e letterarie, possiamo pensare, ancora una volta, alla commedia all’italiana, e in particolare alla chanson de geste divertente concepita e realizzata da Mario Monicelli (1915) in L’armata Brancaleone (1966).
Basta pensare al protagonista, incarnato da Vittorio Gassman, a quel personaggio-mondo che è una specie di «matamoro» tutto apparenza e pure una sorta di samurai sbrindellato, che Fortunato Pasqualino, in seno, certo, alla «libertà originaria» di cui sopra si diceva, può aver avuto in mente, negli anni che precedono la resa testuale del teatro dei pupi siciliani (Brancaleone alle crociate, sempre di Monicelli, è del 1970).
Certo, l’orizzonte è illimitato e pure Akira Kurosawa (1910), che in Italia spopolava fin dagli anni Cinquanta, può essere utile e trovare il suo posto come “fonte” e/o immagine di quel teatro dei pupi «dove gesto e parola sono totalità, terra e cielo, confronto di ragioni umane, storiche, e di mistero».

Ma Pinocchio se la cava?
Rientrando a Parigi, trova morti ovunque, fra lo spettro della guerra civile – con Rinaldo che prega così il Capitano saraceno: «Vi chiediamo di allontanarvi dalle nostre mura e di lasciarci odiare e uccidere in pace» (p. 121) – e Rovenza, «grande guerriera saracena dal martello fatato», che per Orlando è la «femmina dell’Apocalisse e del Corano» che atterra Rinaldo (che finge d’esser morto): «Oh Rinaldo! – dice Orlando – da vivo ti avrei voluto dare io la morte, ma ora che morto ti vedo, ti vendicherò. A noi Rovenza!» (p. 122).
Pinocchio non si capacita: fame da una parte, guerra dall’altra. Non gli resta che “affrontare” Carlomagno in sogno o, meglio, in un incubo a lieto fine. Il sovrano si spaventa, promette pane e pace e bandisce le menzogne dal suo regno (dalla terra) invitando il burattino a salire sul trono e facendogli puntare il naso su tutti i paladini al fine di sapere se hanno il coraggio della verità.
Ovviamente, Pinocchio comincia a starnutire.
NOTE
1. M. Cuticchio, La nuova vita di un mestiere antico. In viaggio con l’Opera dei Pupi e il Cunto, Liguori, Napoli 2010.
2. Cfr. F. Pasqualino, Teatro con i pupi siciliani, Cavallotto, Catania-Caltanissetta-Palermo 1980, pp. 99-130, ma la citazione che precede è da p. 9. Segnalo che d’ora in avanti le pagine da cui si cita saranno indicate direttamente nel testo tra parentesi tonde alla fine di ogni citazione.
3. Si legga il denso P. Fornaro, Tradizione di tragedia. L’obiezione del disordine da Omero a Beckett, Arcipelago, Milano 2009.
4. Cito dalla copia anastatica del 2001 di Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Felice Paggi Libraio Editore, Firenze 1883, pp. 45-46.

