La misoginia greca è un dato culturale incontrovertibile. Da Esiodo sappiamo che per i Greci la prima donna, Pandora, ambiguo malanno, fu una punizione divina, ben più disgraziata di una Eva pagana, dal momento che il male del mondo per i Greci non ha origine dalla trasgressione del divieto (peraltro condivisa dai due progenitori della tradizione giudaica), ma dalla vendetta che Zeus infligge agli uomini, in ragione del fuoco che Prometeo ha rubato per loro. Insomma: il trasgressore è Prometeo, gli uomini sono condannati di riflesso e con poca colpa, le donne rappresentano la pena inflitta.
Che i dubbi su Penelope siano dunque ben radicati nella cultura patriarcale greca è cosa certa; d’altra parte, è noto che ogni forma archetipica, in virtù della sua essenzialità, si presta particolarmente a incarnare paradigmi differenti a seconda dei momenti storici e dei valori di riferimento.

In età classica ed ellenistica le illazioni su Penelope si sprecano: un gioco paraetimologico la associa al dio Pan, creatura silvestre generata da Hermes o, in una variante ben più ingiuriosa, dall’unione con tutti i Proci. Apollodoro di Atene immagina che la sposa di Ulisse sia stata infine rimandata dal padre Icario per aver ceduto ad Antinoo, uno dei pretendenti. Il tema della fedeltà/infedeltà della sposa di Ulisse era dunque oggetto di dibattito letterario nel mondo greco, ma è la Roma augustea che mostra bene come la ricezione del modello si sposi al suo impiego ideologico: Igino, bibliotecario di Augusto, inserì Penelope (come Alcesti, Laodamia ed Ecuba) nel catalogo delle donne castissime, accanto a Lucrezia, la fedele moglie di Collatino, la cui morte autoinflitta diviene emblema delle virtù delle matrone antiche: riservate, operose, in particolare nella filatura della lana, e fedeli fino al sacrificio. Ovidio ne fa invece l’autrice della prima lettera delle Heroides: la regina si esprime con il pathos di una moglie tormentata, oltre che dall’ansia per la vita del marito, dal sospetto che il suo tardo ritorno si debba a un amore straniero, una donna affascinante a cui descrivere una sposa buona solo a filare la lana. Due autori coevi dunque potevano condensare sullo stesso personaggio le contraddittorie istanze psicologiche e morali che attraversavano il loro tempo.
Non serve troppa fantasia per immaginare come la cultura cristiana tardoantica e medievale (in Occidente sempre più lontana dall’accesso diretto ai testi in lingua greca e dunque anche da Omero) abbia visto in Penelope il simbolo della virtù muliebre della pudicizia. Gerolamo, condannando il monaco Gioviniano (eretico proprio per la svalutazione dell’ascetismo), subordina la vita matrimoniale alla castità e ricorda proprio Penelope in ragione della sua pudicizia: «Penelopi pudicitia Homeri carmen est», sta a dire che il cuore dell’Odissea è per lui non già l’adulterio, né il ritorno dello sposo, ma la castità della sposa.
Da Gerolamo al Petrarca dei Trionfi si compie una reinterpretazione cristiano-umanistica del culto della castità: Penelope entra nel corteo delle donne che liberano i prigionieri di Amore per portarli davanti all’altare della Pudicizia a Roma. Boccaccio accoglie uno spunto ovidiano (da Ars amatoria, II 355-356) e nell’Amorosa visione accosta Penelope a Laodamia, la principessa vedova che non esitò a gettarsi sulla pira in cui bruciava la statua bronzea del marito defunto.
La solidità della coppia archetipica e della fedeltà di Penelope entrerà in crisi con l’ingresso nell’età moderna e Ariosto, l’autore che meglio di tutti nel Furioso ha saputo rappresentare la guerra dei sessi (l’assedio molesto dei cavalieri inseguitori, le fughe di Angelica, la perdita del senno…) la ricorda quando mette in guardia il lettore dalle menzogne dei poeti, con due esempi: la presunta vittoria achea a Troia e la fedeltà della moglie di Ulisse («tutta al contrario l’istoria converti: / che i Greci rotti, e che Troia vittrice, / e che Penelopea fu meretrice», Orlando furioso, XXXV, 27)
Insomma, se analizziamo le rivisitazioni del mito di Ulisse e Penelope possiamo seguire lungo un fil rouge i cambiamenti che attraversano la società e le relazioni tra i sessi. Parafrasando Daniel Mendelsohn, che, ricorderete, ipotizzava una costante immutabile nella natura umana, diremo che se una costante c’è, questa non è impermeabile alle congiunture storiche, ma risiede nel fatto che ogni generazione trova nel mito la possibilità di assurgere a universale il proprio particolare. E ciò si dovrà al fatto che nel mito poche e significative invarianti resistono a tutte le possibili variazioni, offrendo lo spazio per un discorso che attraversa le generazioni, un lascito di volta in volta accolto, trasformato o respinto, ma mai eluso.
La linea femminile e femminista del mito di Penelope
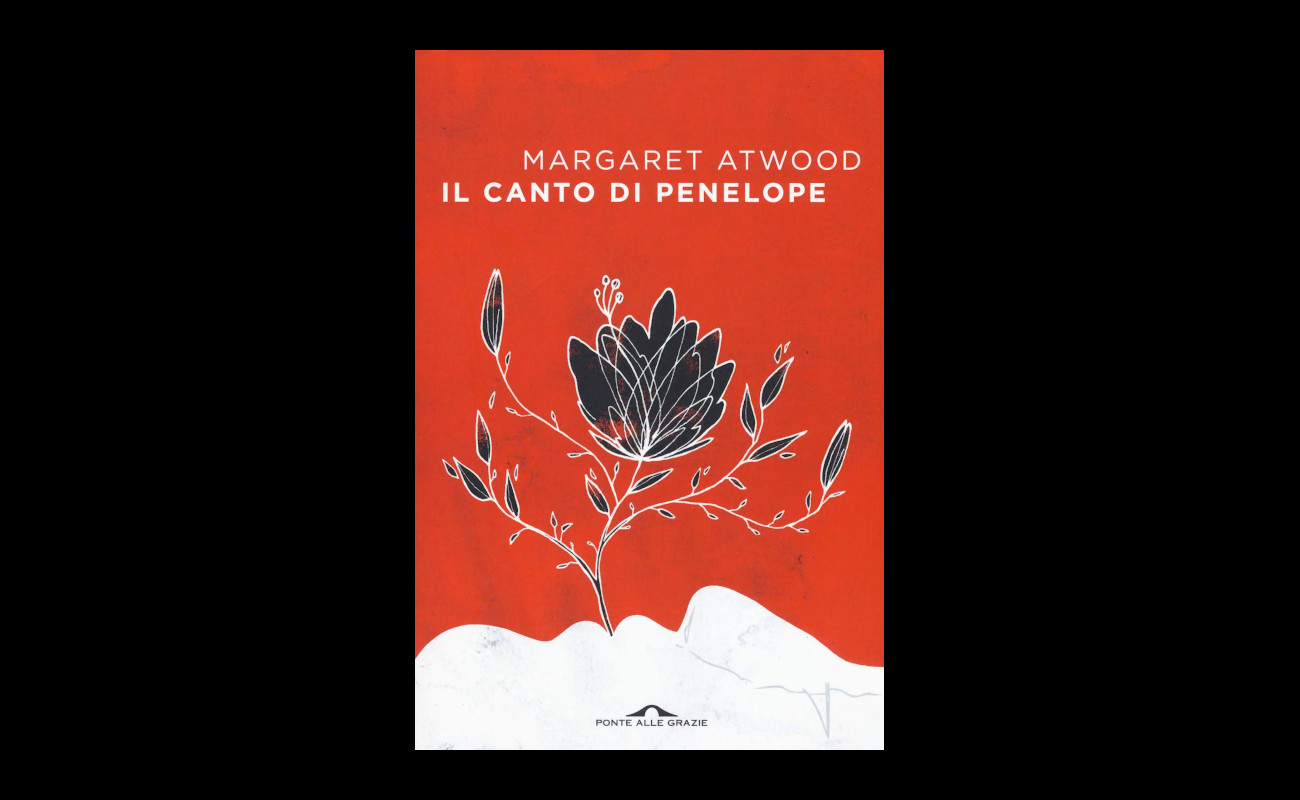 Il silenzio delle antenate, si è detto, dovrebbe trovare un posto nelle nostre lezioni perché è un tema trasversale che interessa la storia, l’arte, le letterature e certamente anche la storia del pensiero, ab origine segnata da un pregiudizio platonico troppo tardivamente smentito nell’evoluzione della cultura occidentale[1].
Il silenzio delle antenate, si è detto, dovrebbe trovare un posto nelle nostre lezioni perché è un tema trasversale che interessa la storia, l’arte, le letterature e certamente anche la storia del pensiero, ab origine segnata da un pregiudizio platonico troppo tardivamente smentito nell’evoluzione della cultura occidentale[1].
A partire dagli anni Venti del secolo scorso si è diffusa e ritorna ciclicamente la tesi che sia stata una donna a scrivere i testi omerici e l’Odissea in particolare (da S. Butler, The Authoress of the Odissey, London 1897, a R. Ruyer, Homée au feminin, Paris 1977, fino al più recente Andrew Dalby, Rediscovering Homer: Inside the Origins of the Epic, New York 2007). L’ipotesi suggestiva nasce dal riconoscimento di una sensibilità e un punto di vista femminili. L’argomento, va da sé, non è sufficientemente forte da imprimere una svolta alla cosiddetta “questione omerica”, ma a queste tesi si dovrà riconoscere almeno il merito dell’intenzione: se la storia della letteratura è per millenni, con poche eccezioni, storia del silenzio delle donne e se non c’è rimedio a un punto di vista femminile sempre mediato da voce maschile, è suggestivo pensare di poter reagire all’amputazione di un punto di vista autenticamente femminile nella storia e sulla storia, ricreando per le donne del mito una narrazione e una voce, seppure a immagine dei desideri e delle aspirazioni delle donne contemporanee.
Ciò varrà a maggior ragione per alcuni romanzi contemporanei che sembrano veicolare un messaggio: se riusciamo a provare, anche sul piano della finzione narrativa, la nascosta libertà ed emancipazione delle donne del passato avremo la prova che la sottomissione femminile è un fatto culturale e che non nasce dalla natura delle donne. Non vi ricorda una recentissima polemica social che ha visto protagonista lo storico Alessandro Barbero?
Citerò due narrazioni accomunate dall’uso, certo non casuale, della prima persona. Il primo, ormai quasi introvabile, è la Penelope di Silvana La Spina (ed. La tartaruga, 1988). La scrittrice padovana si concentra sull’infanzia abusata di Penelope, che ancora adolescente è guidata da una schiava al culto di una divinità femminile matriarcale, e accetta le nozze per fuggire a un padre incestuoso. Il matrimonio è per lei lo spazio della solitudine anche dopo il ritorno di Ulisse, anche perché Telemaco è un giovane inquieto e morbosamente legato alla madre. Il romanzo si conclude con Penelope che infine lascia Itaca, offrendo a sé stessa e a Euriclea, confidente e amica, la possibilità tradizionalmente tutta maschile del viaggio. La narrazione testimonia il clima culturale in cui nasce: la finzione di La Spina attinge alle reintepretazioni del mito e del folclore antico secondo coordinate femminili matriarcali, sempre più indagati a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso.
Sulla stessa linea, e sulla scia degli studi di Robert Graves, si colloca anche il romanzo di Margaret Atwood, Il canto di Penelope (oggi tradotto da Margherita Crepax per Ponte alle Grazie, 2021). La scrittrice canadese non ha bisogno di presentazioni ed è probabile che anche studentesse e studenti la conoscano per il Racconto dell’ancella, romanzo distopico molto noto anche per la fiction che ne è stata tratta.
Il punto di partenza anche per la Penelope di Atwood non è Omero; si legge infatti nella prefazione: «Ma l’Odissea di Omero non è l’unica versione della storia: il mito aveva tradizioni orali e locali, poteva essere raccontato a seconda del luogo di provenienza. Io non ho tratto il materiale di questo libro solo dall’Odissea, soprattutto per quanto riguarda i particolari sulle origini di Penelope, sugli anni giovanili, sul matrimonio e sulle voci scandalose che circolavano sul suo conto». Ne esce un racconto in soggettiva ma plurale, che affianca a Penelope il coro, nel quale si dà voce alle dodici ancelle infedeli impiccate da Telemaco su ordine del padre. Penelope è un’ombra che parla dal regno di Ade, dove finalmente sa più cose e può smentire la propria leggenda strumentale, l’essere stata trasformata in “un bastone edificante”. Raccontare la propria versione della storia è per lei tessere finalmente la sua vera tela.
Il Canto di Penelope è una lettura che può essere proposta fin dal biennio delle superiori, purché alcuni elementi trovino la giusta evidenza e contestualizzazione nella presentazione dell’insegnante: per esempio, una certa caratterizzazione delle figure femminili (Anticlea, madre di Ulisse, e la nutrice Euriclea), nelle quali si manifesta un patriarcato tanto ben interiorizzato da impedire la solidarietà nei riguardi delle donne che manifestano un punto di vista originale o divergente. Anche la ripresa delle teorie di Robert Graves sulla presunta affiliazione di Penelope a un antico culto matriarcale, merita qualche parola di contesto: le ancelle sarebbero state massacrate sia per la relazione con i pretendenti, sia perché dedite a riti alla dea Artemide (confessano nell’ultimo coro l’unione orgiastica con i Proci e il lavacro nel sangue degli uomini uccisi).
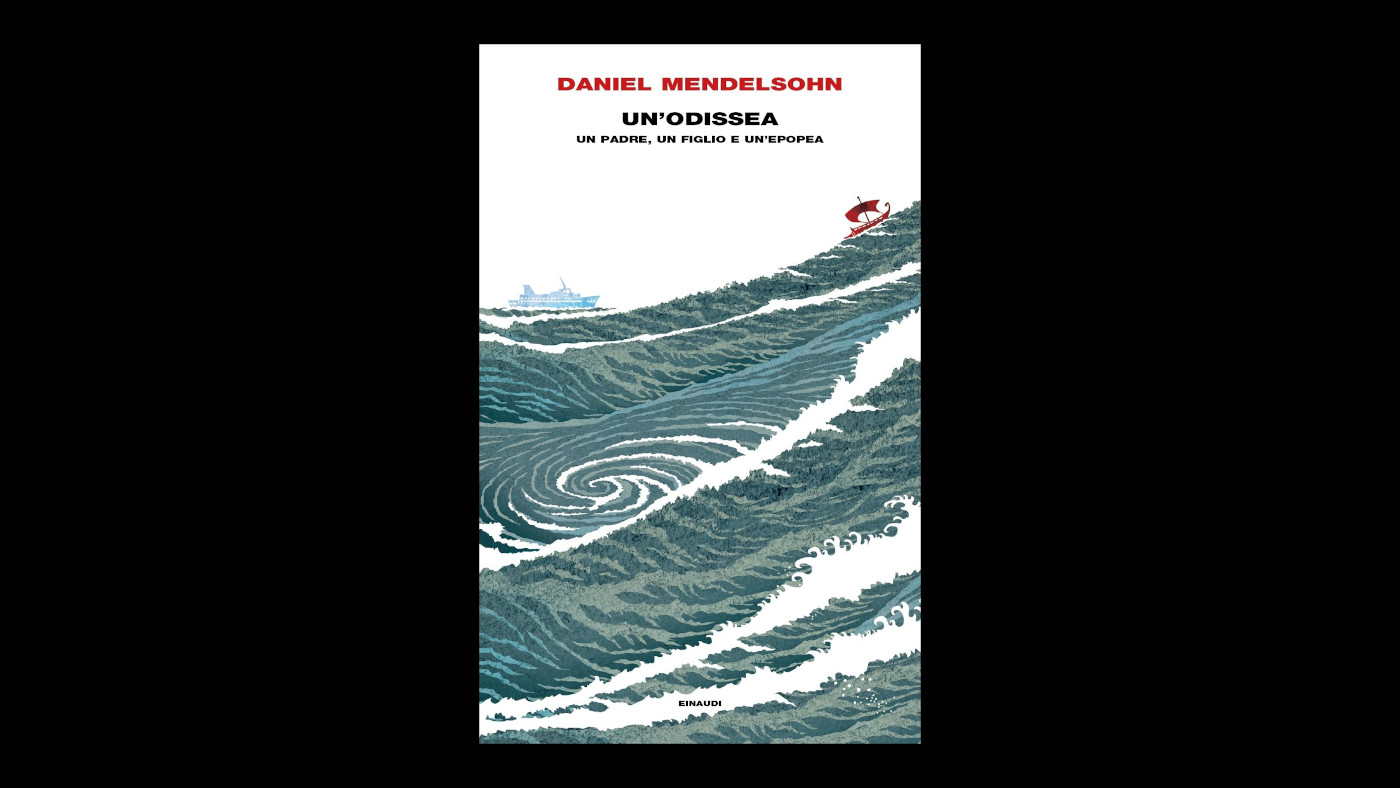 Frammenti di un discorso matrimoniale
Frammenti di un discorso matrimoniale
C’è poi una riproposizione del modello che allarga il discorso alla coppia. Ascrivo a questa linea l’amabile racconto autobiografico di Daniel Mendelsohn, lo scrittore, critico e docente statunitense su cui ho aperto il mio precedente contributo. La sua Odissea. Un padre, un figlio, un’epopea (Einaudi 2018), offre uno spaccato interessante circa l’approccio ai classici, e all’insegnamento dei classici, nella prospettiva critica americana: centrale mi pare il rispecchiamento. Alle lezioni che lo scrittore e io narrante dedica al poema omerico partecipa anche suo padre: ed ecco che la figura di Telemaco si offre a Mendelsohn come chiave per una conoscenza più profonda del proprio genitore (una sorta di altro Ulisse), specie quando insieme compiono un viaggio in Grecia.
Nel corso del romanzo si alterna lo sguardo sull’antico e a quello che esplora la vicenda personale dei Mendelsohn, fino al nodo più interessante: il riconoscimento del segreto della relazione coniugale tra il padre e la madre dell’autore, quella stessa homophrosyne che Omero augura a Nausicaa e che Mendelsohn legge come un “pensare allo stesso modo”.
Un’intuizione del tutto opposta anima il bel romanzo di Luigi Malerba, Itaca per sempre, riscrittura vera e propria, sebbene nata dall’occasione anche qui autobiografica di una conversazione alla presenza dell’omerista Pietro Pucci, al quale la moglie di Malerba, Anna Lapenna, ebbe a proporre una luminosa intuizione: Penelope aveva riconosciuto sin dal principio Ulisse nel mendico ma si era ben guardata dal rivelare la scoperta.
Malerba scrive un appassionante diario a due voci, due soggettività che a fatica si incontrano perché centrale per entrambi è la questione del riconoscimento: dopo vent’anni il corpo e l’anima hanno molto vissuto e la memoria non può bastare. Così Penelope intuisce la presenza del marito ma lo punisce per la sfiducia che le ha riservato mantenendosi in incognito; Ulisse, a sua volta, messo in crisi dal mancato riconoscimento della moglie, che dura ben oltre il trucco del talamo, dubita di sé stesso e insieme si risente; il mare lo tenta, è prossimo all’abbandono, ma Penelope manda Telemaco a convincerlo a restare a Itaca “per sempre.” La riunificazione della coppia non basterebbe a sciogliere la trama: nessuno dei due ha la certezza oggettiva di chi sia l’altro e Ulisse è un uomo che ama l’avventura. Sarà la creatività di Penelope a offrire una chance a entrambi, suggerendo al marito di non disperdere i ricordi e di far rivivere le sue avventure nella scrittura.
È dunque Ulisse l’autore dei poemi omerici: Luigi Malerba conferma la fortuna dell’enigma di Omero, che per Atwood era Penelope, per Robert Graves una principessa siciliana di nome Nausicaa (nel romanzo Homer’s Daughter, 1955)
Non posso fare a meno di citare, su questa via malerbiana di diario a più voci, l’ultimo scritto di Maria Grazia Ciani, traduttrice e fine conoscitrice dei testi omerici: La morte di Penelope (Feltrinelli 2021). Questa volta le voci sono tre: Ciani rispolvera la leggenda che vuole Penelope cedevole con Antinoo e compone l’emozionante diario di un innamoramento e di un tradimento. L’invenzione parte da una domanda la cui risposta appare oggi scontata: può una donna abbandonata giovanissima per la guerra, preservare intatto il talamo per vent’anni, pur dubitando ogni giorno della sopravvivenza del marito, della sua fedeltà, del suo ritorno?
Homophrosyne: la speranza in un abbraccio
Ho proposto un percorso che mi ha tenuto impegnata per molto tempo e credo di aver inseguito le tracce di una questione che riguarda l’antico ma anche il presente, poiché si presta a molti livelli del discorso: da un lato il ruolo delle donne del passato (nello spazio domestico, in quello pubblico, nella cultura), dall’altro la risignificazione che si attua quando si interpreta o si riscrive qualcosa che è stato detto, ma da una prospettiva altra, quella di chi abita la propria attualità.
Se leggendo proviamo a chiederci cosa cambia e cosa resta uguale, o non è cambiato abbastanza, scopriamo che questa è una di quelle domande che trasformano chi le pone. Ma la premessa da cui sono partita conteneva un secondo quesito: può l’esplorazione del mito esercitare una sorta di cura culturale?
Non sono abbastanza attrezzata da approfondire l’intuizione che la coppia Ikaro e Ikaria in Mitoraj possa leggersi come una rappresentazione della polarità intrapsichica del maschile e del femminile: quelli che per Jung sono gli archetipi di animus (maschile interiore per la donna) e anima (femminile interiore per l’uomo). Mi interessa però sottolineare che la soggettività artistica di Mitoraj può essere significativa anche in un discorso collettivo. Possiamo dire del mito che esso è per l’inconscio collettivo ciò che il sogno è per l’inconscio individuale? Se l’artista ha sognato per sé e per tutti, scolpendo, possiamo ricavarne alcune considerazioni.
Il danno di un mondo patriarcale e di una cultura che non si riconosce anche matrilineare non sta solo nella sofferenza inflitta alle donne o ad altri soggetti di volta in volta sacrificati al dominio della forza. Simone Weil avverte che la forza pietrifica anche chi la esercita (peraltro provvisoriamente, illudendosi soltanto di possederla, come provano le parole profetiche di ogni eroe morente). Non può perciò essere generativa una società alla quale manchi non solo la buona concordia tra gli uomini e le donne, ma anche la buona relazione tra istanze, movimenti e linguaggi del femminile e del maschile archetipici.
Ikaro e Ikaria soffrono questo mancato dialogo; perciò, forse, Eros è avvolto da bende come un soldato ferito. Riprendiamo il gioco paraetimologico dal quale siamo partiti assegnando alle sculture di Mitoraj il compito di portare alla luce qualcosa che forse l’archetipo antico sottende.

Il volo di Ikaro è folle e votato alla caduta, ma “folle volo” è anche l’ultimo viaggio di Ulisse che, secondo Dante, non si preoccupa del «debito amor che doveva Penelope far lieta». Ma, se è mortale la scelta di Icaro (e di Ulisse), nemmeno Ikaria, trattenuta, può spiccare il suo salto verso il cielo e come lei è limitata nel movimento, e non ha diritto di parola, la figlia di Icario, Penelope. Per colpa di due solitudini Itaca muore, continuamente razziata. Diremmo dunque che, finché non si rinnova la relazione tra maschile e femminile (il talamo), la guerra di Ilio non può finire e la forza continua a esercitare il suo dominio distruttivo sull’intera comunità. Ciò che rende prospera non solo la vita nello spazio domestico, ma anche la città, è quella concordia che Ulisse augura a Nausicaa: non tanto un “pensare allo stesso modo”, ma una conversazione che rende possibile l’integrazione del punto di vista dell’altro/a, dunque un vivere nella relazione. È una condizione che il regno di Alcinoo attua molto bene, assegnando alla regina Arete l’amministrazione della giustizia, probabilmente il ruolo regale più nobile, perché l’esercizio della giustizia implica la capacità di tenere insieme tutte le cose.

Potremmo proseguire a lungo tra questi pensieri, che forse a qualcuno parranno un (folle) volo pindarico: proprio nell’homophrosyne mi pare di riconoscere la “cura culturale” offerta dal mito e dunque anche la risposta alle perplessità dello storico Barbero sulla determinazione delle donne e, quel che più conta, l’antidoto ai tanti muri ideologici che rendono ancora la nostra Itaca attuale un luogo “pietroso”.
L’homophrosyne, unità nella relazione, è perciò anche il mio augurio per questo Natale e per il tempo che verrà.
Note
[1] A titolo di esempio e con intento sintetico, cito il lavoro della filosofa Adriana Cavarero e in particolare la sua lettura del mito di Penelope.
Bibliografia
L’uomo greco, a c. di J.P. Vernant, Laterza, 1991) in particolare J. Redfield, Vita domestica.
A. Cavarero, Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia antica, Editori Riuniti 1999
E. Cantarella, Itaca. Eroi, donne e potere tra vendetta e diritto, Feltrinelli 2002 e id., L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna dell’antichità greca e romana, Feltrinelli 2010.
M. R. Cornacchia, La traccia del modello. Ricezione e della figura di Penelope nella letteratura contemporanea, tesi di dottorato in lingua e letteratura greca, Università di Bologna 2007
G. Ieranò, Elena e Penelope. Infedeltà e matrimonio, Einaudi Stile Libero 2021


