
L’accostamento dei due libri è l’occasione per una ricognizione nei miti letterari – non solo siculi e classici – che costituiscono la filigrana delle narrazioni di Nadia Terranova, e la rendono allo stesso tempo antica e contemporanea.
Messina, la città e una casa
Partiamo da Addio fantasmi, e dalla trama: i fantasmi del titolo sono quelli di Ida, trentaseienne messinese, romana per scelta e per sopravvivenza, costretta a tornare nella casa natale che deve essere ristrutturata. La casa letteralmente si sfarina per l’usura del tempo, la trascuratezza della madre che ancora la abita e non sa viverla, misteriose infiltrazioni d’acqua di cui si fatica a trovare la causa. È una casa animale, corporea, che si sottrae alla volontà delle proprietarie; al posto del cuore ha una sveglia che ha smesso di battere alle 6 e 16 di ventitré anni prima, il giorno in cui il padre di Ida è scomparso senza lasciare una traccia né un cadavere da seppellire, dimenticare o ricordare.
La scomparsa di Sebastiano Laquidara è l’incantesimo che ferma il tempo e costringe Ida e sua madre in una guerra fredda che impedisce alla vita di scorrere; il tempo si ferma, la memoria diventa una dannazione che non trova antidoto neppure nella fuga a Roma.
C’è nell’intimo di Ida un legame indissolubile con la casa messinese, il luogo del dolore muto. Nella casa che si erode lentamente, il passato sembra una bomba inesplosa, e la sveglia che non batte più il tempo (un po’ come l’orologio fermo che ancora campeggia sul muro della stazione di Bologna) resta per sempre il correlativo oggettivo di ciò che è stato.
La memoria si impone come un monito, ma anche come una punizione crudele per il dolore che non può estinguersi: la scomparsa del padre non era ieri né oggi, era sempre (Addio fantasmi, p.103)
Il tempo si ferma, e lega Ida ai suoi fantasmi con una potenza fiabesca che Nadia Terranova, indagatrice di leggende e già autrice di storie per ragazzi, conosce bene; in Omero è stato qui dice infatti di sé:
Ho sempre saputo di essere siciliana e dunque greca, araba, normanna e figlia di mille popoli che nei millenni hanno attraversato la mia terra. Ho sempre saputo di essere cresciuta in un luogo ricostruito dopo un grave terremoto e maremoto, dunque pieno di fantasmi che non se ne volevano andare: casa mia è anche casa loro.
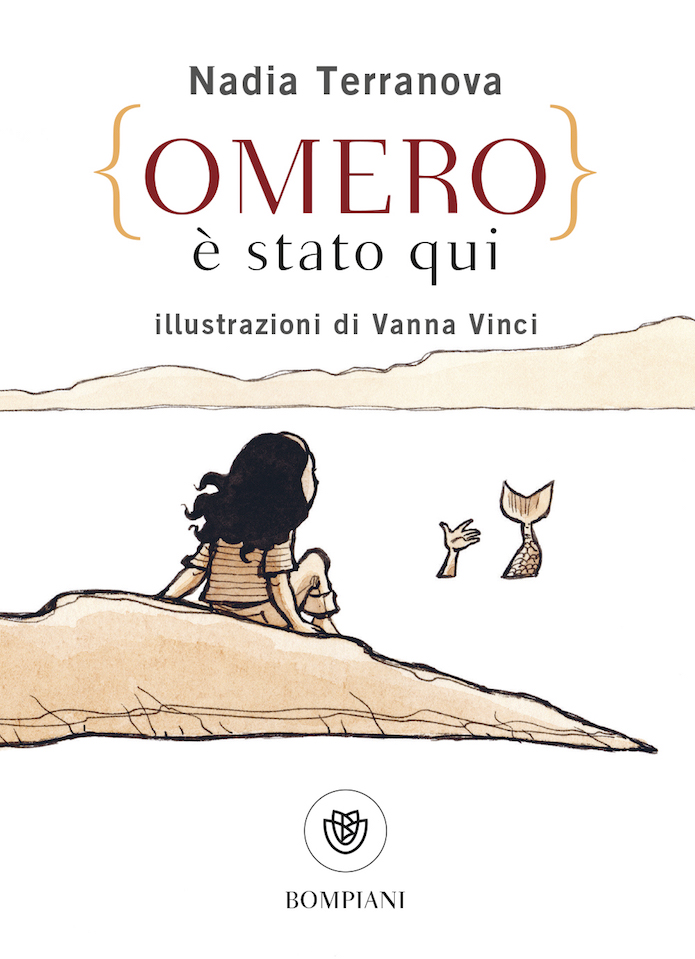
Nella storia personale di Ida si specchia il carattere della sua fantasmatica città, Messina:
Dev’essere stato dopo il terremoto del 1908 che abbiamo smesso di buttare le cose, incapaci per memoria storica di eliminare il vecchio per fare il posto al nuovo; dopo il trauma tutto doveva convivere, accatastarsi, non si poteva demolire niente, solo costruire a dismisura per lo spavento, baracche e palazzine, strade e lampioni: da un giorno all’altro la città c’era, poi non c’era più, e se il disastro era accaduto poteva accadere di nuovo, infinite volte. Allora meglio addestrarsi a tenere insieme. (Addio fantasmi, p. 58)
Sulle tracce dello scomparso
Ho letto l’intenso romanzo di Terranova a poca distanza da L’estate del ’78 di Roberto Alajmo, il romanzo che ho raccontato proprio su questa rivista. Mi colpì allora e mi colpisce anche oggi l’occorrenza di due narrazioni in cui il protagonista torna sulle tracce di una figura parentale scomparsa. Certo il romanzo di Nadia Terranova è scrittura di finzione, mentre Alajmo torna effettivamente sulle tracce della propria madre e ne disvela la fine, ma questo interessa l’autore; ciò che il lettore incontra sono due scrittori siciliani e due protagonisti che, giovanissimi, hanno visto appassire e poi scomparire una madre e un padre, come evaporati a poco a poco, fantasmi già in vita, per un incanto psicologico (la depressione del padre di Ida) e anche chimico (il farmaco droga della madre di Alajmo).
Per la protagonista del romanzo di Terranova, Ida, ciò implica un rapporto padre-figlia rovesciato fin dal principio:
Le macchine ci passavano accanto in senso contrario, mio padre non si girava, non mi teneva la mano, non mi raccomandava di stare attenta. Avrei voluto raccomandarmi io a lui, di far caso alle auto e tenersi vicino al marciapiede, ma non riuscivo più a dirgli nulla e lo avevo tenuto per me: speriamo che non muoia. Dovevo averlo pensato così forte che, poco dopo, gli dei mi avevano punito accontentandomi: mio padre non era morto e non sarebbe morto mai. (ivi, p. 60)
Una sorta di inettitudine paterna era già tema del precedente romanzo di Nadia Terranova, Gli anni al contrario (Einaudi Stile Libero 2015): anche qui troviamo una figlia, Mara, e la sua infanzia senza tempo, due genitori ragazzini, troppo fragili per la tempesta della Storia, e, soprattutto, un padre, Giovanni, che perde le coordinate che servono a una guida e si sottrae, un po’ come Colapesce, personaggio leggendario siciliano e fantasma totemico di molte scritture di Nadia Terranova.

Genitori che si sottraggono al ruolo sono personaggi ricorrenti della narrativa contemporanea, ma per la scrittrice messinese il tema incrocia la letteratura della sua terra, sovente legata al topos della sparizione. Lo stretto inghiotte appunto Colapesce, leggendario ragazzo pesce che si inabissa per sfida e poi non torna perché una delle colonne che reggono la Sicilia sta per crollare e tocca lui reggere l’intera isola; scompare Mattia Pascal, alla ricerca di una nuova vita; e anche Sciascia ricostruisce un’enigmatica sparizione, quella di Ettore Majorana. La novità è che Terranova sposta l’attenzione dalla scelta di scomparire all’eredità di chi resta; verrebbe da dire che la sua sia una variazione su un tema tutto siciliano se un’altra deliziosa creatura della scrittrice, Bruno, il bambino che imparò a volare, libro illustrato da Ofra Amit (Orecchio acerbo 2012 – Premio Napoli 2012), non ci avvertisse della sua passione per Bruno Schulz, l’autore ebreo galiziano de Le botteghe color cannella (Einaudi 2001).
Molti racconti dello scrittore polacco sono dedicati al padre Jacob, bottegaio di tessuti e pensatore visionario, che incantava il piccolo Bruno con teorie ed esperimenti surreali, alternati a momenti di deperimento fisico o follia e a continue sparizioni/trasformazioni che lo scrittore descrive come progressive anticipazioni della scomparsa definitiva. In alcuni di questi racconti troviamo un un giovanissimo Bruno attento e apprensivo nei riguardi di un padre che, quando la salute comincia a declinare, trascorre a letto intere giornate tutto sperso nei labirinti di calcoli complicati, indisponibile all’accudimento anche in virtù di una malattia che lo fa deperire lentamente e appassire a vista d’occhio (così almeno nel racconto La visitazione, da Le botteghe color cannella…, p. 12 e p. 14). Poco più che bambina, Ida, come Bruno, si è presa cura di un padre inabissato nelle proprie ossessioni, anche se per lei non è valso l’incanto carnevalesco sperimentato dal figlio di Jacob Schulz; domina infatti ogni suo ricordo la malinconia provocata da un amore paterno che l’ha delusa due volte: prima in ragione dell’incapacità di prendersi cura, e poi per la sparizione/sottrazione del corpo, che cancella la possibilità del lutto, della sepoltura, dell’eredità di un mandato di vita.
Non sembrerebbe esserci posto per una elaborazione che liberi la vita di questa figlia:
Il corpo di mio padre non si trovava da nessuna parte e io non riuscivo a muovermi, tanto lontano mi sembrava il perdono che avremmo potuto concederci, tanto impossibile la speranza a cui avremmo dovuto affidarci. (Addio fantasmi, p. 115)
Ogni testo letterario è in fondo un ipertesto in cui riverberano e dialogano le suggestioni dei libri che l’autore (e i suoi lettori) hanno conosciuto e amato. Proseguendo in questo gioco di riferimenti incrociati, potremmo aggiungere che anche Bruno Schulz è letterariamente uno scomparso per David Grossmann. In quel romanzo “fantasmatico” che è Vedi alla voce Amore, lo scrittore israeliano scarta la biografia vulgata secondo cui Bruno Schulz sarebbe stato ucciso per capriccio dai nazisti e lo immagina invece in volontaria fuga a Danzica, sulle tracce del quadro Il grido di Munch, e poi nuotatore fra i pesci nelle acque del mare del Nord, in un epilogo panico che ricorda le ipotesi di Ida sul proprio padre che
amava il mare: imparai che mio padre doveva, per forza, essere ritornato all’acqua (ivi, p. 99).
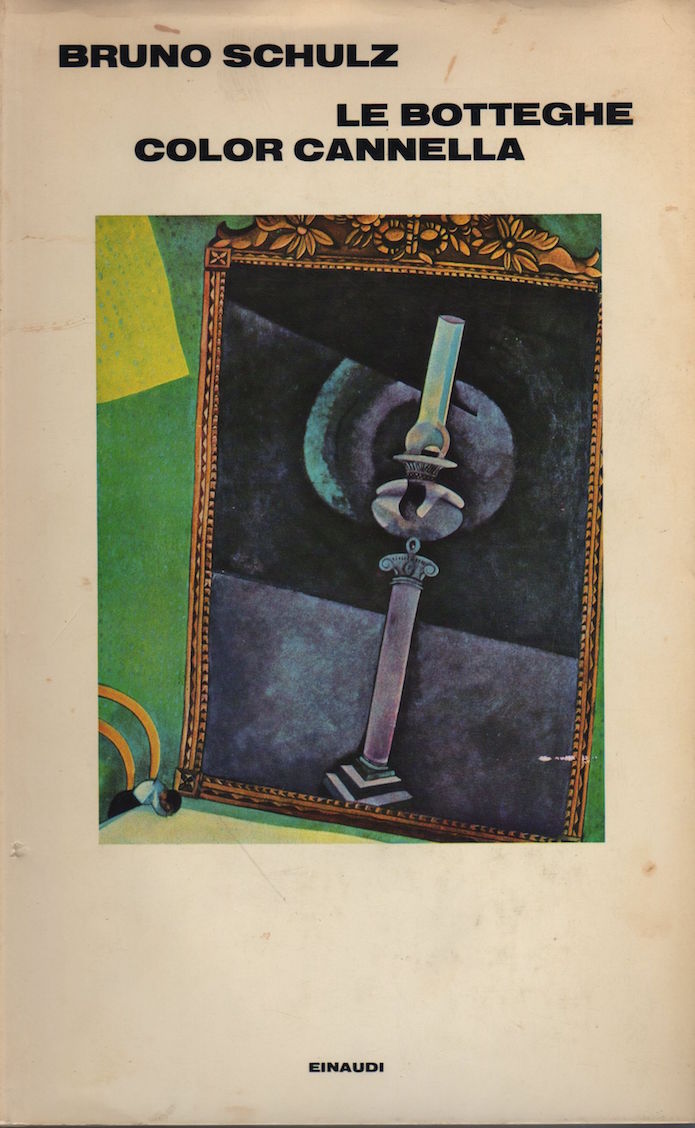
Dire il nome: il potere magico della scrittura
C’è un capitolo dal titolo emblematico che forse vale a sintetizzare l’atmosfera prevalente del romanzo di Nadia Terranova: Cose terribili come fossero normali e forse viceversa. La storia di Ida è infatti la storia di un dolore che non deflagra e perciò resta muto, non riconosciuto, e costringe lei e la madre a una solitudine senza pietà. Non c’è possibilità di comunicare finché il nucleo sostanziale attorno a cui si definisce l’identità delle due donne appartiene alla sfera del non detto. La madre di Ida è viva, ma a tratti appare un fantasma non meno ingombrante di quello paterno.
Eravamo due alberi piantati in tempi diversi e a lei era toccato crescere prima, questo non la rendeva un genitore, come essere nata dopo non faceva di me una figlia, anzi: più crescevamo e più eravamo piante a cui toccava dividere lo stesso terreno. (ivi, p. 68)
E ancora:
Capii che cos’è davvero una madre: qualcosa da cui non esiste riparo. Dicono che una madre dà tutto e non chiede niente: nessuno dice invece che chiede tutto e dà ciò che non chiediamo di avere. (ivi, p. 82)
Nel racconto la madre di Ida è sempre e soltanto lei o mia madre, unico personaggio innominato del romanzo: questa donna, di cui ignoriamo il nome e che non pronuncia mai il nome del padre, è chiusa in un isolamento che nega il lutto e lo rende incomunicabile, incomprensibile e dunque insuperabile. Non di meno, sembra impossibile sottrarsi al paradigma esistenziale con cui essa confina e congela tutto ciò che la fa soffrire. Dice Sara, un’amica d’infanzia di Ida:
Mi hai fatto paura. Sembravi tua madre e ho capito che saresti diventata come lei, una donna che vive intorno a una crepa sanguinante, anche quando quel sangue è diventato secco, la crosta si è sgretolata ed è caduta via. (ivi, p. 164)
Sappiamo bene che il nome è importante perché consente una relazione con gli altri, per quanto faticosa, e definisce un’identità a cui (Pirandello insegna) è possibile persino ribellarsi alla ricerca di una forma d’esistenza il più possibile autentica. Nel romanzo di Terranova il nome ha un valore magico-evocativo: la protagonista ragazzina individua una serie di atti di forza con cui trattenere il nome del padre, come bastasse una ritualità magica a far ricomparire la sua persona come si pretende nella prima fase di elaborazione di una perdita; ventitré anni dopo, ormai donna, compie un rito di segno opposto.
Sul ferro della panchina, fra i nomi degli innamorati e la volgarità dei disegni osceni, implorai la pace di un cadavere e scrissi le parole che i veri orfani possono permettersi di irridere mentre i sopravvissuti a una sparizione agognano come la quiete: “Qui giace Sebastiano Laquidara, lo piange la figlia Ida”. Quando finii di scrivere il necrologio di mio padre, la furia del suo nome si placò. (ivi, p. 63)
La scrittura, come un segno sacro, dà finalmente corpo al nome del padre che non si potrebbe seppellire altrimenti, perché non è morto e non ha lasciato alcun cadavere. Per l’opposta ragione, l’impossibilità di pronunciare il nome della madre e, più in generale, di dare un nome ai fatti del passato e ai loro esiti, non si estingue l’altra furia: quella, fredda e composta, della relazione tra due donne che non sanno dire il dolore e neppure l’amore. Salverà in qualche modo entrambe un incontro di cui non faccio parola perché bisogna pur lasciare qualcosa al lettore; basti sapere che c’è infine un pianto con qualche risata e una traversata dello stretto, la stessa dell’andata. Questa volta, però, Caronte porta sull’altra sponda un’anima mutata per la quale, forse, la felicità non esiste ma esistono momenti felici.
Non si sbaglia: lo stretto, ancora una volta, ha compiuto la sua magia.

