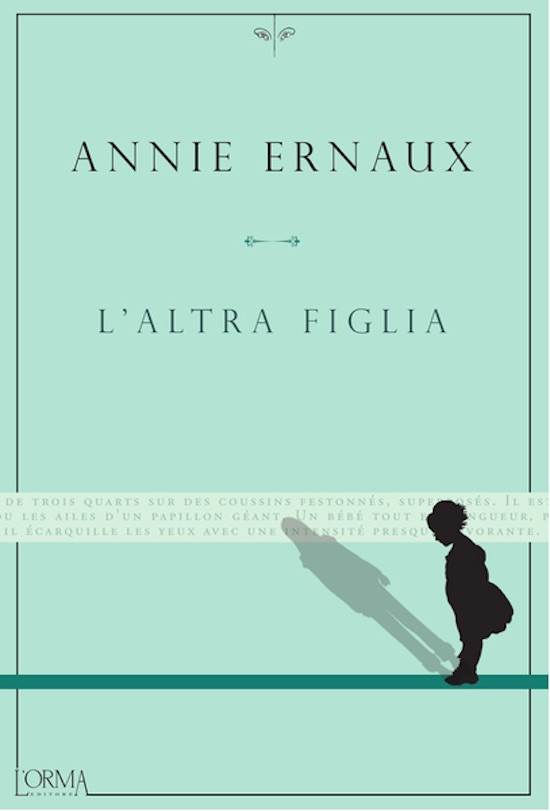
Sembrerà un paradosso e forse non lo è: senza parole l’onda immensa di ogni ricordo e di tutte le infinite possibilità non lascerebbe altre vie di scampo che la morte o l’oblio. Di questo mi azzardo a parlare accostando, non senza arbitrio e un po’ per caso avendo letto/ riletto i due testi in sequenza, il racconto di Borges intitolato Funes o della memoria (dalla raccolta Finzioni) e L’altra figlia di Annie Ernaux (da poche settimane in italiano, grazie alla traduzione di Lorenzo Flabbi e a L’Orma editore).
Memoria e scrittura: L’altra figlia di Annie Ernaux
Il tema del romanzo della Ernaux non stupirà chi un poco conosca questa scrittrice francese che proprio sulla memoria ha costruito molto della sua narrazione (si vedano Il posto e Gli anni, sempre per i tipi de L’Orma). Qui Annie Ernaux ci porta alla sorgente della sua scrittura: una conversazione ascoltata per caso a dieci anni nella bottega di famiglia e la scoperta di una sorella la morta ancora bambina due anni prima della nascita di Annie. L’altra figlia appunto.
Introduce questa lettera impossibile a una sorella mai incontrata una citazione di Flannery O’Connor : “Credere è la maledizione dei bambini”. Crede infatti Annie bambina, ben al di là di ciò che si dipana sotto i suoi occhi, anche quando l’incanto finisce e uno scambio di battute rivela l’esistenza di una sorella che le parole della madre consegnano a un’aura di santità.
Credono, o fingono di credere, tutti i suoi familiari, tenendo in vita la finzione “al di là di ogni verosimiglianza”. E Annie accetta la consegna del silenzio per pietà e perché negli anni Cinquanta, “secondo una regola implicita, era proibito interpellare i genitori, o gli adulti in generale, su ciò che non volevano che sapessimo ma che sapevamo già”.
Crede, infine, chi si concede il privilegio di leggere queste pagine struggenti eppure senza lacrime. Ma è una credulità, questa, tutta diversa. Le parole della scrittrice pescano fra i relitti dell’infanzia e rendono condivisibile quel che sembrerebbe irrimediabilmente personale. La soggettività del ricordo trova finalmente cittadinanza tra le cose che si dicono e si ascoltano.
È proprio l’opposto della consegna del silenzio implicitamente ricevuta da bambina. La rivelazione dei dieci anni, dolorosa ma a ben guardare non del tutto inattesa, segna il confine tra l’infanzia e l’età adulta, ma anche tra il silenzio e la tormentata ricerca della propria voce – che sarebbe poi a dire anche del proprio sguardo sul mondo.
Attraverso il linguaggio, la vita trova un ordine e un significato sorprendente: “Orgoglio e senso di colpa nell’esser stata scelta per vivere, in un disegno indecifrabile. Forse più orgoglio della sopravvivenza che senso di colpa. A vent’anni, dopo essere discesa nell’inferno della bulimia e del sangue mensile prosciugato, è arrivata la risposta: per scrivere. Io non scrivo perché tu sei morta. Tu sei morta perché io possa scrivere, fa una grande differenza”.
Sorprende questa specie di rovesciamento teleologico che trasforma ciò che sarebbe facile collocare all’origine dell’evento scrittura, ossia la morte dell’altra figlia (sorella per Annie) ma anche il suo disvelamento, in un evento per altro, giustificato proprio dal fine della nascita di Annie, della scrittura di Annie: Tu sei morta perché io possa scrivere – delirante gioco di parole? il segno della licenza soggettiva di ognuno davanti alle tessere della propria storia?
Attraverso un analogo rovesciamento del senso comune, la morte che ha impedito alle due bambine di conoscersi, anziché interrompere un legame possibile, ne costituisce il presupposto d’esistenza: “La loro (dei genitori) determinazione ad avere un solo figlio, manifestata nella frase non potremmo fare per due quel che facciamo per una, implicava la tua vita o la mia, non entrambe”.
Dunque nessuna Annie senza la morte della prima figlia e nessuna sorellanza senza quel lutto. E infatti quella di Annie si propone come una vita contrassegnata sin dalla nascita dalla dualità. Il monologo è una lettera “finta” alla sorella, differente da quelle vere che si scrivono ai viventi, eppure (o proprio per questo) non meno connotata da realtà: chi sopravvive cerca in chi non ha mai conosciuto la sua interlocutrice, offrendo all’assente la sola forma possibile di esistenza: “Da bambina – è lì l’origine della scrittura? – credevo sempre di essere il doppio di un’altra, di una che viveva altrove. Di non stare nemmeno vivendo per davvero, ma che la mia vita fosse “la scrittura”, la finzione dell’altra. È qualcosa da approfondire questa assenza d’essere o questo essere fittizio. Forse è questo l’oggetto della finta lettera che sto scrivendo – sono vere solo quelle indirizzate ai viventi.” E ancora: “La tua esistenza passa solo attraverso l’impronta che tu hai lasciato sulla mia. Scriverti non è altro che fare il giro della tua assenza. Descrivere l’eredità dell’assenza. Sei una forma vuota che è impossibile riempire di scrittura”.
Sembra di trovare nell’enigma della scrittura qualcosa che richiama l’enigma del ricordo: presenza e assenza compongono l’irriducibile dualismo che chi legge sperimenta nell’immaginazione che nasce appunto dalla parola altrui. Ogni racconto dilata e insieme rende più sapida l’esperienza di chi legge. Il ricordo spontaneo di Annie (esplorato nella finzione ma comunque soggettivo), attraverso la scrittura si presta alla costruzione di una co-memoria che coinvolge chi scrive e chi legge – in questo senso lector in fabula. Ogni essere umano fa i conti con l’assenza, ogni vita è variamente connotata dalla perdita. A partire da questa intima somiglianza scrittura e lettura possono essere il laboratorio in cui si sperimenta la costruzione di un noi.

La prigionia del ricordo: Funes o della memoria di Jorge Luis Borges
Proprio l’impossibilità del linguaggio nasce invece il dramma di Ireneo Funes, protagonista del bel racconto di Borges. All’età di diciannove anni egli subisce un incidente che gli procura la paralisi e una percezione e una memoria infallibili. Prima di allora “era stato ciò che sono tutti i cristiani: un cieco, un sordo, uno stordito, uno smemorato (…) aveva vissuto come chi sogna: guardava senza vedere, ascoltava senza udire, dimenticava tutto, o quasi tutto”.
Il nuovo stato è tutt’altro che un privilegio: l’immobilità è un prezzo minimo rispetto alla condanna della percezione e del ricordo, che non sa trovare nelle parole uno spazio di ordine e di comunicabilità. Scrive Borges: “Era quasi incapace di comprendere come il simbolo generico cane potesse designare un così vasto assortimento di individui diversi per dimensioni e forma; ma anche l’infastidiva il fatto che il cane delle tre e quattordici (visto di profilo) avesse lo stesso nome del cane delle tre e un quarto (visto di fronte)”.
Ora, a me pare che la memoria di ciascuno oscilli entro queste due estreme polarità: quella di chi guarda senza vedere, ascolta senza udire e dimentica tutto (si direbbe la più diffusa oggi, ma forse è solo un’illusione prospettica) e quella di chi come Funes rischia di sacrificare la vita stessa alla tirannia di un ricordo eternamente presente proprio perché senza parole (memorie che non possono confluire nel simbolico, né essere condivise).
Si dice che la storia e la scrittura siano una strenua lotta contro il tempo. La gloria che tanti hanno cercato nella poesia non sarebbe che il goffo tentativo di superare l’ineluttabilità della morte – una profferta alla posterità che sarà forse ripagata con una tomba in Santa Croce o al Monumentale (oppure con l’intitolazione di una via, fosse pure in un modesto quartiere periferico). Così sui banchi abbiamo imparato a leggere l’arte e il legame foscoliano e “sepolcrale” tra memoria e scrittura. Ma il farmaco della memoria, la scrittura, ha forse altre indicazioni.
Torniamo a Borges. Stupito che Funes non si stato oggetto di studi scientifici, il narratore dice “il fatto è che viviamo ritardando tutto il ritardabile; forse sappiamo tutti profondamente che siamo immortali e che, presto o tardi, ogni uomo farà tutte le cose e saprà tutto”.
Quanto più vere certe parole nel nostro secolo ormai più che breve, segnato da una ripetizione che dilata i confini dell’esperienza – anestetizzandola però, con l’esito di favorire proprio l’ascolto disattento, lo sguardo che non vede, la dimenticanza. Saremo dunque ciechi, sordi, storditi e smemorati per non soccombere sotto l’onda di ciò che abbiamo vissuto e di ciò di cui siamo stati semplici spettatori? Oppure, proprio come Funes, resteremo intrappolati in un eterno e sconfinato presente, e dunque inesorabilmente soli, senza il soccorso della costruzione di quella che Paul Ricoeur chiamava co-memoria?
L’enigma della scrittura e della memoria: il rallentamento dell’immortalità.
Come ho spiegato, l’azzardo di questa riflessione parte da suggestioni casuali, i due testi che avevo per le mani sono stati uno il controcanto dell’altro. Dunque non dirò nulla di più di ciò che altri hanno opportunamente e meglio indagato circa il legame enigmatico tra memoria e scrittura.
Mi pare di intuire però che lo specifico del ricordo, quando la finzione lo trasforma in parola (e parola scritta), sia non tanto o non solo la facoltà di trattenere e salvare ciò che altrimenti andrebbe perduto per sempre, ma paradossalmente di offrirsi come antidoto a quella potenziale, insostenibile immortalità di cui Borges parla.
Centellinando i ricordi, costruendo corrispondenze, individuando significati altrimenti indistinguibili chi racconta domanda a chi legge una collaborazione interpretativa.
Postulato di entrambi è la fiducia nell’idea che la storia, personale e collettiva, pur nella sua enigmatica e irriducibile complessità, sia interpretabile, che valga la pena esercitare e condividere le facoltà della memoria, dell’immaginazione e del pensiero.
Questa azione di rallentamento dell’immortalità sembra proprio la responsabilità assunta da alcuni scrittori affinché la memoria propria e di tutti non sia, come già per Funes, un grande deposito di rifiuti.
“Non scrivo perché tu sei morta. Tu sei morta perché io possa scrivere, fa una grande differenza”. Il dato di certezza nella storia di Annie Ernaux è che sono avvenuti nell’ordine: la morte di una bambina, la nascita di una sorella, dunque il silenzio e la scoperta inattesa di una verità dolorosa, infine (soltanto da ultimo) il racconto. Nessuna scrittura potrà mai regalare a tali eventi più realtà o verità o evidenza , ma il linguaggio ha la capacità di offrire un ordine e un senso possibile al vuoto di significato che affolla la vita di chi scrive e anche quella di chi poi, leggendo, riconosce qualcosa di sé.
Questo fa una grande differenza.
P.S. La riflessione nasce anche da un incontro-laboratorio tenuto a Fano, lo scorso 12 giugno, nell’ambito di Letteraria Lab. Ringrazio per le preziose sollecitazioni tutti i partecipanti e in particolare Maura Maioli, organizzatrice del premio Letteraria Fano, instancabile promotrice di letture e a sua volta tessitrice di memorie con l’ultimo romanzo Dalla mia casa non si vedeva il mare (Pequod 2016).

