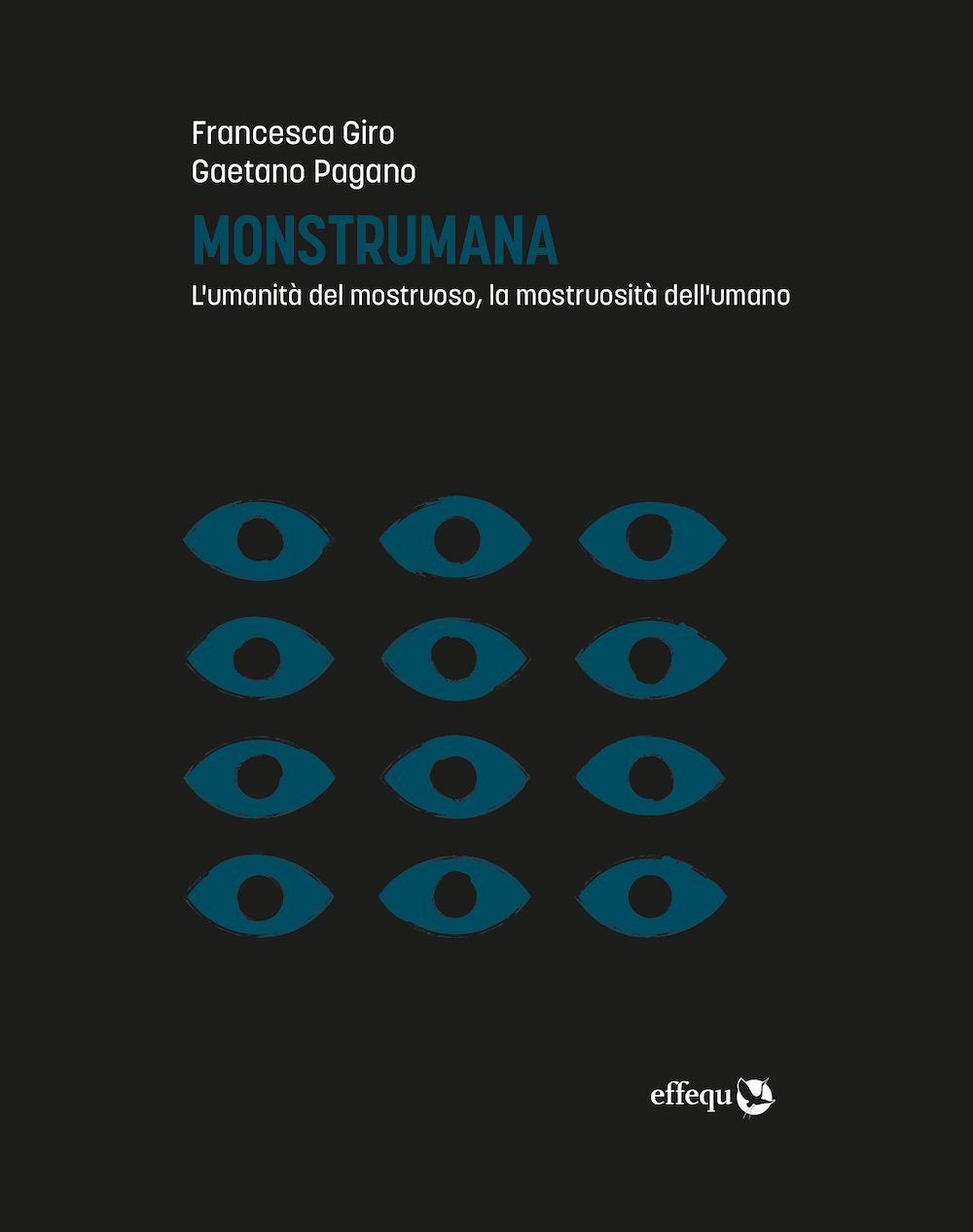La fantasia di autori e autrici della letteratura ha spesso prodotto personaggi talmente fuori dagli schemi da trascendere i confini dell’umano: esseri ibridi o deformi, vampiri, stirpi semiferine, sirene, meduse, spettri infestano da secoli, se non da millenni, le storie dei popoli della Terra, dei quali raccontano le paure, le ossessioni, gli odi. Di alcuni, i più celebri, di questi mostri parla il nuovo «saggio pop» di effequ Monstrumana. L’umanità del mostruoso, la mostruosità dell’umano, scritto a quattro mani da Francesca Giro e Gaetano Pagano. Attingendo a studi teorici di area anglofona (nel Regno Unito e negli Usa i racconti di mostri e dunque anche la relativa critica hanno una tradizione consolidata), Giro e Pagano propongono una curiosa mappatura delle creature mostruose e ne offrono letture originali.
Quello che colpisce della loro analisi è la stratificazione culturale che ha interessato i «mostri», la loro evoluzione nel tempo, che non smette di offrire alla scrittura letteraria spunti sempre nuovi e rivisitazioni sorprendenti. La genealogia di Monstrumana inizia con Frankenstein (1818) di Mary Shelley, il risultato di un esperimento nel quale Giro e Pagano vedono il riflesso dei difficili rapporti familiari dell’autrice, rimasta orfana di madre (la femminista Mary Wollstonecraft) e priva della presenza del padre (il filosofo William Godwin), al quale il libro è dedicato. La Creatura del dottor Frankenstein, in un rapporto di genitorialità inconsueta tra i due, entra in un discorso sul corpo e sulla sua riproducibilità, sulle potenzialità della scienza, sulle categorie canoniche di bello e di brutto. Queste riguardano ancora più da vicino Quasimodo, il campanaro del romanzo di Victor Hugo Il gobbo di Notre Dame (1831), vittima di quel potere di «sorvegliare e punire» magistralmente definito da Michel Foucault. Il sorvegliante qui è il famigerato Frollo, un uomo laido che a dispetto della sua carica e dell’onorabilità che vorrebbe imporre è guidato da avidità e cattiveria, sia verso il campanaro sia verso Esmeralda, un’altra «diversa». Sarà proprio lei a mostrare empatia per Quasimodo messo alla berlina, rivelando che la mostruosità non sta dalla parte di chi è escluso ma da quella di chi esclude.

Un personaggio mostruosamente interessante per le molteplici letture che ha subìto è Calibano, l’uomo che, nella Tempesta (1610-11) di William Shakespeare, vive solo, in un’isola del Mediterraneo, prima di incontrare Prospero e la figlia Miranda, che lo riducono in schiavitù. La trasformazione in «mostro» di Calibano si colora di significati nuovi alla luce degli studi postcoloniali: negli anni della decolonizzazione, il personaggio cominciò a essere letto non più come espressione di aggressività ed eccessi ma come vittima delle sopraffazioni europee (Prospero e Miranda vengono dall’Italia, da Milano). In quest’ottica, Prospero prefigura l’azione dei colonizzatori bianchi, che definiscono il perimetro dell’uguaglianza e della diversità, impongono le proprie tradizioni culturali a partire dalla lingua, sottraggono la terra alle popolazioni locali e poi le accusano di sedizione.
Tra i tanti «mostri» citati nel saggio non poteva mancare il personaggio ambiguo di Jekyll-Hyde (1886), in cui le categorie del bruto e del brutto si assommano, né il vampiro Dracula (1897), sottoposto a una lettura intersezionale; nel conte transilvano, infatti, vengono rilevati i vari fattori che, collegati insieme, fondano la sua presunta diversità, non ultima la sfera sessuale e quella di genere. Gli uomini e le donne del romanzo di Stoker sfidano il conformismo dell’età vittoriana, così perbenista ma così bramosa di evasioni eccentriche, per abbracciare modelli alternativi del maschile e del femminile (soprattutto del materno), fino ad acquisire ruoli e comportamenti loro preclusi nella società reale. Al vampirismo queer di Dracula fa eco quello di Carmilla, la vampiressa protagonista dell’omonimo romanzo pubblicato da Joseph Sheridan Le Fanu nel 1872; nella sua storia si intravedono elementi di rivendicazione politica, legati alla lotta indipendentista dell’Irlanda, di cui l’autore era originario, e considerazioni mediche, legate alla paura dei morbi e alle teorie del contagio.
Ci sono poi i mostri freak, plasmati dai loro creatori o creatrici sull’onda di un compiaciuto gusto per l’orrido, il reietto, la marginalità fisica e biologica. Ne fanno parte, nel Signore degli anelli, Gollum, già membro come Sméagol di una «razza» antica di hobbit, parlante una lingua a sé e portatore di un’ambiguità morale che invano Frodo cerca di risolvere e a cui è affidata la salvezza della Terra di Mezzo (sarà infatti il mostro schizofrenico, non l’eroe hobbit, ad assicurare la distruzione dell’anello). E a proposito di freak, Giro e Pagano si soffermano su Sophie Fevvers, la protagonista del romanzo Notti al circo (1984) di Angela Carter, ambientato – ça va sans dire – nella Londra di fine Ottocento. Le ali di Fevvers, che le permettono di volare verso l’indipendenza per cui le suffragiste stavano in quegli stessi anni combattendo, diventano, nello spazio eccentrico della performance circense, non un vizio da reprimere, ma una qualità da applaudire. La freakaggine di Fevvers, reale o performativa che sia, è però esposta a commenti, censure, dubbi e non viene per nessuna ragione ammessa al di fuori dello spettacolo:
riconoscere una diversità attraverso la derisione della stessa è probabilmente il metodo più immediato e facile di definire, più che il soggetto deriso, il soggetto che deride. Deridere è una forma di odio, e l’odio conferisce identità: dà la sensazione di definirsi, soprattutto a partire da ciò che non siamo. Odiando, definiamo ciò che è altro e al contempo definiamo noi (p. 175).
Il freak è dunque esposto allo stigma sociale e, allo stesso tempo, a quella tolleranza sussiegosa, e solo apparentemente inclusiva, che, confermando la «normalità» del centro, relega ai margini tutto il resto; ogni tanto qualche piccola eccezione riesce a varcare il confine della regola, grazie a una concessione dall’alto oppure in cambio di una spettacolarizzazione deformante.
Infine, ci sono i mostri che discendono dai miti antichi e che in seguito hanno conosciuto riscritture più o meno distopiche: è il caso delle sirene, variamente raffigurate nell’immaginario greco-latino ed ebraico-cristiano, fino alla loro cruda rappresentazione nel romanzo (2007) che a loro ha dedicato Laura Pugno (in libreria anche con Melusina, con le strepitose illustrazioni di Elisa Seitzinger, nata a Ornavasso, Comune ossolano con una sirena nello stemma). Pugno racconta di sirene spossessate del loro regno acquatico da una specie umana in fuga dal mondo terrestre e crudelmente sfruttate a fini commerciali o sessuali. Il loro essere creature in transito, corporalmente partecipi di più nature, interpreti di ruoli da principesse non solo passive (la Ariel di Andersen è impersonata, nel live action Disney, da un’attrice afrodiscendente), non conta, anzi viene negato e represso dall’egemonia del binarismo e del capitalismo.

Come non ricordare, a questo proposito, il pasto a base di sirena bollita nel capitolo Il pranzo del generale Cork della Pelle (1949) di Curzio Malaparte? Gli alti ufficiali anglo-americani giunti a Napoli nell’autunno del 1943 pretendono cibarie all’altezza della fama della cucina italiana e così i cuochi, in mancanza d’altro, sono costretti a imbandire i pesci dell’acquario cittadino, tra cui appunto una sirena:
Giaceva quella bambina nella sua bara d’argento, e pareva dormisse. Ma, per un’imperdonabile dimenticanza del cuoco, dormiva come dormono i morti cui nessuno ha avuto la pietosa cura di abbassar le palpebre: ad occhi aperti. E mirava i tritoni di Luca Giordano soffiar nelle loro conche marine, e i delfini, attaccati al cocchio di Venere, galoppar sulle onde, e Venere nuda seduta nell’aureo cocchio, e il bianco e roseo corteo delle sue Ninfe, e Nettuno, col tridente in pugno, correr sul mare trainato dalla foga dei suoi bianchi cavalli, assetati ancora dell’innocente sangue d’Ippolito. Mirava il Trionfo di Venere dipinto nel soffitto, quel turchino mare, quegli argentei pesci, quei verdi mostri marini, quelle bianche nuvole erranti in fondo all’orizzonte, e sorrideva estatica: era quello il suo mare, era quella la sua patria perduta, il paese dei suoi sogni, il felice regno delle Sirene.
Nella pungente descrizione di Malaparte, la sirena è posta al servizio di un’impietosa gastronomia di guerra, con buona pace di una white savior che assiste inorridita all’impiattamento della creatura. In un mondo distopico come quello della guerra persino il mostro della tradizione perde qualunque connotazione paurosa per essere inglobato nel sistema di potere corrente (e, nella realtà, nel marchio della catena Starbucks). Un analogo passaggio ha interessato il volto di Medusa, la gorgone dallo sguardo pietrificante, finita su uno scudo (perduto) dipinto da Leonardo da Vinci, quindi trasformata da Gianni Versace nell’inconfondibile blasone della sua casa di moda, oltre che effigiata ovunque nelle sue lussuose dimore. Ma Medusa può anche essere presentata come una donna vittima di traumi e violenze, di stereotipi e di gabbie normanti, a cui reagisce in maniera imprevedibile.
In più punti del libro, Giro e Pagano colgono lo sguardo umano sul «mostro», i caratteri che, come agli alieni dei film, gli attribuiamo semplicemente estremizzando alcuni tratti di Homo sapiens. È il voluto e rassicurante equivoco di chi separa «loro», gli altri, gli estranei, i lontani, da «noi», di chi condanna le pagliuzze senza vedere le travi, di chi lapida le adultere dal basso dei propri peccati. I mostri della letteratura sono noi, sono il nostro immaginato riflesso – questo è indubbio –, mentre noi come umani e umane possiamo scegliere, forse, di non essere dei mostri.