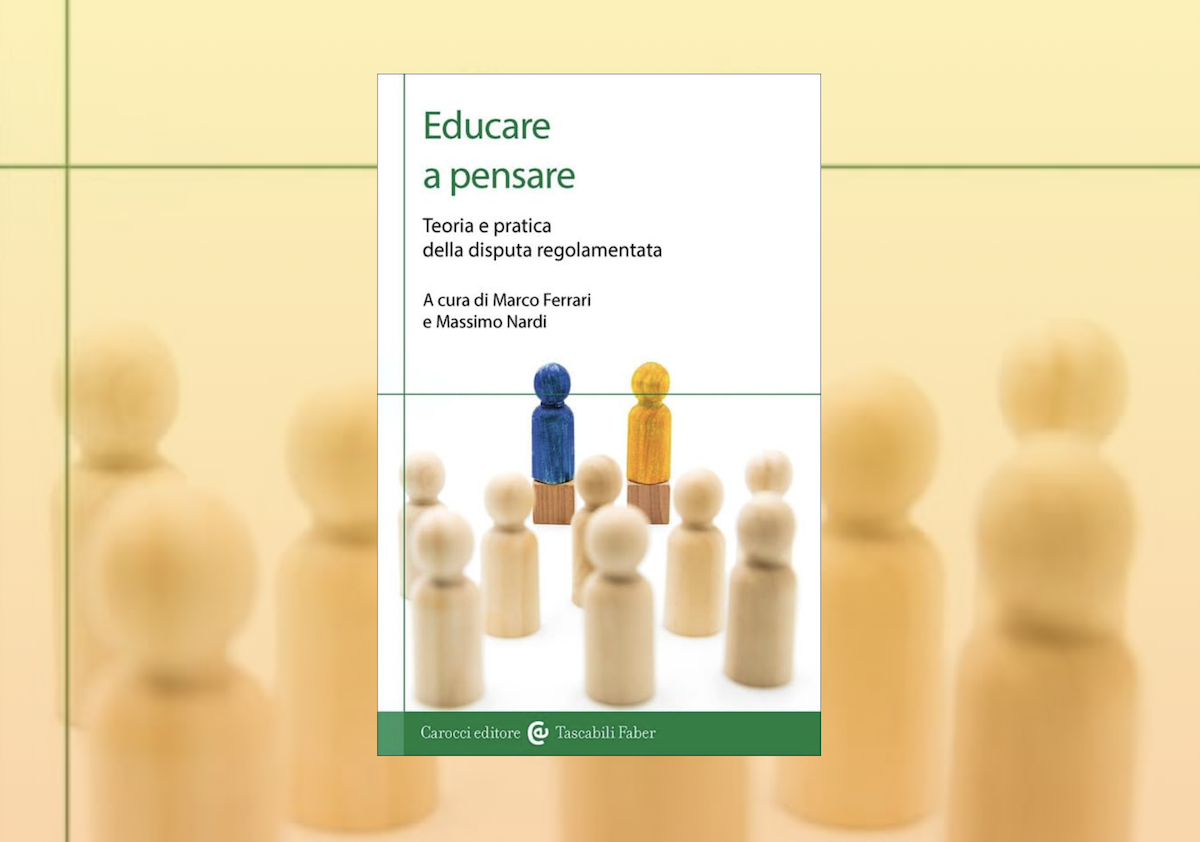Gian Paolo Terravecchia, nel suo contributo «Stili di disputa e aikido verbale», ospitato nel volume collettivo recentemente pubblicato «Educare a pensare. Teoria e pratica della disputa regolamentata», curato da Marco Ferrari e Massimo Nardi, si interroga sul senso della disputa regolamentata ponendo due domande cruciali: «Che cosa facciamo quando partecipiamo a una disputa regolamentata? Quali sono i nostri fini?» (p. 65).
Non si tratta di una domanda puramente accademica, bensì del cuore dell’avventura non solo intellettuale dell’autore, docente della secondaria superiore e presidente del Comitato didattico delle Romanae Disputationes, progetto di eccellenza nazionale in ambito filosofico riconosciuto anche dal Ministero dell’Istruzione.
Nel suo breve e sapido saggio, tuttavia, non è tanto la scuola a occupare il centro dell’analisi, quanto piuttosto l’aspirazione a ridefinire il dibattito stesso come pratica intellettuale di cui oggi si avverte un’estrema necessità. Terravecchia critica due approcci tradizionali: quello competitivo, ossessionato dalla vittoria, e quello non competitivo, incline invece a una partecipazione superficiale e, ultimamente, disimpegnata. Il primo «favorisce il cinismo» (p. 66), riducendo l’interlocutore a un «nemico da sconfiggere»; il secondo risulta demotivante, poiché «non favorisce quello sguardo tagliente sulle questioni» (p. 66) indispensabile per una ricerca autentica.
Terravecchia propone così una terza via, definendo la disputa come una «forma di lotta verbale finalizzata al perseguimento dell’armonia» (p. 66). Un approccio che richiama chiaramente la dialettica socratica, in cui il confronto non mira a dominare, ma a illuminare la verità attraverso un percorso condiviso. Non si tratta di un duello, bensì di un cammino comune verso il vero, dove severità intellettuale e rispetto trovano equilibrio. Questa visione, a mio parere, può ispirare il dibattito pubblico ben oltre il contesto scolastico.
Lo stile come chiave del dialogo
Ci si aspetterebbe a questo punto un approfondimento sulle basi logiche dell’argomentazione; invece, con uno scarto imprevisto, l’autore sceglie di mettere sotto la lente d’ingrandimento lo stile del dibattito. Terravecchia osserva che i teorici dell’argomentazione, concentrati prevalentemente sugli aspetti logici, hanno trascurato «l’elocutio e l’actio» (p. 67). Mai come in questo caso invece la forma si rivela essere sostanza. Lo stile non è solo glamour intellettuale: «Nella pratica dialogica la modalità dialettica può essere decisiva» (p. 68). Per esplicitare meglio questa posizione, l’autore ricorre a un parallelo con le arti marziali, distinguendo il “karate verbale”, aggressivo e orientato ad «abbattere la tesi dell’interlocutore» (p. 69), da altre arti quali il judo e soprattutto l’“aikido verbale”, che cerca invece l’armonia mediante la comprensione.
Perché proprio l’aikido? Perché non mira a distruggere la forza dell’avversario, ma a comprenderla, accoglierla e reindirizzarla, trasformando così l’energia conflittuale in movimento armonico. È importante chiarire che Terravecchia non propone una rinuncia “buonista” alla severità intellettuale o al confronto diretto e franco in nome di una filosofia orientaleggiante. L’armonia ricercata non è semplice concordia, bensì un equilibrio dinamico che integra prospettive diverse e valorizza il dialogo come strumento di crescita reciproca. Si tratta di un approccio «serio, vero, intellettualmente severo, tanto quanto gentile ed elegante», capace di trasformare il dibattito da sterile scontro a fertile terreno di apprendimento reciproco.
Quest’eleganza richiama la “sprezzatura” descritta da Baldassarre Castiglione nel Cortegiano (1528), ovvero l’arte di agire con naturalezza e grazia, qualità che è al contempo estetica, etica e sociale. Il riferimento appare pertinente soprattutto perché per Castiglione queste qualità non contraddistinguevano un intellettuale astratto, ma il “cortegiano” come mediatore politico e diplomatico, una figura che poteva influenzare concretamente la vita pubblica, consigliare il principe, mediare conflitti, tessere alleanze.
La lettura dell’articolo di Terravecchia fa emergere altri echi, classici come contemporanei. Cicerone, nel De Officiis (I,136), dava questo suggerimento: «Il nostro discorso deve essere libero da moti eccessivi, affinché non emergano né ira, né qualche desiderio smodato, né pigrizia, né indolenza, né nulla di simile; e bisogna soprattutto fare attenzione a sembrare rispettosi e affezionati verso coloro con cui conversiamo». Un autore che ha sviluppato particolarmente il tema della leadership come Stephen R. Covey, esorta: «Se dovessi riassumere in una frase il principio più importante che ho imparato… sarebbe questo: cerca prima di capire e poi di essere capito». Terravecchia propone inoltre tecniche specifiche, come il sorriso interiore (p. 71) che migliora concentrazione ed ethos, e il “tenkan”, movimento dialettico di «ammissione senza concessione della tesi altrui» (p. 71) che guida l’interlocutore verso i limiti della sua posizione.
Breve digressione sul tenkan, tecnica tipica di quell’arte marziale giapponese che è l’Aikido. Un’analogia scacchistica, non esplicitata da Terravecchia che però ha un background di giocatore, rende chiaro il concetto. Come negli spettacolari sacrifici scacchistici propri di campioni quali Kasparov, Tal, Alekhine, apparentemente svantaggiosi, ma in realtà decisivi, l’ammissione dialettica si trasforma in vantaggio strategico. Così un cedere almeno in apparenza all’avversario, un far proprie le sue movenze, un affiancarsi quasi dolce alla sua figura permette di volgere in modo inaspettato a proprio favore la sua stessa irruenza.
Un modello per la società
La terza via proposta da Terravecchia non è dunque soltanto didattica, ma si offre come modello per un dialogo civile più costruttivo. Il dibattito politico contemporaneo, cristallizzato nella contrapposizione sterile e dogmatica (“karate verbale”), potrebbe beneficiare enormemente dell’approccio proposto dall’aikido verbale. La Dichiarazione di apertura del protocollo Age Contra di cui Terravecchia è l’autore (a p. 74), indica la strada di uscita dalla polarizzazione: «Ci impegniamo a svolgere una critica implacabile delle idee non persuasive, porgendola però con lealtà, con modi civili e col massimo rispetto». Richard Sennett (Together, 2012) lo conferma quando sottolinea la cooperazione e il dialogo come fondamentali per ottenere un effetto costruttivo nel confronto. L’aikido verbale incarna questo ideale, valorizzando il dibattito come arte della relazione.
L’intelligenza artificiale come specchio argomentativo
Il contributo di Terravecchia invita indirettamente anche a una riflessione su un tema di grande attualità: il ruolo dell’intelligenza artificiale nel dibattito. Il volume «Educare a pensare» affronta esplicitamente questo argomento nel capitolo 8, attraverso l’intervento di Pier Cesare Rivoltella, che esplora come i modelli linguistici (LLM) possano supportare la pratica argomentativa. In effetti i chatbot più diffusi oggi, come ChatGPT, Gemini, Claude o Grok, sono generalmente concepiti per conversazioni fluide e immediate più che per approfondimenti rigorosi. Tuttavia, proprio questa loro caratteristica può incoraggiare gli utenti a riscoprire e valorizzare le logiche del dibattito strutturato.
Interagire in modo adeguato con un’intelligenza artificiale impone all’utente di affinare la capacità critica: quando la risposta ricevuta appare incompleta, superficiale o imprecisa, l’utente è portato a riformulare la propria domanda, a confutare le tesi proposte o ad approfondire ulteriormente la questione, in modo analogo a quanto avviene in una disputa regolamentata. In questo senso, il confronto con un’IA, che talvolta sembra avere già tutte le risposte pronte, riporta in primo piano la fondamentale abilità di porre a più riprese domande efficaci, puntuali e pertinenti. Così, il dialogo con il chatbot può diventare un’efficace palestra di rigore argomentativo e autocoscienza critica, tanto più che questi strumenti tecnologici si propongono spesso come veri e propri sparring partner dialogici, capaci di stimolare e sfidare l’interlocutore, specialmente nelle loro versioni vocali più avanzate.
Conclusione: un invito all’armonia
Suzette Haden Elgin (The Gentle Art of Verbal Self-Defense, 1980) si concentra sull’uso consapevole e controllato del linguaggio per difendersi dagli attacchi verbali e per comunicare in modo efficace: secondo la linguista e scrittrice di fantascienza statunitense l’autocontrollo nella comunicazione è segno di autentico potere personale. Affermare, come fa Terravecchia, che «la gentilezza non è debolezza» (p. 70), sottolinea l’importanza di un modello che combina severità e grazia, tradizione classica e apertura moderna, e che potrebbe cambiare profondamente non solo l’approccio scolastico, ma l’intera cultura del dialogo pubblico.