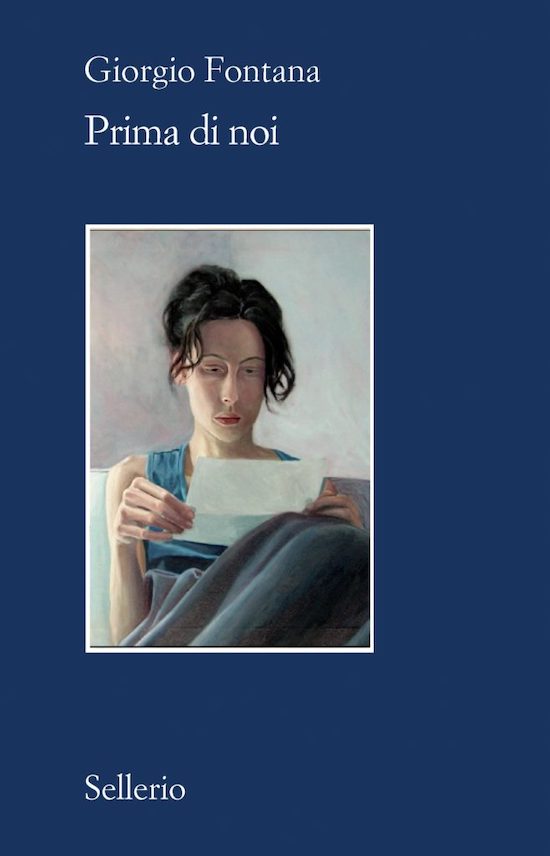
Abbandonando la prospettiva di scorcio, Fontana presenta in un racconto lineare l’epopea della famiglia Sartori nell’arco di un secolo: la miseria contadina dei capostipiti Maurizio e Nadia, in un Friuli aspro e duro, il trasferimento a Udine mentre il Fascismo sale al potere, quindi la migrazione milanese, la fabbrica, il benessere borghese, le trasformazioni e le dissoluzioni degli ultimi cinquant’anni, con l’eco delle stragi degli anni Settanta e della mafia.
L’obiettivo (doppio) è ambizioso: ricostruire, attraverso una via familiare e privata, gli eventi e le trasformazioni più salienti del Novecento italiano (e le eredità che il “secolo breve” ha lasciato al nuovo millennio) e, al contempo, condurre proprio a partire da questa storia individuale e collettiva una riflessione più ampia sul senso della storia.
Gli esordi: nessun paradiso
L’epopea familiare dei Sartori ha il suo mito fondativo in una rappresentazione antiedenica: non parte infatti da un paradiso terrestre, ma dalla campagna devastata dalla grande guerra, e il capostipite, Maurizio Sartori, non solo incarna la figura antieroica del disertore, ma per aver salva la pelle lascia morire un commilitone ferito. Trovato riparo in una fattoria, conosce Nadia, che si innamora di lui e rimane incinta del primo figlio, Gabriele; ma, di nuovo, alla notizia dell’inattesa paternità Maurizio sceglie la fuga, interrotta solo per intervento del padre di Nadia che gli impone di assumersi la responsabilità del nascituro. Anche negli anni della maturità Maurizio resta un uomo complesso e umorale, atterrito dalla vita e non esente da un impulso di morte («Voglio che salti tutto in aria. Tutto, Voialtri, la città, il Friuli e l’Italia», p. 81).
Nel sangue dei Sartori scorre dunque il gene paterno dell’egoismo e della viltà e questa eredità nascosta ha un suo corso sotterraneo: è una tara congenita, un peccato originale che sembra inquinare nella progenie ogni ipotesi di felicità e redenzione. I Sartori partecipano, attraverso Maurizio, del male del mondo; quando non ne subiscono gli effetti, sono per così dire portatori sani di un virus che intacca la loro fede in una felicità possibile e rende spesso vani i loro gesti.
Il problema del male (in assenza di Dio)
Il microcosmo della famiglia Sartori si presta a un discorso sull’uomo che sempre implica anche un discorso sul male, sul bene e in ultima analisi su Dio. Lo si coglie sin dalla prima comparsa sulla scena di Domenico, uno dei tre figli di Maurizio e Nadia: personaggio sensibilissimo al dolore del mondo, caratterizzato (quasi suo malgrado) da una disposizione al sacrificio inequivocabilmente cristologica. A differenza di Cristo, però, Domenico è un agnello che non porta redenzione, la sua sventura non è manzonianamente “provvida” (come quella di Ermengarda): egli al più testimonia il ramo estinto di una catena evolutiva che procede secondo logiche di dominio e potere.
Una delle ultime scene che lo vede protagonista si svolge in un campo di prigionia africano: qui Domenico raccoglie le riflessioni di un uomo che tutti chiamano evocativamente il Profeta:
Il bene su questa terra non esiste se non per pochi istanti. Di certo non esiste la provvidenza. Dio non interviene in nulla, non ascolta le preghiere né punisce i colpevoli. (…) Non c’è ragione possibile. Il fondamento del mondo è il dolore. (…) Qualche filosofo dice che il male è assenza di bene. (…) E se fosse il bene ad essere assenza di male? Se il Dio che adoriamo non fosse che un angelo ribelle, esiliato in paradiso dal vero sovrano di questo universo? (…) Inutile pregare, inutile sperare perché Dio non ha forze sufficienti per salvarci (pp. 237-28).
Il mondo appare dunque irredimibile, ma nell’inferno in cui Dio non può nulla, Domenico è capace d’amore, non perché amare abbia un senso o valga a sanare le ferite della storia, ma perché non può fare altrimenti.
A questa forma di fede si affianca quella di chi, nonostante tutto, si abbandona a una fiducia istintiva e laica nell’arte: Gabriele, scrittore e professore, trova nella letteratura una prospettiva insieme etica ed estetica, Diana, sua nipote, crederà nella musica, nel proprio talento e nell’amore.
C’è poi la fede politica di Renzo, il fratello di Domenico, che si interroga: «Vale la pena difenderlo questo mondo? Un mondo dove la gente si ammazza così? Vale la pena fare la rivoluzione e cambiarlo» (p. 258), un punto di vista che, spinto fino alle sue estreme conseguenze, anticipa gli esiti devastanti della lotta armata.
Per tutti questi personaggi tuttavia, il riscatto resta un fatto individuale poiché non si dà nessuna salvezza collettiva e nessuna rivoluzione è davvero possibile.
L’impossibile fuga dalla storia
In una scena molto evocativa ambientata a Udine negli anni Trenta, dove Gabriele anima un piccolo cinematografo, suo fratello Renzo, spettatore di un film che prevede la morte di una principessa, un po’ per ribellione, un po’ per scherzo, decide tra le proteste di proiettare la pellicola a ritroso per salvare la principessa. Le immagini che scorrono all’incontrario offrono la metafora di una reversibilità degli eventi che la vita non contempla.
L’idea della storia reversibile richiama quella di una retro-topia, ossia di un’utopia che, come nel mito del paradiso terrestre, riguarda il passato anziché il futuro. A coltivare questa prospettiva è Gabriele, il figlio non voluto, personaggio che più di tutti incarna una visione idealista dell’esistenza, molto romantica e molto libresca. Scrittore onesto ma di modestissimo talento, che vive il suo tempo senza appartenervi realmente, all’amata rivolge l’invito del poeta slavo Izet Sarajlic «Cara, e se provassimo a fuggire dalla storia?» (p. 698).
La fuga di Gabriele sono i libri e il sogno di un paradiso perduto che egli sente nell’infanzia vissuta con i due fratelli prima che la grande tragedia del Fascismo e della guerra si intrecciasse con quella più minuta dei conflitti familiari. La sua visione è talmente disancorata dalla realtà che egli, depositario di una lettera che potrebbe rivelargli la verità circa la nascita non voluta dal padre Maurizio, rinuncia a leggere, restando così fedele alla finzione che ha costruito e conducendo una vita serena. Tuttavia la sua felicità non è senza colpa, poiché la scelta di ignorare il passato rende la propria discendenza orfana della verità e senza memoria: senza una storia da perdonare e seppellire, nessun futuro è possibile.
La generazione senza trauma e il dolore come colpa
Se è vero che ogni testo è un ipertesto (come non ripeterlo a ogni lettura), l’ultimo romanzo di Giorgio Fontana è un pozzo di riferimenti alla grande letteratura, all’arte e alla filosofia. Si sente la formazione e la riflessione dello storico che Fontana è stato e che continua a essere, anche attraverso nelle sue scritture che spesso si inseriscono in un solco propriamente manzoniano.
Proverò a proporre una chiave di lettura che muove dalle riflessioni del filosofo berlinese Walter Benjamin, particolarmente cogenti per le sezioni finali del romanzo, dedicate ai personaggi che chiudono la vicenda dei Sartori: Dario e Letizia.
Più o meno coevi del loro autore, e dunque trentenni nel 2013, quando il romanzo si conclude, i personaggi più giovani della saga incarnano la condizione esistenziale di chi, nato alla fine degli anni Settanta o nei primi Ottanta, è spesso al centro di luoghi comuni appiattiti sulle categorie della precarietà e del disimpegno. Dario e Letizia, in effetti, non sfuggono ad alcune connotazioni che richiamano questa rappresentazione, ma, come succede spesso con la letteratura, smascherano la complessità che si cela dietro al cliché.
Per Dario potrebbe valere la descrizione di Franz Tunda, il protagonista di Fuga senza fine di Joseph Roth (romanzo del cuore di Fontana, che infatti lo cita più volte):
sano e vivace, un uomo giovane, forte, dai molti talenti, (…) Tunda non sapeva cosa fare. Non aveva nessuna professione, nessun amore, nessun desiderio, nessuna speranza, nessuna ambizione e nemmeno egoismo. Superfluo come lui non c’era nessuno al mondo (Joseph Roth, Fuga senza fine, Adelphi 2002, p. 152).
Come Tunda, Dario è un campione di straniamento, immune al dolore come all’amore, preserva sé stesso da un trauma che ha già conosciuto e che teme ripetersi (la madre lo ha abbandonato per seguire la vocazione missionaria in Africa). Non è privo di sensibilità e talento, ma coltiva una concezione particolare del talento, come una sorta di superpotere che rende chi lo possiede diverso da tutti; è una qualità che non chiede di essere spesa, destinata al bene o al male, né offre una via per la felicità; può rendere forti, ma, come accade a Hulk nei fumetti, il più forte di tutti e anche il più solo.
Sua coetanea è la cugina Letizia. Anch’essa è un personaggio segnato dal tempo a cui appartiene, ma se Dario si percepisce solo ma sano e non cerca alternative alla sua condizione, Letizia esprime la sua sofferenza attraverso il corpo: gli attacchi di panico rendono tangibile una «precarietà che da esistenziale e lavorativa diventa infine biologica» (p. 796). A differenza del cugino, Letizia vuole essere felice e prova a esserlo innanzitutto cercando di comprendere l’origine del suo male, che sente non individuale ed esclusivo, ma frutto comune della forza del passato sul presente (p. 799).
La famiglia Sartori, spostandosi da un Friuli contadino e periferico nella grande metropoli, ha accumulato benessere economico, cultura e una stabilità ignota ai suoi avi. Se però una quota di sofferenza è connaturata all’esistenza (come la storia insegna), superato il «dolore fisico, fame e freddo e povertà o comunque una qualche privazione», ai più giovani non può che toccare un destino di ferite interiori.
Nessuna guerra che meriti di finire nelle pagine di un libro: solo una costante paura del futuro e una altrettanto grande paura di voltarsiper rimanere pietrificati sotto il peso di quanto accaduto prima di loro, un cumulo insostenibili di morte e vita, ricchezza e spreco (p. 864).
Quella di Letizia e Dario è la prima generazione effettivamente senza trauma: fossero nati pochi anni prima avrebbero conosciuto la stagione del terrorismo e delle stragi; al contrario, la loro vita è stata soltanto sfiorata dall’eco di guerre che non si combattevano sulla loro pelle:
Magari le fosse successo qualcosa di terribile, magari fosse stata abbandonata dalla madre quando era bambina. Invece no, doveva cavarsela da sola e non aveva diritto di lamentarsi, come le aveva detto una volta Federico, il senso di colpa borghese era cosa più borghese che ci fosse. E dunque, completò la diagnosi, il corpo della paziente lo ha espresso al suo posto (p. 811).
La sofferenza come colpa borghese connessa al capitalismo, il capitalismo come religione tutta immanente, fondata esclusivamente sul culto, senza alcuna possibilità di fuga o redenzione: ecco la lezione che Fontana mutua da Walter Benjamin (su «Minima et moralia» un suo contributo proprio su questo tema).
E, se vale l’idea che Benjamin sia un autore-chiave per comprendere la narrazione di Fontana, nella paura di voltarsi indietro cui Letizia fa riferimento, possiamo riconoscere lo sguardo dell’angelo della storia immaginato dal filosofo tedesco nella IX delle sue Tesi di filosofia della storia (1939-1940):
Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto, ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che gli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.
Tesi di filosofia della storia (1940), in Id., Angelus novus. Saggi e frammenti, trad. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino, pp. 78, disponibile online qui.
Il futuro a cui l’angelo dà le spalle è incerto, l’unica certezza sono le macerie della storia. Esiste una via d’uscita dalle macerie, potremmo chiederci con il filosofo berlinese? E chi è, nel romanzo di Fontana, l’angelo novus?
Memoria e pietà: una via per uscire dalle macerie
La famiglia Sartori nasce con Maurizio ed esaurisce con l’ultimo maschio Dario il suo cognome, ma a questa patri-linearità si associa una circolarità della linea femminile e materna. Se l’inquietudine, l’egoismo, la viltà e l’impulso di morte sono l’eredità di Maurizio, sua moglie Nadia è invece testimone dei valori opposti (il coraggio della verità, la fede nell’amore e la pietà) che si riconoscono in tutte le donne della famiglia e che raggiungono anche Letizia, offrendo per la prima volta una via di riscatto non solo individuale.
Nell’imminenza della catastrofe bellica che minaccia la sua famiglia, per due volte Nadia aveva cercato l’aiuto della veggente Elsa Winkler. Non ne aveva ricavato alcun pronostico ma alcune premesse che ci aiutano a capire meglio il resto della vicenda.
Quello che faccio io [interrogare i morti] funziona attraverso la sofferenza, perché è l’unica misura dell’amore. Ciò che muove il cosmo, materiale e immateriale.
Quindi, a proposito della tragedia collettiva che sta per calare sull’Europa:
Se crede al mostro, può credere anche alla spada che l’uccide. Se crede in qualcosa di cattivo, può, anzi deve, credere anche nel rimedio. Altrimenti è tutto vano (p. 161).
La spada, aveva decretato la veggente al secondo incontro, è Nadia stessa.
Nadia è una donna semplice, insensatamente devota a un uomo che appare debole e che tuttavia ella ama con la certezza d’essere a sua volta amata («A volte le anime elette sono belle e pure; più spesso sono imperfette e lacerate. Ma forse tutte, se capaci di umiltà, spetta un angolo di paradiso», p. 157). Non ha paura della sua storia sghemba perché in essa coglie una trama d’amore e la manifestazione dell’unico paradiso possibile, quel tipo di paradiso che anche Letizia sogna per sé e che forse trova proprio grazie a qualcosa che dalla bisnonna giunge fino a lei.
Ultima di una progenie di donne coraggiose e capaci di una fede non astratta nella vita e nell’amore, Letizia vince così il panico e trova il coraggio di voltarsi indietro, non con un’espressione d’orrore ma con uno sguardo compassionevole. L’angelo della storia, l’uomo del futuro, nella narrazione di Fontana è una donna e la sua via d’uscita dalle macerie è la pietà per ciò che è venuto «prima di noi».
