
Tranquillizzo subito i lettori affermando che non ho alcuna intenzione di trattare in modo sistematico il rapporto tra l’imperatore Adriano (117-138 d.C.) e la Grecia, e in particolare l’amatissima Atene, città dove soggiornò a lungo prima e durante il suo regno e della quale volle non solo assumere la cittadinanza, ma anche la suprema carica politica dei tempi più antichi.
Infatti tra il 112-113 d.C., quando non era ancora salito al trono, era stato nominato arconte della città, funzione invero anacronistica in un’epoca di assoluta dominazione romana, ma carica di suggestione, poiché in questo modo il potente generale di origine iberica si collocava sulla scia di personaggi del calibro di Dracone, Solone o Clistene.

Siamo davanti a un argomento molto vasto e molto studiato, che negli ultimi anni è stato oggetto di alcune mostre – ad esempio Adriano e la Grecia. Villa Adriana tra classicità ed ellenismo (Tivoli, Villa Adriana 2014) e Adriano e Atene (Atene, Museo Archeologico Nazionale, 2017-2020) – e di un’esaustiva monografia di taglio storico-archeologico, e cioè A. Carandini, E. Papi, Adriano. Roma e Atene, Utet, Torino 2019.
Ed è soprattutto la possibilità di consultare quest’ultimo, fondamentale, libro che rende superflua una mia trattazione diffusa, che peraltro necessiterebbe di spazi inadeguati a questa sede nonché di competenze assai superiori alla mia: pertanto mi accontenterò, come vedrete, di ragionare intorno a una statua.
Le Memorie di un principe filelleno
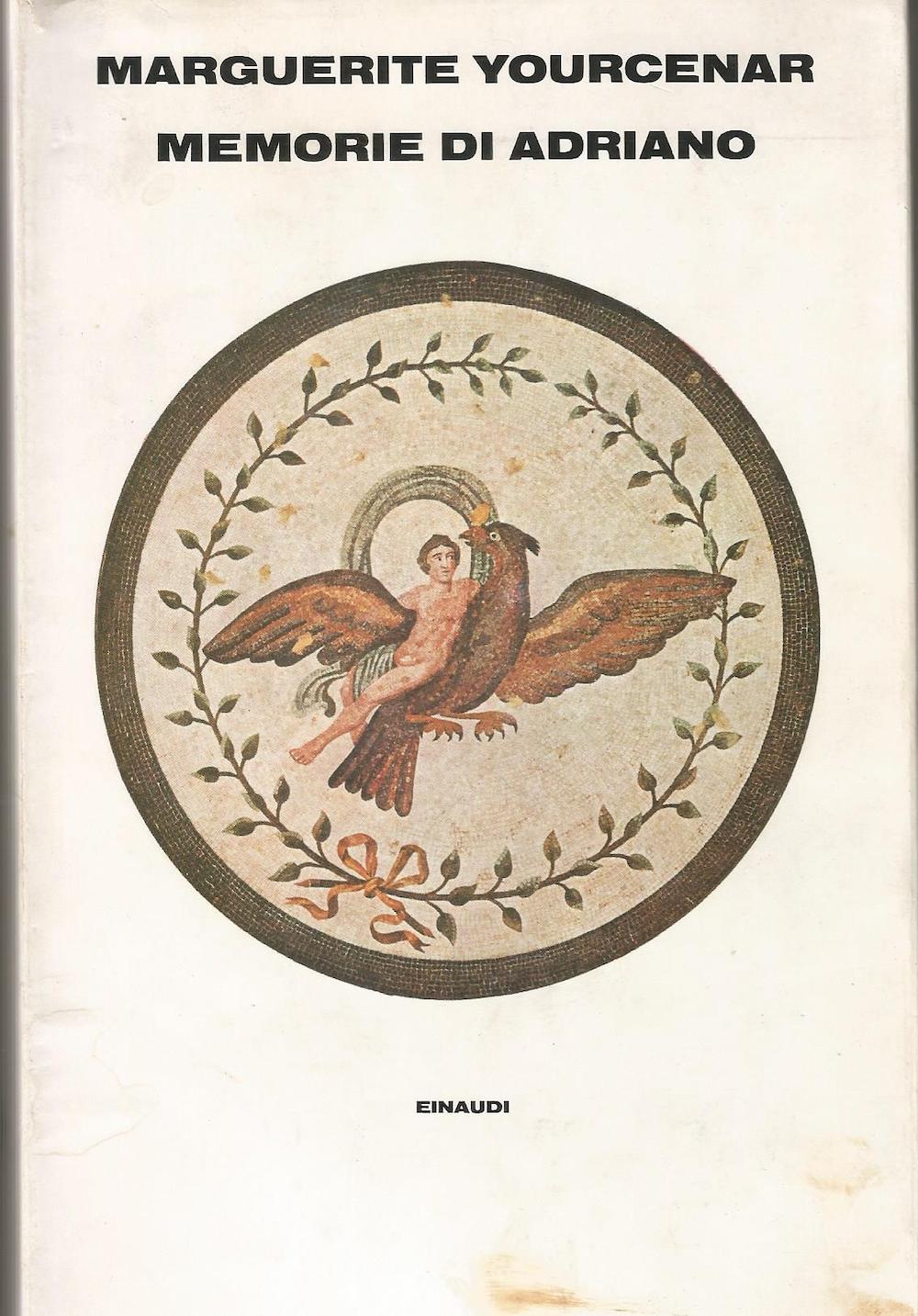 Intendiamoci, Adriano fu davvero un imperatore filelleno, grande viaggiatore, che nella sua Villa Adriana di Tivoli volle ricostruire le meraviglie di quel mondo che aveva visitato e aveva retto con mano ferma, custode di quegli sconfinati confini territoriali (scusate il gioco di parole) che Traiano gli aveva affidato in eredità.
Intendiamoci, Adriano fu davvero un imperatore filelleno, grande viaggiatore, che nella sua Villa Adriana di Tivoli volle ricostruire le meraviglie di quel mondo che aveva visitato e aveva retto con mano ferma, custode di quegli sconfinati confini territoriali (scusate il gioco di parole) che Traiano gli aveva affidato in eredità.
Un mondo che nella straordinaria fiction romanzesca delle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar (trad. it. L. Storoni Mazzolani, Einaudi, Torino 1981, edizione da cui infra farò passim alcune citazioni) il princeps ormai invecchiato ricorda con struggente malinconia: e forse l’oggetto di maggiore nostalgia, oltre alla memoria dell’amato Antinoo strappatogli dalle acque del Nilo e che egli divinizzò omologandolo a Osiride, è proprio il ricordo delle permanenze ad Atene, città che nel libro è menzionata ben quaranta volte.
La città di Teseo, la città di Romolo
L’Adriano immaginato, al pari di quello storico, si vanta dei suoi interventi edilizi nella città, che dovettero raggiungere il loro apice nel 131-132 d.C. quando venne inaugurato il tempio di Zeus Olimpio (Olympieion), il cui “cantiere” era stato aperto – e tale era rimasto per secoli – addirittura in età pisistratea (VI sec. a.C.).

Contestualmente l’imperatore edificò una nuova porta dalla città il cui arco sul lato rivolto verso l’acropoli recava incisa l’epigrafe «Questa è la città di Teseo», mentre su quello rivolto al tempio si poteva leggere «Questa è la città di Adriano» (Inscriptiones Grecae², 5185). Ed ecco quanto troviamo a questo proposito nel capolavoro di Marguerite Yourcenar:
Osai metter mano a quella bellezza, tentai di rendere perfetta quella città ammirevole. Dopo una lunga decadenza, Atene si ripopolava nuovamente, e ricominciava a crescere dopo un lungo periodo di declino: ne raddoppiai l’estensione; mi prefiguravo un’Atene rinnovata, lungo l’Ilisso, la città di Adriano al fianco di quella di Teseo. Tutto era da riordinare, da ricostruire. Sei secoli innanzi era stato abbandonato, appena iniziato, il grande tempio consacrato a Giove Olimpico. I miei operai si misero al lavoro: Atene conobbe di nuovo l’attività gioiosa che non aveva assaporata più dai tempi di Pericle (p. 150).
Pur consapevole dell’importanza del suo ruolo e del filo rosso che lo lega a ritroso a Teseo e a Pericle, l’Adriano letterario alterna però al legittimo orgoglio di avere portato al massimo grado possibile la fusione tra la civiltà greca e quella romana («le nozze di Atene e Roma erano consumate», p. 166) il timore che tutto ciò possa non durare per sempre («Mi dicevo che è vano sperare, per Atene e per Roma, quell’eternità che non è accordata né agli uomini né alle cose, e che i più saggi tra noi negano persino agli déi», p. 227) nonché un umanissimo, personale, senso di spaesamento, ben spiegato da queste parole:
Conviene che io faccia qui una confessione che non ho fatto a nessuno: non ho mai avuto la sensazione di appartenere completamente a nessun luogo, neppure alla mia dilettissima Atene, neppure a Roma. Straniero dappertutto, non mi sentivo particolarmente isolato in nessun luogo. Cammin facendo, esercitavo le diverse professioni di cui si compone il mestiere di imperatore: indossavo la vita militare come un vestito che è diventato comodo a furia d’esser portato (p.118).
Il vestito dell’imperatore nell’Agorà romana

Io non so se il vero Adriano fosse davvero così meditabondo, anche se la sua nota apostrofe alla Animula vagula blandula sembrerebbe confermarlo; comunque sia, trovo molto interessante quest’ultimo passo, che contiene alcune affermazioni che definiscono perfettamente la sua personalità, dall’amore per Atene, alla devozione per Roma, alla necessità di concepire il potere come un «mestiere», al fatto di sentirsi «straniero dappertutto» pur senza essere «particolarmente isolato in nessun luogo»: possiamo tradurre tutto ciò in una sorta di obbligo morale – per chi è in quel momento signore del mondo – all’ecumenismo e alla tolleranza, nella consapevolezza che talora è però necessario usare la forza, se è vero che si deve «indossare la vita militare come un vestito».
Questa metafora del «vestito» mi è tornata alla mente in una recente visita all’Agorà romana di Atene, area che il Nostro ristrutturò e trasformò in una sorta di museo all’aperto – con monumenti e statue di vario genere – e completò facendo edificare a nord di essa una splendida biblioteca, ancora oggi ben visibile.

Nel perimetro della grande distesa si trova anche un misterioso edificio, detto “Torre dei venti” – probabilmente un ingegnoso orologio-planetario – che chi scrive ama moltissimo: è incerto se sia di epoca precedente oppure di età adrianea, ma quel che è certo che al nostro raffinato imperatore non poteva affatto dispiacere, data l’eleganza delle sue decorazioni.
Ma c’è c’entra proprio il vestito? C’entra perché nel Museo dell’Agorà si può ammirare una statua acefala dell’imperatore, che doveva ornare l’area della piazza insieme a quelle di vari eroi eponimi delle tribù ateniesi e di altre “glorie locali”: essa ci mostra benissimo il «vestito» con il quale Adriano voleva mostrarsi in Attica.
Civetta, serpente, lupa e altri simboli
Anzitutto il princeps indossa un paludamentum, cioè il mantello dei generali romani, il che non stupisce per chi si fregiava del titolo permanente di imperator (cioè «comandante vittorioso»); stupefacente è però la decorazione di quella veste, carica come nessun’altra di valenze ideologiche.
Al centro infatti campeggia Atena, dea protettrice della città, affiancata da due animali dal forte significato simbolico: a destra vi è la civetta, uccello sacro alla dea, e – per certi versi – sua stessa manifestazione zoomorfa, mentre a sinistra c’è un serpente, essere nel quale era stato trasformato Erittonio, uno dei mitici re di Atene.
Ma l’omaggio alla storia mitica di Atene non può non essere accompagnato anche da un robusto riferimento alla realtà politica presente, poiché Atena si poggia sulla lupa che allatta i gemelli, emblema del potere romano, e la scena è chiusa ai lati da due Vittorie alate.

A nessuno, dunque poteva sfuggire il messaggio di questa fantasiosa e composita iconografia, e cioè da un lato la duplice (o forse anche plurima, come si è visto) identità culturale dell’imperatore, dall’altro la necessità storica della fusione tra le due civiltà, quella della polis che aveva inventato la democrazia e quella dell’Urbs che gli dèi avevano destinato a governare l’ecumene. Siamo dunque molto oltre il concetto oraziano di Graecia capta ferum victorem cepit (Epistole, 2, 1, 56) o l’interesse collezionistico per l’arte greca della classe dirigente romana del I secolo a.C. Qui sembrano non esserci più vinti o vincitori, ma popoli che contribuivano insieme al progresso umano, come in questi stessi anni affermava il greco Plutarco nelle sue Vite parallele: non esisteva infatti un “migliore” – solo per fare qualche esempio – tra Teseo o Romolo, Pericle e Fabio Massimo, Alessandro Magno o Giulio Cesare, ma la civetta da un lato e la lupa dall’altro li ispiravano sempre «a egregie cose», per dirla con Foscolo.
L’aquila delle legioni, l’uccello di Giove
Non voglio apparire ingenuo, né posso esserlo dopo tanti anni di studi di Storia romana. Ribadisco pertanto che Adriano non era un pacifista, un intellettuale da salotto che – come qualche volta erroneamente si è detto – manifestava la sua forza solo nei viaggi, nella caccia e in qualche altro hobby di lusso: ce lo dicono le sue campagne militari, il suo Vallum in Britannia, la durezza con cui represse la rivolta giudaica, ma ce lo dice pure la voglia di essere ritratto anche qui ad Atene col mantello militare con tanto di Vittorie alate come ornamento. Ma per lui la guerra era lo strumento per difendere quel mondo eterogeneo, inclusivo, multilinguistico e multiculturale che egli aveva contribuito a creare e che poteva a suo avviso resistere solo se protetto dalle armi di Roma, dalle aquile delle sue legioni. L’esercito diventava allora, in poche parole, un mezzo al servizio di quella humanitas senza la quale era impossibile garantire quella felicitas (individuale e collettiva) che tante volte aveva voluto rappresentare allegoricamente sulle monete da lui emesse.
A proposito di aquile… Qualcuno potrebbe obiettare che non ho finora menzionato, in relazione alla statua analizzata, alcune figure che ornano la bordura inferiore del mantello: volti giovanili ai lati, un satiro al centro (forse con funzione apotropaica), elmi e aquile. Non credo che ci siano dubbi sulle allusioni militari di queste ultime icone, anche se, guardandole, non ho potuto ancora una volta non pensare alle Memorie, e in particolare all’immagine finale dell’imperatore che – a Baia, nella Campania felix – si sta avvicinando alla morte con queste parole:
Tutto è pronto: l’aquila incaricata di recare agli dèi l’anima dell’imperatore è tenuta in riserva per la cerimonia funebre; il mio mausoleo, sulla sommità del quale vengono piantati in questo momento i cipressi destinati a formare contro il cielo una piramide nera, sarà terminato pressappoco in tempo per deporvi le mie ceneri ancor tiepide (p. 275).
Infatti se per tutti i romani “comuni mortali” l’aquila era l’emblema delle legioni, per il princeps era anche l’uccello – sacro a Giove – che ne avrebbe portato l’anima in cielo per l’apoteosi, proprio come era capitato poco tempo prima alla moglie Vibia Sabina. Sì, proprio l’aquila, il rapace che il Giove romano aveva preso in prestito da quello Zeus Olimpio cui Adriano aveva consacrato ad Atene uno dei più grandi templi del mondo antico; ma tra un po’ lui e il padre degli dèi sarebbero diventati “colleghi”, e anche a lui – Divus Hadrianus – avrebbero dedicato qualche tempio, come quello eretto poi a Roma nel Campo Marzio…

Insomma: la lupa, la civetta, il serpente e l’aquila possono benissimo rappresentare una sintesi completa della personalità del nostro imperatore a dimostrazione che l’uso politico del «potere delle immagini» che l’archeologo Paul Zanker aveva attribuito a Ottaviano Augusto (in Augusto e il potere delle immagini, Einaudi, Torino 1989) era stato continuato e perfino ulteriormente raffinato dai suoi successori. Nel caso analizzato, però, con una sostanziale differenza rispetto al modello: se di Augusto circolavano soprattutto le statue e l’imperatore soggiornava prevalentemente a Roma, Adriano si muoveva nel grande “villaggio globale” dell’impero insieme con le sue immagini – e riprendendo la frase di Yourcenar – ne indossava davanti ai propri sudditi le stesse vesti. Egli sapeva infatti, al pari del suo alter ego romanzesco, che «siamo ingombri di statue», (p. 124), e che senza la parallela presenza fisica, umana (ecco che ritorna l’humanitas…) a garantirne l’autenticità quelle del princeps avrebbero rischiato di perdere molto del loro già citato «potere»; ma ciò – come abbiamo visto – almeno ad Atene non doveva e non poteva certo avvenire.

