Mattina di luglio, il sole già alto: la brezza marina regala sollievo al fuoco di Caronte mentre Fatima si inginocchia sulla sabbia e distende una mercanzia composta da ventagli colorati, bracciali, elastici e pinze per capelli. Un tripudio di teli a motivi geometrici le nasconde una pancia da gestante: tra due mesi al massimo partorirà il suo bambino. Dopo poco arriva Sara, con una sporta di libri e un italiano preciso; a Verona frequenta un liceo delle scienze umane, i soldi guadagnati d’estate aiutano gli studi. Ma non è che siamo poveri, tiene a dire, intuendo il pensiero di chi la guarda e ha figli o nipoti stesi sul lettino oppure all’estero per migliorare l’inglese. Sara non ci sta a farsi chiudere in un cliché, si vede che ha gusto nello sparigliare le carte. Però (immagino sia esperienza di chiunque in questi incontri vacanzieri) è difficile non pensare che, se per tutti è la stessa variazione di azzurro del mare, la donna che porta faticosamente il peso di due persone e quella che sulla sabbia rovente foraggia i suoi studi provano che il sole non brucia per tutti allo stesso modo.
Non vorrei che si leggesse in questo esordio un intento moralista: è che questa che abito quasi ogni estate è la terra di mio padre, una terra contadina, rossa e riarsa, un mondo per secoli uguale a sé stesso e, per quel che mi interessa dire oggi, abitato da donne lungamente dannate dalla fatica, dalla povertà e dall’isolamento.
Questa parte d’Italia che amo tanto, di cui potrei scrivere e parlare per ore, che fu messapica e quasi greca, e poi romana, bizantina e normanna, che quindi unì la sua storia a quella di tutto il meridione d’Italia, questo estremo lembo della penisola tuttora pieno di contraddizioni è anche la terra del morso della taranta, fenomeno che portò l’antropologo Ernesto De Martino ad affermare che «della follia non si può fare storia», perché il concetto stesso di follia è “caduta dalla storia”, ossia frattura tra la coscienza soggettiva e il suo mondo. Ma in Salento, come in tutti i luoghi in cui restano tracce di culture arcaiche, si può provare a capire in che misura la follia può essere anche cura.
Dunque parlerò di tarantate e di Santa Caterina d’Alessandria per offrire qualche sfumatura in più a chi, pensando al Salento, si immagina soltanto musica, mare e, proverbialmente, vento.
Galatina: San Paolo, lo sputo guaritore e il rito delle tarantate
L’antica San Pietro in Galatina, 20 km a sud di Lecce, equidistante dai due mari che diedero il nome all’antico popolo dei Messapi, è oggi una città di 27.000 abitanti (ISTAT 2017). Il riferimento greco al latte racconta la dedizione all’allevamento e al commercio del bestiame, ma anche la pervasività della lingua greca nel dialetto locale, che in Salento si deve più al magistero dei monaci basiliani medievali che ai residui magnogreci collegati alla vicina Taranto. Nel XV secolo la cittadina divenne capitale di un vasto ducato, sotto la casata Orsini Del Balzo, cui si deve la splendida Basilica di Santa Caterina, su cui torneremo tra poco.
A Galatina, il 29 giugno, in occasione della festa di San Paolo, nello spazio adiacente alla piccola cappella a lui dedicata, a due passi dalla centralissima Piazza San Pietro, per secoli ebbe luogo un rito di esorcismo e guarigione collettiva frequentato dalle cosiddette tarantate, o tarantolate (il femminile si giustifica col fatto che fossero per lo più donne), colpite dai presunti effetti del morso della taranta. La credulità popolare associava infatti il morbo (la crisi psichica) all’aracnidismo provocato dal veleno di ragni e serpenti di campagna e riconduceva a San Paolo, defensor civitatis, il dono dello sputo guaritore, offerto dal santo stesso alla discendenza di un uomo che proprio a Galatina lo avrebbe ospitato e protetto dai persecutori.
Al di là della leggenda, l’associazione è pertinente: nel racconto biblico, infatti, San Paolo, predicatore in Giudea, placa l’assalto spaventoso di bisce e serpenti con il segno della croce.
L’ultimo membro della famiglia omaggiata dallo sputo taumaturgico, Polisena Farina, non aveva discendenza, e così, si dice, prima di morire nel 1706 sputò dentro al pozzo di acqua sorgiva che vi era nel palazzo, perpetuando il miracolo: da quel momento, stante il De tarantulae anatome et morsu opusculum del medico Nicola Caputi (Lecce 1941), il potere taumaturgico sarebbe passato all’acqua del pozzo, aprendo la via a una tradizione rituale collettiva che, fino agli anni Sessanta del secolo scorso, richiamava migliaia di persone da tutte le campagne. La pratica si estinse spontaneamente negli anni del boom economico, quando molti salentini migrarono nelle città del Nord Italia, in Belgio o in Svizzera e, al loro ritorno in estate, non erano più disponibili a prestar fede a quelle che ormai sembravano loro vecchie superstizioni, verso cui provavano anche una sottile di vergogna.
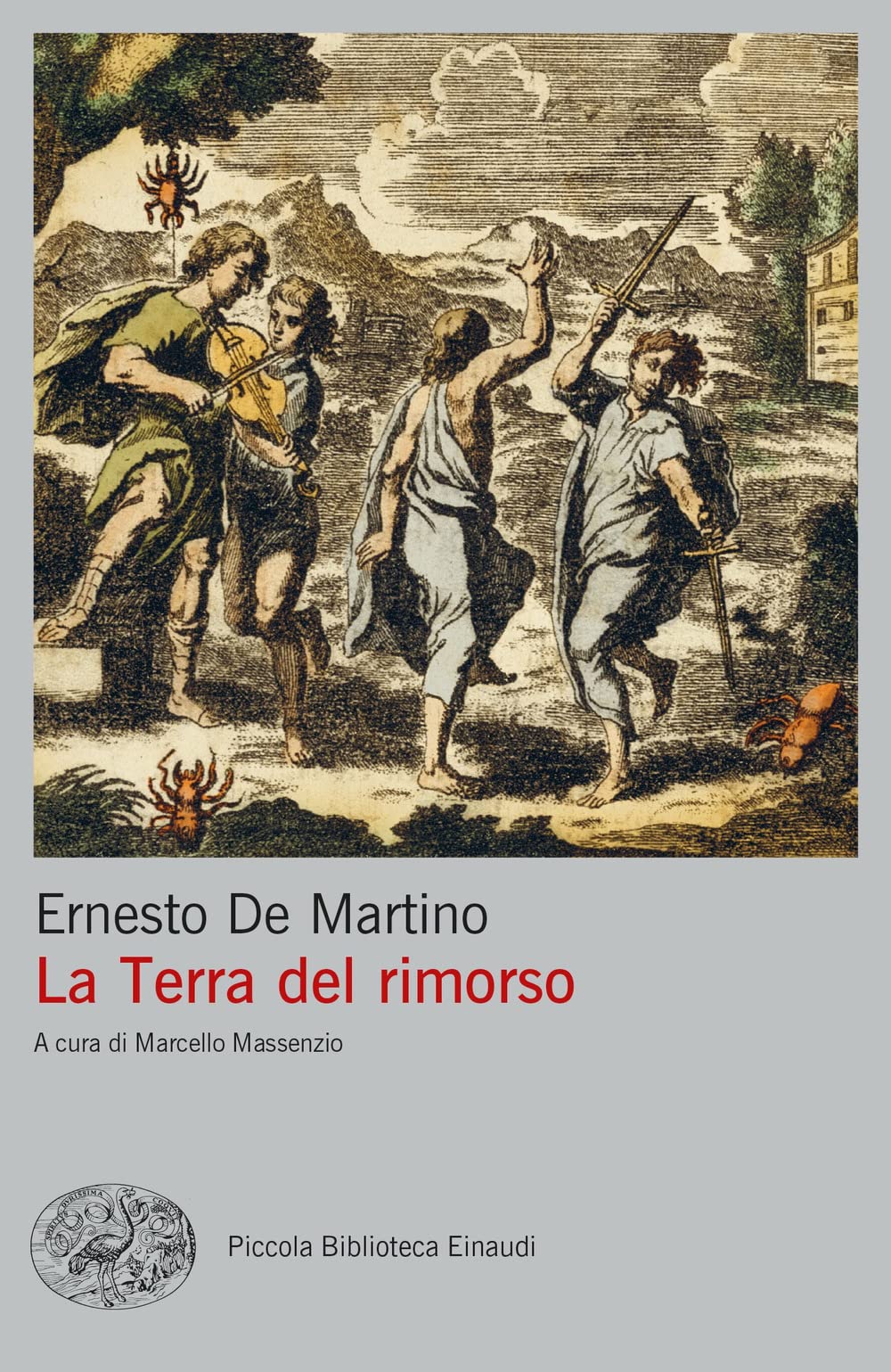 Il culto era però ancora vivo nel 1959, quando l’antropologo Ernesto De Martino (uno dei padri dell’etnologia italiana) organizzò proprio a Galatina, Nardò e Muro Leccese una spedizione di ricerca etno-antropologica multidisciplinare sul campo; vi parteciparono lo psichiatra Giovanni Jervis, la psicologa Letizia Jervis-Comba, l’etnomusicologo Diego Carpitella, l’antropologa Amalia Signorelli e il fotografo Franco Pinna, a cui si deve la prima documentazione iconografica. Sono gli anni in cui Elio Vittorini riserva grande attenzione alla questione del meridione, che è anche al centro dell’attività documentaristica di Cesare Zavattini. La spedizione di ricerca confluì in un’opera tuttora fondamentale per gli studi etno-antropologici: La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud (Il Saggiatore, Milano 1961).
Il culto era però ancora vivo nel 1959, quando l’antropologo Ernesto De Martino (uno dei padri dell’etnologia italiana) organizzò proprio a Galatina, Nardò e Muro Leccese una spedizione di ricerca etno-antropologica multidisciplinare sul campo; vi parteciparono lo psichiatra Giovanni Jervis, la psicologa Letizia Jervis-Comba, l’etnomusicologo Diego Carpitella, l’antropologa Amalia Signorelli e il fotografo Franco Pinna, a cui si deve la prima documentazione iconografica. Sono gli anni in cui Elio Vittorini riserva grande attenzione alla questione del meridione, che è anche al centro dell’attività documentaristica di Cesare Zavattini. La spedizione di ricerca confluì in un’opera tuttora fondamentale per gli studi etno-antropologici: La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud (Il Saggiatore, Milano 1961).
La cappella di San Paolo oggi non è più visitabile, ma restano appunto la documentazione fotografica di Franco Penna e poi quella di Annabella Rossi (Lettere da un tarantata, 1970, oggi edito da Squilibri editore, 2015) e, soprattutto, il prezioso documentario girato nel 1962 dal giovane regista Gianfranco Mingozzi, con voce e commenti di Salvatore Quasimodo (La Taranta, libro con DVD, Kurumuny Edizioni 2009). Il lavoro di De Martino, e in particolare il caso di Maria di Nardò, ispirarono anche il film Pizzicata, del regista anglo-salentino Edoardo Winspeare (1994, qui in streaming nella versione completa).
Il rito annuale di Galatina rivela il carattere parareligioso del tarantismo; la distanza tra la celebrazione annuale e i presunti morsi del ragno (nell’immediato curati con pratiche coreutico-musicali guidate da suonatori popolari) manifesta bene la portata simbolica del fenomeno: il negativo legato all’animale avvelenatore veniva ricondotto entro un orizzonte di senso in cui si incontravano il basso e l’alto, la superstizione contadina e un cattolicesimo meridionale non del tutto chiuso rispetto alle tradizioni pagane arcaiche. La malattia diventava così strumento di reintegrazione, che disciplinava la crisi, le assegnava luoghi, tempi e modi determinati e si sforzava di ricomporre un nuovo equilibrio.
Non è questa la sede per condensare in poche righe un tema a cui il solo De Martino ha dedicato quattrocento pagine. Però ricaviamo dalla sua ricerca antropologica l’interpretazione della crisi psichica come “crisi della presenza”, vale a dire come interruzione della capacità di reagire a situazioni traumatiche in grazia delle memorie e dell’esperienza. Per effetto di un trauma, non infrequente in una società povera e contadina, la coscienza delle tarantate manifestava nel sintomo la frattura tra le stesse e la dimensione sociale e collettiva in cui erano collocate (ciò che per De Martino è la “storia”). Dunque il rito folclorico, sia esso la danza al ritmo dei tamburelli o l’acqua medicale del pozzo (entrambe soltanto credenze popolari in una prospettiva razionalista), può essere letto come una via attraverso cui si cercava di superare la perdita del legame identitario tra la tarantata e il suo mondo.
In una lettura socio-economica, le tarantate sono l’ultimo anello di una catena patriarcale nella quale la gerarchia del potere afferma con violenza il primato dei padroni sulle masse dei diseredati, del padre sul figlio, sulla figlia e su ogni membro della famiglia, dell’uomo sulla donna. Impedite nell’espressione della propria vitalità e del proprio desiderio, maritate e dunque sottoposte a uomini che non amavano, oppure non maritate e quindi non madri, ma in un tempo e un luogo in cui la maternità legittimava l’esistenza, e spesso anche abusate nel silenzio generale, alcune donne manifestavano attraverso il corpo la dissociazione dal comunitario orizzonte di senso (così Clara Gallini nella presentazione a La terra del rimorso, 2009, p. 17): un sottrarsi inconsapevolmente ribelle, se vogliamo, che esigeva un’azione di guarigione. E in effetti, nel concreto, proprio quando la crisi psichica si traduceva in sintomo, la comunità rispondeva con una cura e un’attenzione generalmente non concessa a chi era spinto ai margini della società.
 Ho pensato a queste esistenze così comuni nel mondo contadino quando ho letto la storia di Lucia, madre suicida di Maria Grazia Calandrone, che a lei ha dedicato il romanzo inchiesta Dove non mi hai portata (Einaudi, Milano 2023).
Ho pensato a queste esistenze così comuni nel mondo contadino quando ho letto la storia di Lucia, madre suicida di Maria Grazia Calandrone, che a lei ha dedicato il romanzo inchiesta Dove non mi hai portata (Einaudi, Milano 2023).
Quali che fossero le radici del male che coglieva le tarantate salentine, l’insistenza rituale sulla musica e sul ballo (non solo salentina e non solo mediterranea) interroga circa il rapporto tra psiche e soma (il modo in cui l’una influenza l’altro) e costringe a guardare la dimensione collettiva della guarigione, mentre pone l’accento sulla complessa dinamica che lega l’individuo/a al suo gruppo.
Lo spazio in cui il rito avviene sovverte la geografia dei rapporti: chi occupava la periferia si trova improvvisamente (finalmente?) al centro della scena. A Galatina, a Nardò e a Muro Leccese, le reiette della storia, come Maria, trovarono transitoriamente una centralità che non può non stimolare reminiscenze del mondo antico: i culti di Demetra e di Dioniso, le tradizioni misteriche che, per una via altra, assegnarono spesso proprio alle donne un ruolo che la società negava loro sul piano politico.
Galatina e Santa Caterina d’Alessandria (Ipazia nell’ombra)
Se il fenomeno del tarantismo regala a chi visita Galatina una possibilità di riflessione sulla presenza delle donne nella storia, le pietre della città sembrano offrire alla riflessione una sorta di controcanto. Il coro pittorico (mi si perdoni la sinestesia un po’ barocca) è negli affreschi della basilica dedicata a Santa Caterina di Alessandria, figura agiografica che trova non poche attestazioni votive in tutta Italia e che in Salento forse si lega anche alla presenza dei monaci basiliani di rito orientale.
La storia della basilica è, come accade sovente, complessa, ma in estrema sintesi si può si può datare tra XIV e XV secolo l’estensione di un edificio preesistente, probabilmente bizantino, realizzata su commissione degli Orsini del Balzo. La leggenda vuole che il committente fosse Raimondello, crociato, di ritorno dal santuario del Monte Sinai in cui si conservava il corpo della santa: pare che baciandole la mano ne avesse sottratto con i denti un dito, oggi conservato all’interno di un reliquario d’argento. Raimondello morì nel 1405 e la decorazione della basilica si deve alla moglie, Maria d’Enghien, regina di Napoli e contessa di Lecce.
Il pregio maggiore del luogo è sicuramente la decorazione pittorica dell’interno, realizzata in parte da maestranze locali, in parte da artisti che la contessa fece arrivare da varie zone della penisola, in particolare pittori di scuola giottesca e senese. La vastità dei cicli pittorici, tra cui quello appunto dedicato a Santa Caterina, richiama alla memoria del visitatore il felice stordimento che si prova visitando la basilica di San Francesco d’Assisi.

Ma veniamo a Santa Caterina: il suo culto, si diceva, è diffuso in ambito ortodosso e cattolico e sembra evidenziare proprio i collegamenti tra le due chiese. Tra le attestazioni in Salento mi piace ricordare, anche per ragioni affettive, la molto meno nota chiesetta di Santa Maria della Croce a Casarano, anche detta Casaranello, prezioso scrigno di mosaici bizantini nel catino absidale e appunto di affreschi dedicati alla santa nella navata centrale.
Secondo la vulgata, Caterina era una giovane nobildonna cristiana, colta e bellissima, vissuta in Alessandria d’Egitto. La martirizzazione sarebbe avvenuta all’inizio del IV secolo e con certezza si può dire che la santa è protagonista di una Passio greca molto più tarda, ma è la Legenda aurea del domenicano Jacopo da Varazze che permette l’accesso alla formulazione della storia in area latina: convertita al cristianesimo dopo la morte del padre, mentre in Alessandria imperversavano persecuzioni contro i Cristiani, Caterina fu notata dall’imperatore che, soggiogato dalla sua bellezza non meno che dalla sua eloquenza, incaricò alcuni valenti filosofi di convincerla a rinnegare il Dio cristiano per tornare al culto pagano. Con sua sorpresa, furono però i filosofi ad essere convertiti dalle parole infervorate della santa e l’imperatore li condannò al rogo. Caterina rifiutò dal sovrano la salvezza che avrebbe avuto se si fosse concessa a lui e questi allora la condannò alla tortura della duplice ruota dentata, suo simbolo iconografico, che però fu spezzata dalla spada di un angelo. La pena definitiva fu dunque la decapitazione, che la santa avrebbe potuto anche evitare se non avesse domandato essa stessa al suo Signore la morte, a patto che il suo corpo non fosse smembrato in reliquie e che le fosse concesso esaudire le preghiere di chi l’avesse interpellata. Dalla ferita della decapitazione sgorgò latte anziché sangue e gli angeli portarono il corpo della martire sul Monte Sinai, dove è appunto il santuario a lei dedicato[1].

Le vittoriose dispute culturali e religiose (la leggenda vuole che a convertirsi fosse anche l’imperatrice) hanno fatto di Santa Caterina una patrona degli Studi Universitari: la troviamo, spesso con la ruota del martirio, nel sigillo delle Università, così a Padova e Siena, e, a Parigi, dal XIII secolo teologi e filosofi le dedicavano una processione fino alla chiesa di Sainte-Catherine-de-la-Coulture. Questa versione devozionale, che si affianca a quella oggi meno suggestiva di patrona delle fanciulle in età da marito, è anche all’origine di un dibattuto accostamento tra Caterina e Ipazia d’Alessandria, la martire pagana che pagò la mancata conversione cristiana con la vita e con la distruzione della celebre biblioteca, in cui esercitava il suo magistero di matematica, astronoma e filosofa all’epoca dei decreti teodosiani. In un recente contributo, Caterina / Ipazia, la santa fantasma (in “La rivista di engramma, Testo con figura”, 192, giugno 2022, pp. 99-102), Silvia Ronchey riconduce la prima associazione tra le due donne ad Anna Jameson, scrittrice irlandese, storica protofemminista e pioniera dei Female Studies. Per Ronchey funziona il riconoscimento della figura di santa martire pagana che si cela dietro la megalomartire cristiana e Jamenson sarebbe geniale «nell’esplicitare con chiarezza che la storia del personaggio e del martirio e anche del culto di Caterina erano fin dall’inizio una trasposizione e un reimpiego di quelli, evidentemente preesistenti e probabilmente ben presenti alla memoria collettiva e devozionale egiziana, del culto di Ipazia». Alla santa cristiana sarebbero dunque stati prestati i tratti della santa laica, massacrata non dall’imperatore romano, «ma dal ‘faraone’ del monofisismo egizio, il vescovo Cirillo». Caterina d’Alessandria sarebbe dunque per Ronchey «una Santa fantasma: non tanto per la sua inesistenza storica – poiché storicamente esistette anche se con altro nome e fu martire anche se in un’altra epoca e di un altro, antitetico potere – quanto per la sua natura di phantasma, nel senso che questa parola ha nella lingua greca. Il manifestarsi di un rimosso, un simulacro della phantasia che vive nell’iconografia».
Tra Caterina d’Alessandria e Maria di Nardò

Torno allo stimolo iniziale delle due venditrici sulla spiaggia, Fatima e Sara. Le loro figure reali dialogano nel mio immaginario con le donne raccontate e dipinte che possiamo incontrare a Galatina e certo anche con la donna che io posso essere oggi e che non poterono essere le mie antenate salentine (e neppure quelle friulane). Mi pare perciò utile lasciarsi interpellare dalla storia della tarantata Maria di Nardò (che non poté esprimere la sua vitalità in un tempo e un luogo troppo angusti), non meno che da quella di Caterina e forse Ipazia (la cui sapienza e parola furono ridotte al silenzio). Nel nostro mondo interiore, io credo, Maria e Caterina esistono tutt’ora e dialogano con le persone che incontriamo nel mondo reale. Il riconoscimento che queste figure fantasmatiche chiedono è un pensiero spirituale, e l’empatia (parola abusata ma precisa) è proprio questo riconoscimento, da cui può discendere il gesto politico di assegnare anche Fatima e Sara, donne del nostro tempo, ciò che è o sarebbe necessario, secondo il bisogno e secondo il merito, affinché la loro strada non sia più la terra arsa su cui hanno camminato le nostre nonne. Si può?
Note
[1] Sulla “megalomartire”, protettrice degli studi, rimando al saggio di Roberto Tollo, Santa Caterina d’Alessandria. Icona della Teosofia (Monografie storiche agostiniane, ns 10, Tolentino (MC) 2015, pp. 7-9), che misura in particolare gli effetti del culto a lei dedicato sulla letteratura e sull’arte tanto in Oriente, quanto in Occidente (da Giotto, a Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti, da Masolino a Caravaggio, da Van Dyck ad Artemisia Gentileschi che si ritrasse nelle vesti della santa).
La vita di Santa Caterina è la numero 168 in Iacopo da Varazze, Legenda Aurea. Testo critico riveduto e commento a c. di G.P. Maggioni; Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo; Biblioteca Ambrosiana, Milano 2007; 2 voll.

