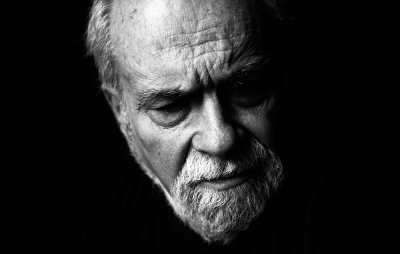
Il quesito imprescindibile per capire il lavoro di Danto è: “che cos’è l’arte?”. Si tratta probabilmente del tema più caldo del dibattito in filosofia dell’arte degli ultimi decenni, anche grazie a Danto. Egli identificò due condizioni necessarie per poter definire un oggetto opera d’arte: il fatto di riguardare qualcosa (aboutness) e il fatto di incarnarne il significato. Si tratta di un approccio debole, rispetto a tesi più forti che legano l’arte al bello o al vero, eppure sufficienti a fare di Danto un essenzialista in filosofia dell’arte.
Danto è noto per aver parlato, nel 1984, di “fine dell’arte”. Ecco come egli stesso spiega l’espressione sulla fine dell’arte: «La mia idea era che non ci fosse più una direzione prestabilita in cui l’arte dovesse procedere, non c’era risposta alla domanda dei giornalisti: “Dove sta andando l’arte?”» (Dopo la fine dell’arte, p. XIII). Non c’era più risposta perché, appunto, l’arte era finita. Non bastava esibire, per dargli torto, il fatto che il mercato dell’arte era fiorente, bisognava piuttosto mostrare che l’arte non aveva già detto tutto ciò che c’era da dire sull’arte stessa. Non che, esaurito questo compito, non ci fosse altro da fare: era possibile scegliere lo stile espressivo che si preferiva, magari sperimentare contaminazioni e varianti. In ogni caso, secondo Danto, non poteva più succedere ciò che invece era successo dopo Hegel e l’estetica moderna, cioè che artisti come Andy Warhol, con le sue Brillo Box, mettessero in radicale discussione i canoni tradizionali.
Memorabile la sua intuizione secondo cui: “Vedere qualcosa come arte richiede qualcosa che l’occhio non può cogliere – un’atmosfera di teoria artistica, una conoscenza della storia dell’arte: un mondo dell’arte” (in F. Bollino, Il mondo dell’arte, in “Studi di estetica”, 27 (2007), p. 79). Si tratta di un monito mirabile che, in filosofia dell’arte, ha aperto nuove prospettive, dato che il riferimento al bello e al piacevole non bastava più a dare conto dell’arte. Tale intuizione è però un richiamo prezioso anche per le ricerche di ontologia sociale, in quanto salva dalla tentazione di pretendere di risolvere le questioni filosofiche facendo appello alle cose.


