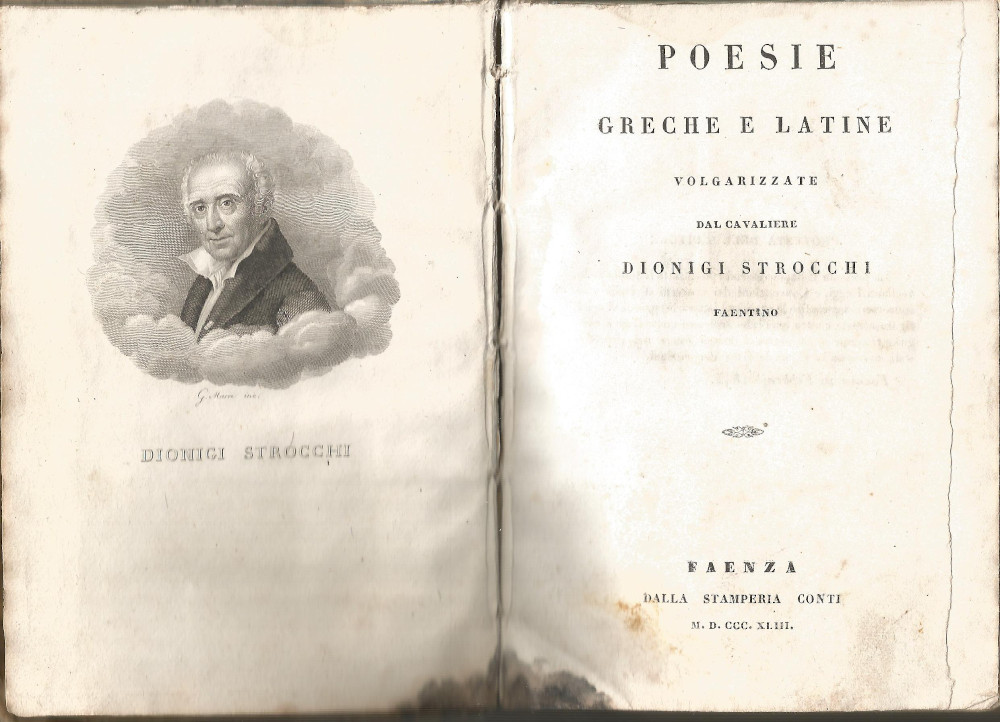
Dionigi Strocchi, chi era costui? Come fossi un novello don Abbondio che si arrovella su Carneade, inizio questa mia riflessione con una professione di ignoranza e… superficialità. Avrei dovuto saperne di più, di tale personaggio: lo dimostra il fatto che alcuni saggi, da me letti in passato, lo menzionano in qualche pagina o nota (ho fatto un controllo negli indici). Ma, francamente, non me lo ricordavo. Così, quando qualche tempo fa Manuela – un’amica, vicina di casa, bravissima restauratrice di mobili – ha donato a mia moglie e a me (in quanto “vecchi professori” di lingue classiche) un libretto ritirato in casa di una cliente, ne ho apprezzato il titolo e l’epoca (Poesie greche e latine volgarizzate dal cavalier Dionigi Strocchi, Faenza, dalla Stamperia Conti, 1843) ma non ho subito compreso l’importanza del suo autore.

Tra politica, educazione ed erudizione
È invece bastata una ricerca sul web (e poi sui predetti libri di casa…) per rivelarmi tutto il valore dello Strocchi, e per calare quel modesto (per dimensioni) volume in un contesto storico-culturale di prim’ordine[1]. È per questo che – al netto delle mie lacune, delle quali rifaccio ammenda – al “vecchio professore” è venuta voglia di condividere le proprie riflessioni con i suoi affezionati lettori. Infatti il Nostro (Faenza 1762 – Ravenna1850) fu uno straordinario figlio del suo tempo, quello dei due secoli «l’un contro l’altro armato» di manzoniana memoria.
Nonostante la formazione giuridica (svoltasi a Roma), egli dedicò la vita agli studi classici e all’educazione, giacché fu autore di numerose pubblicazioni, nonché professore di eloquenza nel neonato Liceo faentino (istituito nel 1803), del quale divenne anche rettore. Appassionato di politica, come molti intellettuali della sua generazione – a cominciare da Ugo Foscolo – si entusiasmò per il Bonaparte liberatore: ciò lo portò a ricoprire anche rilevanti cariche pubbliche municipali, ma gli costò, in tempi di Restaurazione, la necessità di atteggiamenti più “defilati”, dopo avere addirittura subito l’onta del carcere.
Seppe però farsi valere in ambito culturale sotto ogni regime, diventando socio delle più importanti accademie del tempo, dall’Arcadia alla Crusca; e prima di morire ebbe l’onore di essere nominato senatore (1848) dopo la composizione di un inno per l’ascesa al papato di Pio IX.
Se prima l’ho avvicinato all’entusiasmo del Foscolo, in questa parabola lo paragonerei invece a Vincenzo Monti (abate, cittadino, cavaliere…): tra l’altro con entrambi (soprattutto con Monti) lo Strocchi ebbe rapporti di non solo di conoscenza e corrispondenza, ma anche di consonanza, se è vero che come Monti e Foscolo egli non fu solo poeta, ma anche traduttore.

Tradurre e riflettere sulla traduzione
Sì, il libretto da cui siamo partiti contiene un inno omerico (A Venere), gli Inni di Callimaco (insieme con la Chioma di Berenice) – apprezzatissimi da Carducci – seguiti dalla traduzione integrale delle Bucoliche e Georgiche virgiliane. Ma contiene anche delle riflessioni teoriche sull’arte del tradurre, evidenti sia nel saggio iniziale Delle traduzioni, sia nelle premesse alla versione delle Bucoliche e delle Georgiche.
La prima cosa che mi ha impressionato, sfogliando (con cautela) il volume, è il fatto che tutte le traduzioni (tranne quella delle Georgiche, in endecasillabi sciolti) siano in terzine dantesche, segno visibile dai suoi interessi – anche critici – per la Divina Commedia. Insomma: Strocchi, proprio come Vincenzo Monti, nume tutelare di scuola di “classicisti romagnoli” cui egli apparteneva, sembra più preoccupato della qualità della lingua “di arrivo” della traduzione, piuttosto che della fedeltà al testo “di partenza”. Pertanto nel saggio Delle traduzioni (pp. I-XVI) difende a spada tratta la versione dell’Eneide di Annibal Caro (completata nel 1566) dalle accuse di infedeltà mosse da Francesco Algarotti e Clemente Bondi, secondo il quale il Caro avrebbe «in falso rendute alcune sentenze di Virgilio»: sta forse chiedendo implicitamente al lettore di usare con lui la stessa indulgenza?
Ancora più interessante è la premessa alla traduzione delle Georgiche dedicata Alla studiosa gioventù italiana (pp. 163-166), dove difende la scelta di usare gli endecasillabi sciolti (negando la definizione del Baretti «poltroneria d’versi»), più adatti della rima ad «adescare l’animo del giovane lettore a due sorgenti di gentilezza e di prosperità, le buone lettere e l’agricoltura» e farne dunque «l’ottimo dei cittadini». Ma, quasi fosse in colpa per avere tradito l’eredità dantesca, ricorda come le Georgiche siano una «scuola [ove] s’impara a discernere il vero carattere del poetico parlare. A questa scuola parmi che l’Alighieri apprendesse l’arte d’informare, di nudrire, di condire lo stile con la novità, con la venustà, con l’ardimento di metafore e tropi, che sono la vita e l’anima di ogni poesia, e massimamente della comica e didattica». Dante c’entra sempre, insomma, senza se e senza ma.

Foscolo, Monti e… Dante
Il tradurre, dunque, è qualcosa che per lo Strocchi si deve inserire a pieno titolo nella tradizione letteraria italiana, come pure nel contesto culturale e politico-sociale del momento.
D’altronde la traduzione (dalle lingue classiche, ma anche da quelle straniere: si pensi a quella, celeberrima, dell’Ossian di Melchiorre Cesarotti o al foscoliano Viaggio sentimentale dello Sterne) fu al centro del dibattito culturale del secondo Settecento e del primo Ottocento, come attestano anche le note accuse del Foscolo all’Iliade del Monti, il cui autore fu da lui definito con sarcasmo «gran traduttor dei traduttor d’Omero».
Sarà stato anche vero, mi vien da dire, ma per generazioni di studenti (compreso chi scrive, che ha frequentato le scuole medie all’inizio degli anni Settanta) il primissimo approccio con Omero è stata proprio la montiana «ira funesta del Pelide Achille», in quella protasi da imparare rigorosamente a memoria.

Torniamo dunque ancora a Foscolo e Monti, i quali – prima di bisticciare (non solo per ragioni letterarie…) – pubblicarono insieme nel 1807 un Esperimento di traduzione dell’Iliade, che presenta la versione del primo canto di entrambi i poeti, accompagnata da un «volgarizzamento letterale» di Melchiorre Cesarotti. Non mancano, al termine, Considerazioni di tutti e tre i letterati, dalle quali emergono diverse “filosofie” di traduzione: spicca però, nelle lunghe riflessioni del Monti, anche una citazione dantesca, per far capire che la fluidità di «Nel mezzo del cammin di nostra vita», non è la stessa cosa di «Della nostra vita nel cammin mezzo» (p. 92).
A collegare tra loro Strocchi, Monti e Foscolo c’è dunque anche Dante, e non starei scrivendo queste poche righe se non avessi ascoltato qualche giorno fa una bellissima lezione di Paolo Borsa (Università di Friburgo) su Foscolo e la fortuna europea di Dante, organizzata in streaming dal mio Liceo (il “Banfi” di Vimercate) per le celebrazioni dantesche. Perché se di Strocchi – ovviamente – non ha parlato, Borsa ha trattato ampiamente degli altri due, spingendomi alla ricerca (e al facile reperimento online del PDF) dell’Esperimento al quale ho prima fatto cenno.
Uno sgarbo a Leopardi?
Prima di chiudere, è necessario un breve accenno anche a un altro “gigante” delle nostre lettere: nientemeno che Giacomo Leopardi, infatti, inviò a Strocchi nel 1819 una copia delle sue prime liriche, accompagnata da un ossequioso biglietto. Da quel che ho letto, l’erudito faentino non gli rispose mai, deludendo il giovane poeta, da lui forse considerato poco più di un ragazzo. Pare che Pietro Giordani stesso – sponsor del recanatese ci sia rimasto male… Si tratta però di una questione sulla quale alcuni studiosi hanno scritto, e dunque non mancherà a me e ai miei lettori il modo di documentarci meglio.
Un esempio di traduzione
Al termine della nostra chiacchierata, propongo solo qualche verso a mo’ di esempio del lavoro dello Strocchi; ho scelto l’incipit della prima Bucolica (Titire, tu patulae…), passo nel quale convivono l’uso della terzina dantesca, l’atmosfera tra l’arcadico e il neoclassico, ma anche alcuni piccoli inserti di tradizione letteraria, poiché il «dolce loco» del v. 6 mi ha subito ricordato analoga espressione petrarchesca (ad esempio in RVF, 16, il notissimo sonetto del «vecchierel»), usata in precedenza dallo stesso Dante (Rime, 42). Per chi volesse leggere di più, segnalo comunque che anche queste Poesie greche e latine volgarizzate, al pari dell’Esperimento foscoliano, sono – in forma di scansione – facilmente reperibili sul web. Io, però, sono ben contento di vederne una “vissuta” copia cartacea nella libreria di casa.
Grazie ancora, dunque, all’amica Manuela. Sappia pertanto che qualunque “anticaglia” libraria dovesse trovare in qualche mobile da restaurare, questa troverà la mia attenzione; tanto più se mi spingerà, come in questo caso, a imparare qualcosa di nuovo.
Melibeo
Titiro, tu di boschereccia canna
Tenti l’umile verso, e fai di queste
Ombre di faggio a te letto e capanna:
Qui in ozio Amarilli alle foreste
Insegni a risonar; le patrie arene
Noi lasciam, noi lo dolce loco agreste.
Titiro
Noi ha degnati un dio di tanto bene,
Un dio: l’are di lui sovente un mio
Agnello tingerà delle sue vene.
È sua mercé se miei giovenchi invio
Attorno, come vedi, e mi diporto
La zampogna a destar come voglio io.
NOTE
[1] Mi permetto solo di segnalare A. Colombo, Strocchi, Dionigi, in “Dizionario biografico degli italiani”, 94 (2019), pp. 364-367. La voce è anche consultabile dal sito www.treccani.it e, poiché è molto recente, contiene una bibliografia aggiornata.

