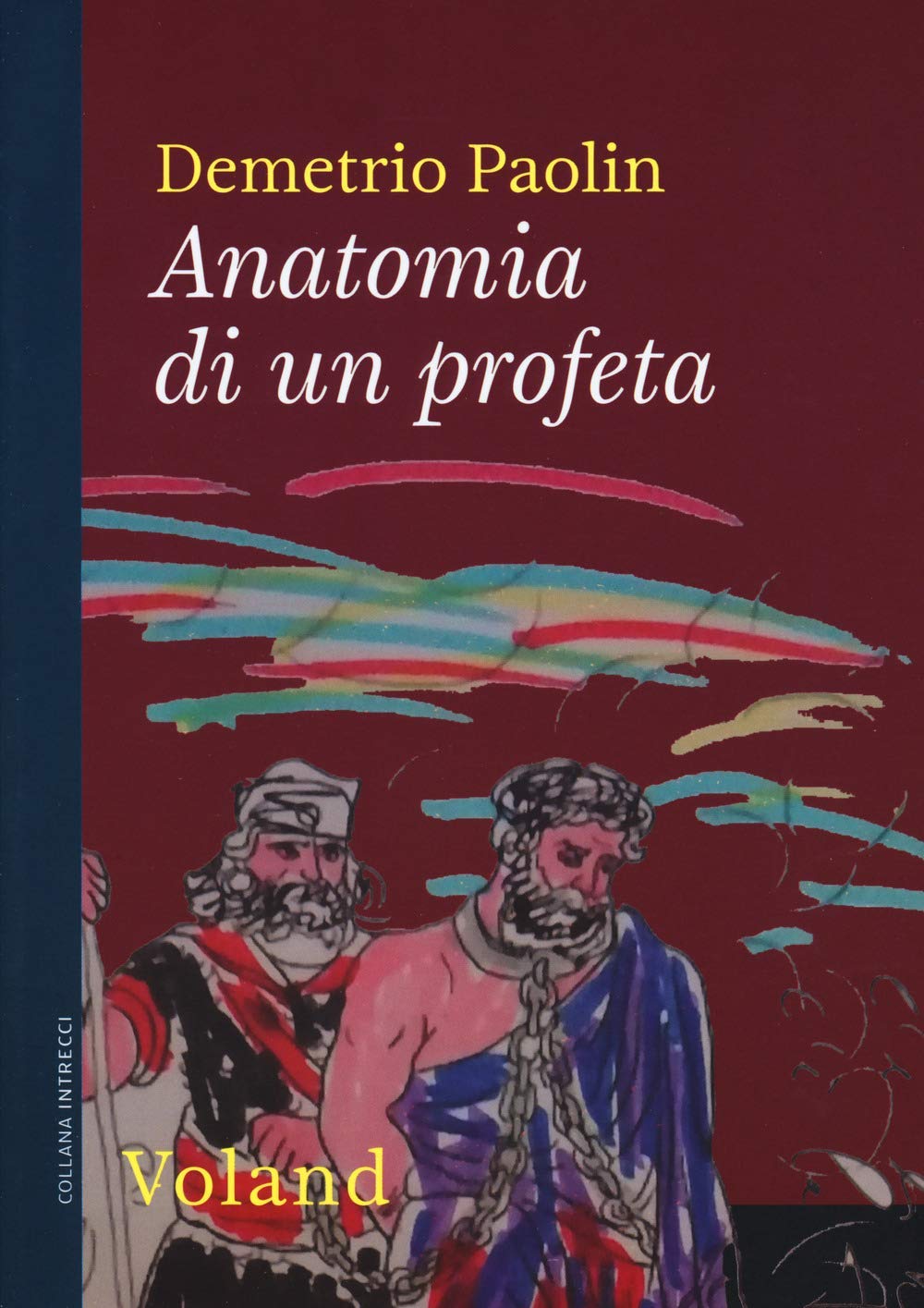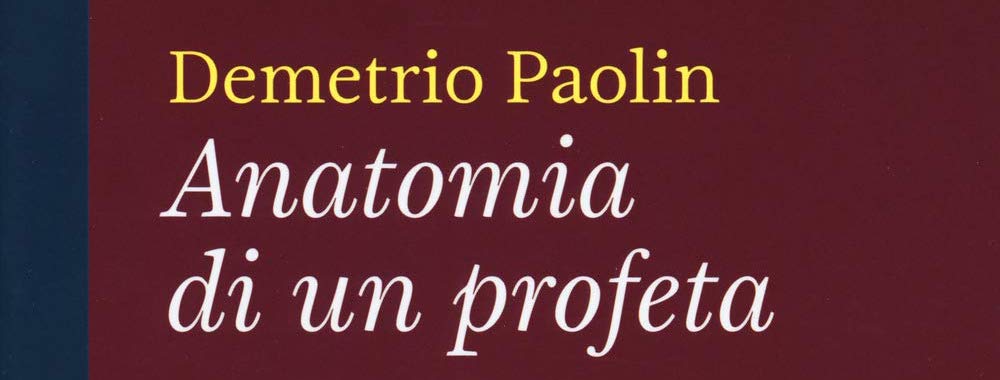
L’occasione mi viene dalla scelta di affrontare in parallelo, in una quarta scientifico, Ariosto e Calvino, con inevitabile deformazione dell’autore cinquecentesco, letto sub specie calviniana e novecentesca. Anziché nascondere il difetto ho esplicitato la circostanza, così che la persistenza del classico emergesse proprio dall’accostamento tra due scrittori, due epoche e due opere (nello specifico il Furioso e il Cavaliere inesistente). Ne è conseguita una riflessione sulla legittimità o illegittimità dell’interpretazione appropriativa e proiettiva dell’opera letteraria e dunque su quella relazione che lega testo e lettore in un dialogo intergenerazionale. Proverò a offrire questa chiave di lettura, per un romanzo contemporaneo certamente non semplice, ma forse adatto ai nostri studenti quasi maturi, ormai in grado di esplorare letterariamente anche un tema scabroso come il suicidio di un bambino.
Al centro della storia raccontata da Paolin è appunto l’undicenne Patrick, che in una notte di dicembre si è tolto la vita ingurgitando veleno per topi e due flaconi di diserbante. La vicenda riemerge diversi decenni dopo, quando l’io narrante ritorna alle colline langarole dell’infanzia e della giovinezza (le stesse che fanno da sfondo al suicidio del bambino) per aiutare il padre nell’innesto di un mandorlo, operazione che resta in realtà un soccorso vano perché la pianta è sterile. Il narratore quarantenne ricorda dunque scene dell’infanzia di Patrick, il suo gesto, la reazione del paese, i genitori e, soprattutto, la propria partecipazione alla vicenda, la quale trova un correlativo oggettivo in un relitto di quel tempo, la musicassetta TDK CHROME da 90 minuti, che ha un titolo vergato nella sua grafia di allora: “L’adolescenza è apprendimento del lutto”. Proprio durante i nove giorni di agonia del bambino, l’adolescente di allora ha registrato per otto volte sul lato A la canzone Jeremy dei Pearl Jam, ispirata dalla storia vera di un adolescente americano uccisosi sotto gli occhi dei compagni, e, sul lato B, ha replicato per lo stesso numero di volte la traccia di Down in a hole, struggente e disperato canto di morte del gruppo statunitense Alice in Chains.
La vicenda è tutta nel movimento generato dal corto circuito emotivo-temporale; l’inchiesta che è il cuore del romanzo si stanzia piuttosto nell’indagine autoptica del titolo, dissezionando l’evento, il protagonista, i testimoni e l’esaminatore stesso. Ma alla meditazione sulla morte e sul lutto si associa una specie di controcanto al narrato, l’analisi e la parafrasi dei testi biblici attribuiti al profeta Geremia. Il libro è perciò uno strano ibrido, un po’ autofiction, un po’ saggio, un po’ riscrittura, la struttura miscela prosa e poesia (poesia visuale anche, in alcuni punti che enfatizzano il potenziale del significante con un cascame di parole o lettere): tra i precedenti prosimetrici la Vita Nova dantesca (nova anche la vita di Demetrio dopo il trauma), ma la relazione con il testo di Geremia palesa soprattutto l’ispirazione esegetica patristica e medievale, con la peculiarità di un vero e proprio corpo a corpo con le parole bibliche. Vale dunque la pena chiedersi non solo quanto Geremia ci sia in Demetrio Paolin ma quanto Demetrio nel suo Geremia: è lo stesso Demetrio a porre la questione, concentrandosi su un versetto mal ricordato, che svela il vizio di immedesimazione, l’eccesso di familiarità con il testo e con il suo autore, dunque una forma di impostura (p. 29).
La prima persona morta è quella che amiamo
Lo scandalo della morte fa il suo ingresso nella vita di un sedicenne ed è subito fine dell’infanzia, ingresso in quel territorio nebbioso in cui le certezze di prima sono scosse dal vissuto esperienziale: dolore, curiosità, straniamento, piacere dell’iniziazione sessuale (proprio la notte in cui Patrick muore), dispiacere subito e cercato attraverso i tagli sulla pelle. Il libro è «una lunga riflessione sul fatto che siamo mortali», scrive Paolin, «dopo la morte di Patrick nulla è stato come prima. Mi verrebbe da dire, sostituendo il cliché, che non è il primo amore che non si scorda mai, è la prima morte: la prima persona morta è quella che amiamo» (nota 8, p. 15). Il gesto «prepotente» di Patrick è perciò «rivoluzione copernicana»: «Ha sbattuto ognuno di noi lontano dal centro dell’universo, ha consegnato la nostra vita – le gioie certe, i successi, i dolori e le perdite – all’insignificanza» (p. 101).
Quel che importa non è tanto la storia di Patrick, del quale si sa poco e che resta evanescente e fantasmatico, come le figure commoventi dei genitori, condannati dalla perdita a forme diverse di non vita. L’attenzione soggettiva è tutta sul narratore e su quel primo lutto, predittivo di altri più o meno vicini: una ragazza di Torino, Tenco, Cobain, Chris Cornell, la Sylvia Plath dei versi in esergo, e i quattro scrittori suicidi dei racconti che compongono Non fate troppi pettegolezzi (Liberaria, 2014), Salgari, Levi, Pavese, Lucentini. Quelle morti autoinflitte hanno creato una parentela esistenziale. Demetrio fa di quei suicidi i suoi Lari, e li invidia perché essi osando l’inosabile (il folle volo) per un attimo hanno visto e saputo: «Se guardiamo alla morte come al momento finale, la morte è la cosa più prossima a Dio che possiamo immaginare su questa terra». Al contempo realizza che il suo “fantasticare” su quelle morti è un’impostura apotropaica: «Se invece di uccidermi avessi preferito concentrarmi sul suicidio altrui, per non affrontare il mio?» (p. 32).
Il suicidio archetipico di Patrick è la genesi della scrittura («Credo di aver iniziato a scrivere per questo motivo, perché volevo in qualche modo dire ciò che avevo intuito vedendo questi esseri umani uccidersi», p. 119) e anche la ragione principale di una fede che alla scrittura è strettamente legata: «Ho creato una religione dopo la sua morte, ho fatto del suo suicidio la mia ragione di fede, scrivo questo libro come se fosse la profezia della sua possibile venuta». Per questo è facile vedere in Patrick una figura cristologica, egli lo è dal primo apparire sulla scena con il suo “cadavere squisito” come un’ostia, che Paolin immagina venirgli incontro come un Dio a indicare il suo volere. Il discorso su Patrick è fondamentalmente un discorso su Dio.
Impostore come un profeta
Come un testo medievale, il romanzo inizia con una soprascritta nella quale si esplicita in modo inequivocabile l’equivalenza Demetrio-Geremia, anticipatrice di quella Geremia/Patrick/Demetrio (e persino della correlazione dei tre a un Dio la cui incarnazione è assimilata proprio al precipitare di un suicida). Ciò che lega il narratore a Geremia, profeta perfetto per le tragedie del Novecento (si pensi alla sua centralità nelle meditazioni di Dietrich Bonhoeffer negli anni Trenta), non è però la capacità di predire un male imminente (assedio, distruzione del tempio, deportazione), perché il male è già e a esso il profeta odierno può opporre soltanto la sua partecipazione al dolore del mondo.
La figura del profeta che primeggia sin dal titolo è centrale nella lingua poetica di Paolin: predicatore e profeta era anche il tedesco Rudolf, figlio di SS, protagonista di Conforme alla gloria (Voland, nella dozzina dello Strega 2016), che girava le piazze della sua Germania esponendo, come una reliquia del male, sé stesso e un macabro dipinto tatuato sulla pelle di un deportato. L’ossessione dell’autore per la profezia ha un carattere che meriterebbe più di qualche parola: non è nella presunzione di parlare al posto di Dio, colmando così il suo silenzio, né insegue una via ispirata della scrittura che vuole nel poeta una specie di medium. La profezia di Paolin è letteralmente affossata nel fango della Storia e delle storie; all’Altro, al divino, egli rivolge al più domande destinate a rimanere irrelate, collocando la sua riflessione sull’ineluttabilità del male nel solco della tradizione che svela la grande ferita del Moderno, quella di cui Auschwitz e le tragedie storiche novecentesche hanno approfondito radicalità. Si trova nella scrittura di Paolin quello che si trova in molta poesia moderna che, da Leopardi in poi, per usare le parole del critico Daniele Piccini, «non edulcora, non fa memoria di una tragedia dissolvendola in estetica (…) non è una forma di consolazione, ma una spina, però portata, un po’ diversamente dalla filosofia, da dentro la vicenda, non da sopra o da fuori, non per categorie, in modo che ogni piccolo dettaglio può in essa valere come il tutto» (D. Piccini, “Il male e la poesia moderna”, in Letteratura come desiderio, Moretti & Vitali, Bergamo 2008, p. 82).
Legando profezia e impostura, Paolin mette al centro della sua poetica l’inettitudine della parola; la profezia è smentita dall’impostura, che sigilla la lingua, rende lo scrivere faticoso, la adombra con il dubbio. Eppure non si rassegna: parafrasando il verso di Sylvia Plath posto in apertura al romanzo, prova a leggere la realtà di Patrick come un filologo ambizioso che tenti di decodificare la lingua speciale dei suicidi, ma sa i limiti della sua lettura.
In un suo saggio di qualche anno fa intitolato Il testimone integrale («Narrazioni», 3/2013, pp. 70-81), il dramma dello scrittore Primo Levi, deportato e sopravvissuto, è rintracciato proprio nell’impossibilità di essere testimone autentico di un male non esperito integralmente a causa della propria sopravvivenza. Lo stesso tema è indagato nel già citato Non fate troppi pettegolezzi, dove il racconto dedicato a Primo Levi parte dal pellegrinaggio lungo la via torinese che porta alla casa dello scrittore. Lì si trova l’ippocastano a cui Levi dedicò la poesia Cuore di legno:
È un impostore, ma ingenuo: vuole farsi credere
emulo del suo bravo fratello di montagna
signore di frutti dolci e di funghi preziosi.
Con una fulminante intuizione Paolin correla l’ippocastano al protagonista del racconto Ferro (Il sistema periodico), l’amico Sandro Delmastro, ucciso da un giovanissimo miliziano. Morendo, lui e gli altri sommersi della vita dello scrittore, hanno implicitamente delegato al sopravvissuto il compito necessario e ingrato di raccontare, pur nella consapevolezza che il racconto non può riportare in vita chi è morto. La resurrezione della carne, che Paolin cerca nel suo ultimo romanzo, non si dà nella forma scrittura. Qual è allora il senso dello scrivere?
La scrittura come guscio
Il Primo Levi raccontato da Paolin è sicuramente Primo Levi, ma è al contempo il suo Primo Levi. Così come l’Ariosto spiegato attraverso Calvino è un Aristo non tradito ma certamente potenziato (rivitalizzato) dal suo più illustre lettore moderno. Non è questa impudenza della letteratura che tiene in vita i classici?
Porterò all’estremo il gioco interpretativo: nel racconto di Non fate troppi pettegolezzi il corpo di Primo Levi suicida ricorda un uovo senza guscio, «albume e tuorlo sparsi sul marmo». L’immagine della poltiglia è suggerita da un’espressione che lo stesso Levi impiega in una delle sue ultime interviste, quando degli ebrei italiani dice che «erano veramente senza corazza, nudi come un uovo senza guscio», ma il tema del guscio è un leitmotiv in Levi. In un breve saggio di Marco Belpoliti è segnalata una nota autografa su foglio aggiunto nel 1958 a Le nostri notti: «La facoltà umana di scavarsi una nicchia, di secernere un guscio, di erigersi intorno una tenue barriera di difesa, anche in circostanze apparentemente disperate, è stupefacente, e meriterebbe uno studio approfondito. Si tratta di un prezioso lavorio di adattamento, in parte passivo e inconscio, e in parte attivo: di piantare un chiodo sopra la cuccetta per appendervi le scarpe di notte; di stipulare taciti patti di non aggressione coi vicini; di intuire e accettare le consuetudini e le leggi del singolo Kommando e del singolo Block. In virtù di questo lavoro, dopo qualche settimana si riesce a raggiungere un certo equilibrio, un certo grado di sicurezza di fronte agli imprevisti; ci si è fatto un nido, il trauma del travasamento è superato».
Il curatore delle opere di Primo Levi richiama anche una seconda occorrenza nel capitolo “La mia casa” di Se questo è un uomo edizione 1958, nel quale l’avere abitato sempre lo stesso luogo è «un caso estremo di sedentarietà paragonabile a quello di certi molluschi, ad esempio le patelle, che dopo un breve stadio larvale in cui nuotano liberamente, si fissano ad uno scoglio, secernono un guscio e non si muovono più per tutta la vita». E l’immagine dell’uovo ricorre certamente nell’articolo Covare il cobra («la Stampa», 11 settembre 1986), dove, richiamando gli scienziati alla loro responsabilità, Levi avverte che una ricerca scientifica non accompagnata dalla riflessione etica può produrre un guscio che schiudendosi genererà il nemico, il Male, il serpente appunto.
Dicevo, porterò all’estremo il gioco: a pagina 13 di Anatomia di un profeta: «Io sono un buco nero e l’amore provato per un bambino di nome Patrick morto tanti anni fa è l’estremo tentativo per giustificare la rabbia che covo nelle ossa». L’endoscheletro del male è l’esatta antitesi del guscio/esoscheletro che protegge i molluschi. Il male è per Paolin nel midollo dell’esistenza, è il dolore, la rabbia, la vergogna di cui è impastata la vita stessa da che, parafrasando Geremia, «la malizia e la colpa» sono entrate nella creazione/manufatto divino, ne hanno profanato la perfezione, trasformandola «in poltiglia informe» (p. 20).
Se la meditazione sulla morte è l’estremo tentativo di rendere nuovamente giusto ciò che è intimamente corroso dal male, ne consegue che la sua scrittura è anche preghiera e, come ogni preghiera, chiedendo l’impossibile cancellazione del male, apre invece la mente a non trascurabili anticipi di consolazione: qui rintracciabili nell’intuizione della trasformazione del corpo di Patrick, del suo ininterrotto farsi vivo nel terreno, offrendo nutrimento chimico alle piante. Qui e ora, ogni altra resurrezione resta una promessa.
Dunque la scrittura cos’è? Voce di qualcuno che balbetta nel deserto, eppure desiderio: di una forma, di un guscio, di un tessuto di parole che al male di vivere opponga una pur transitoria «tenue barriera di difesa».