Il contatto con popoli diversi dal proprio ha destato fin dall’antichità due atteggiamenti solo apparentemente opposti, presenti già nelle Storie di Erodoto: la contemplazione delle meraviglie, di cui furono massimi rappresentanti gli Egizi, o la condanna della barbarie, propria dei lontani Sciti. Di entrambi i popoli Erodoto descrive usi e costumi, ora esaltandone l’eccellenza ora suggerendone l’arretratezza, sullo sfondo di paesaggi che sembrano giustificarle, con rigoroso determinismo. Questa visione semplificatrice dello straniero risentiva di contrapposizioni politiche ed economiche alimentate dalla colonizzazione greca e dalle guerre. La ritroviamo puntualmente negli scritti e nelle azioni dei conquistatori europei, come ci ha insegnato un saggio capitale sull’argomento: La conquista dell’America. Il problema dell’«altro» (1982) di Tzvetan Todorov, libro che nonostante le critiche (in primo luogo di non essere stato scritto da uno storico in senso stretto) non smette di far riflettere.
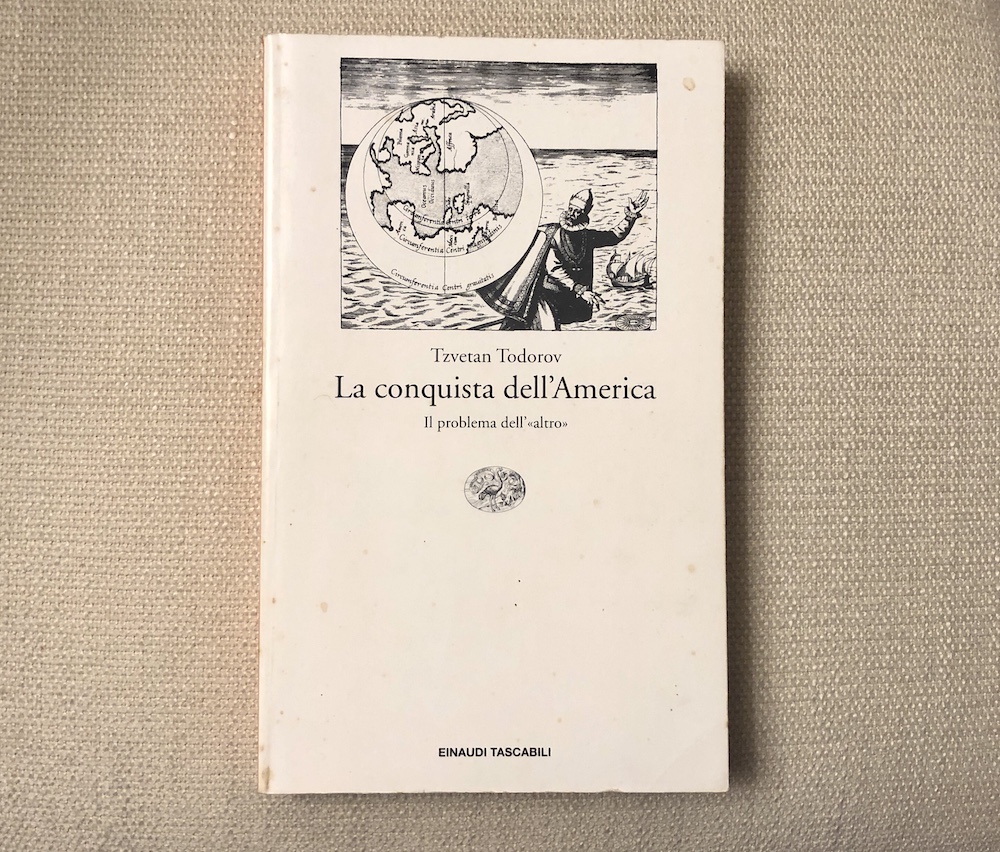
La storia della colonizzazione europea è quasi sempre raccontata da una prospettiva che, nelle classi multietniche di oggi, è non solo superata ma poco favorevole all’integrazione. Quando pure se ne parla, il colonialismo dai tempi di Cristoforo Colombo, nelle sue varie forme, presuppone una considerazione dei continenti sottomessi degna dei sussidiari di epoca fascista. O, appunto, degli etnografi antichi. Sono argomenti con ricadute importanti sia negli studi propriamente storici, sempre meno concentrati su singole regioni (secondo la World o Global history), sia nella museologia, per il rimpatrio degli oggetti sottratti durante il periodo coloniale [Si veda a questo proposito l’approfondimento di Elena Franchi su La ricerca, N.d.A.].
Il problema riguarda più livelli: 1) geografico; 2) etnico; 3) economico. Vediamoli nel dettaglio, con particolare riferimento al continente africano.
1) L’Africa è in genere presentata come un continente inadatto agli insediamenti umani, ricoperto di foreste o deserti che rendono difficili agricoltura e allevamento, attraversato da fiumi non navigabili a causa di ripide e cateratte, delimitato da coste basse sfavorevoli all’attracco di navi. Un simile campionario di piaghe geografiche non spiega però come mai una terra tanto inospitale abbia suscitato le mire dei conquistatori stranieri. I quali, nonostante le apparenti malformazioni territoriali, sono riusciti a: organizzare la tratta degli schiavi e il commercio triangolare; fare letteralmente a fette il continente, secondo confini geometricamente inappuntabili; circumnavigarlo e, a Suez, tagliarlo; depredarne le risorse minerarie; alimentare i conflitti locali a proprio vantaggio; e chi più ne ha, più ne metta. Che dunque le sofferenze dell’Africa siano dovute in gran parte al colonialismo è una verità mai ribadita abbastanza. Il clima, la geografia c’entrano fino a un certo punto. Altrimenti non si capisce perché altre regioni del mondo «inospitali» ma non interessate dalle manifestazioni più aggressive del colonialismo europeo (la Russia, la Scandinavia) abbiano conosciuto una storia diversa. Anche l’idea di «confini naturali» che dall’alba dei tempi dovrebbero separare popoli e Stati è inconcepibile disgiunta dai processi storici.
2) Per nessun altro continente come per l’Africa (e il Sudamerica) si scende tanto nel dettaglio quando si descrive la composizione delle popolazioni. È vero che lo schiavismo e le numerose ondate della colonizzazione hanno generato comunità etniche eterogenee, come in Sudafrica. Ma ciò non giustifica una casistica di «tipi» umani da manuale di antropologia criminale. Quando si descrive l’Italia, mica si dice quanti siano i discendenti dei Normanni, quanti dei Longobardi, dei Celti, degli Arabi, dei Bizantini ecc. Peraltro molti termini etnici sono stati imposti dagli europei e vengono percepiti dai locali come inappropriati se non offensivi: è il caso di «beduini», «berberi» (equivalente di «barbari»), «pigmei», «zulù», «boscimani», «aborigeni» fino agli «altissimi watussi» della nota canzonetta (per carità!). E aggiungiamo, per l’America del Nord, «pellerossa» ed «eschimesi», due espressioni dispregiative nate da osservazioni superficiali e oggi bandite dal vocabolario inglese, sostituite, rispettivamente, da «Nativi» (o «Prime Nazioni») e «Inuit». Anche l’insistenza sui «meticci», sui «creoli», sui più o meno «latini» suggerisce l’idea di una vicinanza o lontananza da un presunto «sangue puro»; la stessa espressione «America latina» è ormai rimpiazzata da «America centro-meridionale» (e forse verrà il giorno in cui l’«America» si chiamerà diversamente).
Todorov osserva che il primo atto di Colombo sbarcato nelle isole caraibiche fu di nominare, un po’ come Adamo nell’Eden, i luoghi, in onore delle divinità cristiane o dei sovrani spagnoli. Questa tendenza imperialistica va estirpata, nel rispetto delle culture locali; basta vincere la pigrizia, informarsi e la sostituzione è servita. Anche perché le classi italiane abbondano di rappresentanti di tali culture che possono diventare fondamentali per analizzare la storia da punti di vista alternativi, essendo in genere ben ferrati/e sull’argomento «colonialismo». Pensando a loro, abbandoniamo modi di dire come «parlare arabo», «occhi da mongolo», «fumare come un turco», e simili amenità.

Attenzione poi a passare dalla svalutazione dell’altro (il barbaro che fa sacrifici umani o beve sangue, il cannibale, l’incivile), sostenuta dai conquistadores, al mito del buon selvaggio (dolce, gentile, indifeso), di cui fu campione il frate domenicano Bartolomé de Las Casas. Quello che possiamo definire «razzismo di sinistra», in apparenza inoffensivo ma pur sempre incline all’assimilazione, è tanto pericoloso quanto il «razzismo di destra», più esplicitamente violento e aggressivo.
3) Veniamo infine alla trattazione economica, difficile da spiegare senza ricorrere all’anti-capitalismo di Marx, Lenin e soci. Descrivere un continente sulla base delle potenzialità economiche delle sue risorse naturali non è un’operazione onesta. Ad esempio, dire che l’Africa è povera perché i suoi fiumi non sono navigabili, oltre a non essere del tutto corretto dal punto di vista storico, presuppone che un territorio abbia valore solo qualora se ne possa ricavare un profitto. L’Africa, del resto, nonostante la decolonizzazione, continua a essere depredata (si pensi alle terre rare) e ai capitalisti tradizionali si sono aggiunti quelli asiatici, Cina in testa. Questa visione sfruttatrice va abbondonata, e per sempre, se vogliamo davvero assumere un atteggiamento rispettoso e non paternalistico. Dopo secoli di monocoltura, monopolio dei commerci con la sedicente «madrepatria», spopolamento, segregazione etnica, sottomissione delle culture native (nelle scuole della Somalia si studiavano Dante e Manzoni, tanto per fare un esempio) è ovvio che l’Africa abbia bisogno di più tempo per emergere secondo la scala di valori dell’Occidente.

Troppo comodo dare la colpa di tutto alle guerre civili, alla corruzione, alle baraccopoli, senza ripercorrere il sentiero storico che le ha rese possibili. Questa esigenza è riassunta nella parola «decolonialità», ovvero la messa in discussione di quell’eurocentrismo che prima ha incoraggiato l’imperialismo e poi ne ha pervaso il resoconto storiografico, in maniera talvolta involontaria. Liberarsi di tale prospettiva, che guarda agli altri continenti dall’alto in basso, risalire alle ragioni ultime delle disparità, adottare un linguaggio consono è la premessa per un vero dialogo interculturale. Sono i muri mentali che, più insidiosi delle statue dei conquistatori disseminate dagli europei in giro per il mondo, è necessario abbattere.

