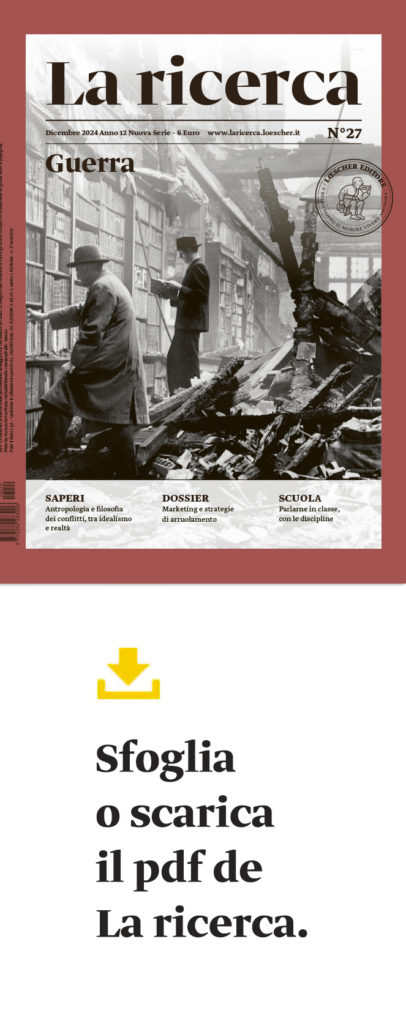Una storia «disgustosa»
Katherine Mansfield, commentando Tutto è bene quel che finisce bene, la commedia di Shakespeare ispirata alla novella di Giletta e Beltramo, dichiara che la protagonista (Helena nel testo di Shakespeare) è «a terrifying female» (una donna terrificante), e continua: «As to lying in Diana’s bed and enjoying the embraces meant for Diana – well, I know nothing more sickening» (Quanto a mettersi nel letto di Diana e godersi gli abbracci destinati a Diana – beh, non mi viene in mente nulla di più disgustoso).
Giletta e Helena non coincidono perfettamente, ma il confronto rivela che la seconda è un poco addolcita rispetto al modello originario, sicché il duro giudizio della scrittrice neozelandese colpisce a maggior ragione il personaggio della novella – su cui ora voglio concentrare l’attenzione, lasciando da parte Shakespeare. È un giudizio moralistico, senza dubbio, nel senso che riguarda il comportamento della fanciulla e non la composizione del testo, lo stile dell’autore o la dimensione simbolica della vicenda, ma non per questo possiamo scartarlo come irrilevante: Boccaccio infatti sollecita proprio una presa di posizione morale, e lo conferma e contrario l’assenza di ogni commento da parte della narratrice (la regina Neifile) e delle sue ascoltatrici.
Assenza che colpisce, perché questa è l’ultima novella della Terza giornata (quella di Dioneo, come è noto, non rispetta il tema prescritto) e conclude la lunga serie dedicata al rapporto tra fortuna e virtù, interventi del caso e intraprendenza umana. La novella affronta i due aspetti della questione programmaticamente enunciati dalla regina stessa, che ha chiesto alle compagne di parlare «di chi alcuna cosa molto da lui disiderata con industria acquistasse o la perduta ricoverasse»: Giletta infatti nella prima parte della novella grazie alla sua abilità di medica riesce a sposare l’uomo che ama e nella seconda parte grazie alla sua astuzia e alla sua spregiudicatezza lo riconquista, dopo averlo perduto. È proprio questa spregiudicatezza che fa inorridire Mansfield e che chiama in causa chi legge per essere approvata o disapprovata.
Maschile/Femminile
La novella nasce dalla fusione di due motivi fiabeschi, legati al superamento di altrettante prove. Nella prima parte del racconto Giletta segue l’amato Beltramo a Parigi e si presenta al re dichiarando che potrà sanare la piaga di cui soffre; se non riuscirà, verrà bruciata come strega, ma in caso contrario potrà scegliersi il marito che vuole (purché non sia di sangue reale). L’eroina, che ha appreso l’arte medica dal padre, guarisce il re e ottiene in marito Beltramo, cambiando la sua condizione sociale, da medica (plebea) a contessa (nobile). Nella seconda parte Giletta, pur essendo «bella e savia» e molto innamorata del marito, viene da lui rifiutata per la sua inferiorità sociale; Beltramo diserta il letto coniugale e abbandona addirittura propria contea, dichiarando che Giletta potrà diventare davvero sua moglie solo se otterrà un anello che lui non si toglie mai dal dito e se gli partorirà un figlio – due prove che ritiene impossibili; Giletta lo raggiunge in incognito a Firenze, si sostituisce a una fanciulla che Beltramo desiderava come amante e supera le prove.
L’operazione di montaggio delle due vicende si regge sul personaggio di Giletta, che si caratterizza per il fatto di assumere, in tutte le fasi della vicenda, ruoli tipicamente maschili. Apprende dal padre l’arte medica e la pratica con successo; sceglie il proprio marito, e lo sceglie non solo bello, ma di una condizione sociale superiore alla propria; quando lui, costretto dal re a sposarla, la rifiuta di fatto e se ne va a Firenze per fare il mercenario, lei assume il governo del Roussillon e «sì come savia donna con gran diligentia e sollecitudine ogni cosa rimise in ordine»; quando il marito, «durissimo», le impone per interposta persona le due prove impossibili, Giletta riflette e decide di tentare «se quelle due cose potessero venir fatto»: prende ancora una volta l’iniziativa e si rimette in viaggio, vestita da pellegrina, per raggiungere Beltramo a Firenze, dove scopre che il marito vagheggia una giovane nobile, ma impoverita, si accorda con la madre di quest’ultima per farsi mettere al posto della figlia, fingendo che questa si conceda a Beltramo (al buio) in cambio del famoso anello, fino a restare incinta non di uno, ma di due bambini.
È questo l’episodio che suscita lo sdegno di Mansfield, perché Giletta (o Helena che sia) deve fingere, tra le braccia del marito, di essere un’altra donna, e prendere carezze e baci che non sono destinati a lei. L’intraprendenza di un’eroina che, comportandosi come un uomo, decide del proprio destino e conquista la propria felicità, contraddice quasi punto per punto le caratteristiche genericamente attribuite alle donne nel Decameron, che Filomena elenca nell’Introduzione alla Prima giornata: «Noi siamo mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose». E tuttavia tale intraprendenza porta a una situazione per noi molto conturbante: quando è a letto con Beltramo Giletta è nello stesso tempo la moglie e l’amante di suo marito, nel suo corpo convivono due donne diverse, quella che lei sa di essere e quella che Beltramo crede che sia.
Personaggi senza interiorità
In verità questa situazione, che a noi moderni appare così complicata, all’eroina di Boccaccio non suscita alcun problema, perché Giletta, come tutti personaggi della novella, è priva di spessore psicologico: la dimensione dell’interiorità è relegata all’antefatto (l’innamoramento infantile), tutto il resto della vicenda si svolge per così dire in pubblico, in una dimensione di socialità molto insistita. Giletta agisce come su un palcoscenico, davanti a un uditorio, perché la presenza di testimoni è decisiva per il successo delle sue azioni, sia quando stabilisce col re di Francia il patto relativo al suo compenso di medica, sia quando si presenta a Beltramo e rivela di aver superato le prove (che lui le aveva imposto pubblicamente, tramite ambasciatori).
Anche nell’ordire la sostituzione di persona che ingannerà Beltramo, la preoccupazione della protagonista è tutta rivolta alla dimensione sociale: bisogna salvaguardare l’«onestà» della giovane (parola-chiave ripetuta ben sei volte nel corso della novella), nei confronti della quale Giletta assume ancora una volta un ruolo maschile (quello di padre: le pagherà la dote in cambio della gentilezza). L’ambiguità che viene a crearsi con la sostituzione di persona non sembra turbarla, tanto che ad alcuni lettori il personaggio è parso freddo, quasi disumano nella sua eccessiva razionalità.
Questa piattezza psicologica è in parte una conseguenza del carattere fiabesco della vicenda, che tende a rendere i protagonisti dei tipi, delle funzioni, direbbe Propp, più che dei personaggi. Ma a me pare che Giletta (come molti protagonisti, maschili e femminili, delle novelle boccaccesche) incarni la mentalità mercantile, cioè appunto l’atteggiamento di chi valuta spassionatamente le situazioni e agisce nel modo più efficace e spregiudicato per raggiungere il proprio obiettivo. La sua è una razionalità economica, per così dire, che prescinde da emozioni, sentimenti, valori morali, problematiche psicologiche. Il passaggio di Giletta da «fanciulla» a «donna» a «contessa», che scandisce le tappe della vicenda ed è mostrato dalle scelte lessicali della narratrice, è il riconoscimento sociale del suo successo, fino al trionfo finale.
Sesso e denaro
Resta da esaminare un altro problema sollevato dalla sequenza fiorentina della vicenda, e cioè il fatto che Beltramo accetta di possedere la ragazza di cui è invaghito (anzi, «il più innamorato uom del mondo») in cambio di una ricompensa materiale – l’anello che sua moglie gli esibirà più tardi di fronte a tutti i cortigiani. La ragazza, nobile ma povera, accetterebbe insomma (nella messa in scena organizzata da Giletta) di prostituirsi – nella realtà, invece, si tratta di una «onestissima giovane», accudita da una madre «savissima e buona donna».
Che il dono dell’anello sia proposto come segno d’amore, e non come pagamento in denaro, non può ingannare: quella che Beltramo propone non è affatto una relazione «onesta», essendo lui sposato, e lo squilibrio economico farebbe della ragazza né più né meno che la sua mantenuta. Temo che questo, sotto traccia, abbia influito sul giudizio di Mansfield, ma ciò ha un’importanza relativa, ormai – occorre piuttosto sottolineare come il rapporto tra sesso e denaro affiori nel Decameron con una frequenza quasi imbarazzante. Ecco un rapido elenco delle novelle in cui si parla di prostituzione:
- I 4: il monaco protagonista incontra una giovane contadina, «con lei entrò in parole e tanto andò d’una in altra, che egli si fu accordato con lei e seco nella sua cella ne la menò»;
- II 2: Rinaldo, spogliato dai briganti, è ospitato da una vedova di Castel Guglielmo che il marchese «quivi a instanzia di sé facea stare», cioè teneva come sua mantenuta;
- II 5: l’ingenuo Andreuccio da Perugia viene circuito da «una giovane ciciliana bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo»;
- III 8: l’abate protagonista conclude il lungo discorso con cui seduce la moglie del geloso Ferondo con le parole «Oltre a questo, io ho di belli gioielli e di cari, li quali io non intendo che d’altra persona sieno che vostra»; e la donna, dopo qualche esitazione, «avendogli veduto in dito un altro bello anello, disse che era apparecchiata»;
- VI 3: messer Dego della Ratta si accorda col marito di una bella fiorentina «di dovergli dare cinquecento fiorin d’oro, e egli una notte con la moglie il lasciasse giacere», salvo poi pagare con denaro falso;
- VIII 1: madonna Ambruogia accetta di diventare l’amante di Gulfardo in cambio di duecento fiorini d’oro, ma lui, sdegnato per la sua ingordigia, se li fa prestare dal marito e beffa la donna;
- VIII 2: il prete di Varlungo convince monna Belcolore ad avere rapporti con lui in cambio di cinque lire (che il prete riuscirà a non pagare) e lei ricorda il triste caso di un’altra parrocchiana, finita male per una storia simile: «credete voi fare a me come voi faceste alla Biliuzza […]? Alla fé di Dio non farete, ché ella n’è divenuta femina di mondo pur per ciò»;
- VIII 4: una vedova di Fiesole si fa sostituire nel letto da una serva, la Ciutazza, in cambio di una camicia nuova, per far cogliere il «preposto» che la tormenta in flagrante dal vescovo;
- VIII 10: l’ingenuo Salabaetto (quasi un secondo Andreuccio) si lascia circuire da una delle palermitane «bellissime ma nemiche dell’onestà, le quali […] con lor piacevoli e amorosi atti e con parole dolcissime questi cotali mercatanti s’ingegnano d’adescare e di trarre nel loro amore»;
- IX 5: gli amici fanno credere a Calandrino che il suo amore per la Niccolosa («la quale un tristo, che era chiamato il Mangione, a sua posta tenendola in una casa da Camaldoli, prestava a vettura») sia ricambiato;
- X 5: messer Ansaldo invia a madonna Dianora una mezzana («una femina che a lei da parte di lui spesse volte veniva») promettendo «maravigliosi doni» in cambio del suo amore; lei chiede (come Beltramo) una cosa apparentemente impossibile, ma messer Ansaldo riesce a procurargliela con l’aiuto di un negromante.
Tralascio la battuta allusiva con cui Dioneo conclude la novella di Griselda (X 10: a Gualtieri «non sarebbe forse stato male investito d’essersi abbattuto a una che quando, fuori di casa, l’avesse fuori in camiscia cacciata, s’avesse sì a un altro fatto scuotere il pilliccione che riuscito ne fosse una bella roba»); e i casi, più rari, in cui sono gli uomini a concedersi per denaro (per esempio IV 10, in cui la protagonista ha un amante senza scrupoli, Ruggieri d’Aieroli, e per amore «lo incominciò a sovenire quando d’una quantità di denari e quando d’un’altra»).
Favola e realismo
Quali conclusioni trarre da queste osservazioni? La prima è che Boccaccio usa le strutture tipiche della fiaba per rappresentare la realtà dei rapporti sociali ed economici. Beltramo rifiuta Giletta perché la ragazza appartiene a una classe sociale inferiore; ma alla fine la riconosce come sua pari in quanto entrambi condividono la visione economicistica del mondo – quella che spinge l’eroina a usare la sua «industria» per nobili scopi, e il conte ad approfittare della miseria della giovane fiorentina per farne la sua mantenuta.
Giletta non è «terrificante» perché si comporta come un uomo o perché ci resta sconosciuta la sua interiorità, ma perché agisce in base a una razionalità fredda e impersonale. Nel suo caso, il risultato è positivo, ma altre novelle del Decameron mostrano quanto possano essere davvero «terrifying» le conseguenze di questo atteggiamento – e non solo le novelle di avventura o di amore o di beffa, ma anche quelle della Decima giornata, che dovrebbe contenere gli esempi di liberalità e magnificenza, ossia delle virtù supreme del mondo cortese. Lo vedremo meglio nel prossimo intervento.
(continua)