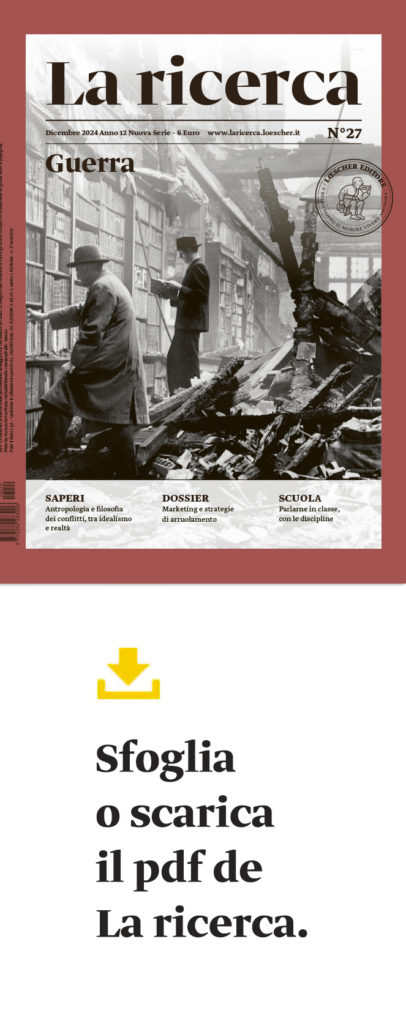Giustizia e compassione
La novella dello scolare Rinieri e della vedova Elena è la più lunga e articolata tra quelle dedicate alle beffe (non solo nelle giornate Settima e Ottava, ma in tutto il Decameron). Ripercorriamo dunque il testo, senza la pretesa di svolgerne un’analisi esaustiva, ma soffermandoci su alcuni passaggi di particolare rilievo.
Il racconto è affidato a Pampinea, la più saggia delle novellatrici, la quale sottolinea il valore morale della storia che si accinge a raccontare: finora, dice, abbiamo riso delle beffe, tuttavia non abbiamo mai visto un beffatore punito; «ma io intendo di farvi avere alquanta compassione d’una giusta retribuzione a una nostra cittadina renduta». Pampinea enuncia così il problema centrale della novella, cioè il rapporto tra giustizia e compassione, che sarà al centro dei commenti delle ascoltatrici al termine del racconto:
Gravi e noiosi erano stati i casi d’Elena a ascoltare alle donne, ma per ciò che in parte giustamente avvenutigli gli estimavano, con più moderata compassione gli avean trapassati, quantunque rigido e constante fieramente, anzi crudele, reputassero lo scolare.
Come si vede, il problema resta aperto: i casi narrati provocano inquietudine e riflessioni dolorose, perché da un lato la punizione della vedova è giusta, almeno “in parte”, e questo attenua la compassione dell’onesta brigata nei suoi confronti, ma dall’altro lo scolare è reputato «rigido… anzi crudele». La morale esplicita proposta da Pampinea all’inizio e alla fine della novella («questo udire non sarà senza utilità di voi, per ciò che meglio di beffare altrui vi guarderete, e farete gran senno»; «E per ciò guardatevi, donne, dal beffare, e gli scolari spezialmente») risulta inadeguata rispetto alle questioni sollevate, e riconosciute dalle sue compagne, e sollecita quindi un esame più approfondito.
Un gioco di simmetrie
Veniamo dunque al racconto. Pampinea esordisce con la presentazione dei due protagonisti, entrambi descritti in termini largamente positivi: Elena è «una giovane del corpo bella e d’animo altiera e di legnaggio assai gentile, de’ beni della fortuna convenevolmente abondante», che approfitta della sua condizione di privilegio per garantirsi la libertà di amare un uomo «a sua scelta»; Rinieri è «nobile» come Elena, e come lei può permettersi di vivere di rendita e di dedicarsi liberamente alla sua passione – lo studio – «non per vender poi la sua scienza a minuto, come molti fanno, ma per sapere la ragion delle cose e la cagion d’esse». Sia lei sia lui, insomma, uniscono alla nobiltà di sangue quella interiore, dell’animo: «altiera» è infatti un aggettivo positivamente connotato, che indica altezza di sentimenti, così come il fatto che Rinieri studi per disinteressato amor di conoscenza e non per sfruttare economicamente il suo sapere.
Il doppio ritratto iniziale anticipa la struttura perfettamente bipartita della novella: nella prima parte la vedova, di cui Rinieri si è innamorato, approfitta della sua passione per attirarlo in pieno inverno nel cortile di casa sua e fargli passare una notte al gelo, rassicurando in questo modo il proprio amante, che dubitava della sua fedeltà; nella seconda parte è lo scolare che approfitta della sofferenza d’amore di Elena, abbandonata dall’amante suddetto, per attirarla in piena estate su una piattaforma in mezzo alla campagna e farla arrostire al sole per un giorno intero, compiendo così la sua vendetta.
Il parallelismo tra le due parti della novella affiora anche in una serie di dettagli più minuti. Per esempio, nella prima parte la vedova e il suo amante osservano dall’alto Rinieri che trema in mezzo alla neve, nella seconda parte la situazione è identica, ma mutata di segno – la donna si trova ancora in posizione più elevata rispetto a Rinieri, ma in realtà a dominare la situazione è lui, e lei è la vittima. In entrambe le parti ha un ruolo significativo la serva della donna, che nella prima è coinvolta nella beffa ai danni di Rinieri, nella seconda, dopo aver involontariamente spinto la sua padrona nella trappola dello scolare, resta coinvolta nella vendetta di quest’ultimo.
Infine, sia nella prima che nella seconda parte hanno un ruolo decisivo i dialoghi tra i due protagonisti: nella prima parte, la vedova prende in giro lo scolare, che supplica invano, giocando sulla metafora del fuoco amoroso: «Questo non dee potere essere [cioè il fatto che lo scolare muoia di freddo], se quello è vero che tu m’hai più volte scritto, cioè che tu per l’amor di me ardi tutto»; nella seconda, il colloquio fra i due ha uno spazio molto maggiore, con Elena impegnata a supplicare invano e Rinieri a rinfacciarle l’offesa e a godere senza pietà del proprio trionfo, usando gli stessi toni ironici e allusivi («se cotanto ora più che per lo passato del tuo onor ti cale e ètti grave il costà su ignuda dimorare, porgi cotesti prieghi a colui nelle cui braccia non t’increbbe, quella notte che tu stessa ricordi, ignuda stare […]. Come nol chiami tu che ti venga a aiutare?» ecc.).
Naturalmente la simmetria non è rigida: Boccaccio imposta una struttura ben congegnata, ma poi si abbandona al gusto dei dettagli concreti, delle sfumature che caratterizzano ogni singolo passaggio della vicenda – e in questo caso la scelta risulta particolarmente felice perché è necessario spiegare il violento contrasto tra i ritratti di Rinieri ed Elena, tutti in positivo, e i loro comportamenti, improntati a stoltezza e crudeltà.
L’amore che acceca
Ecco dunque in che modo Pampinea si attarda, nei momenti di snodo della vicenda, a chiarire in che modo personaggi presentati come nobili e saggi possano diventare protagonisti di due beffe tanto feroci.
Il primo intervento esplicativo della narratrice riguarda la cecità di Rinieri, che l’amore priva della consueta capacità di giudizio: «Ma come spesso avviene coloro ne’ quali è più l’avvedimento delle cose profonde più tosto da amore essere incapestrati, avvenne a questo Rinieri». Lo stesso effetto di accecamento provoca l’amore nella vedova, all’inizio della seconda parte: «Amor mi sprona per sì fatta maniera, che niuna cosa è la quale io non facessi». Nel momento in cui viene lasciata dall’amante, la donna incomincia a comportarsi in modo irrazionale e autodistruttivo, seguendo lo «sciocco» suggerimento della serva di chiedere aiuto allo scolare, «senza pensare che se lo scolare saputa avesse nigromantia per sé adoperata l’avrebbe» e «non ricordandosi ella che lui quasi alla morte condotto avesse».
In entrambi i casi, insomma, l’amore ha come effetto quello di istupidire, facendo sì che prima Rinieri e poi Elena cadano nelle rispettive trappole. Non a caso, quando lo scolare capisce di essere stato beffato e muta l’amore in odio, subito riprende a comportarsi «sì come savio», giocando d’astuzia per nascondere il suo nuovo sentimento e attendere l’occasione di vendicarsi, mentre la donna perde ogni saggezza («più innamorata che savia», «stolta che tu se’»).
Si giustifica alla luce di questa osservazione quello che a me pare il principale difetto (sul piano del ritmo narrativo) di questa novella, e cioè la lunga digressione dello studente sull’amore, gonfia di misoginia e di allusioni sessuali, svolte in un registro decisamente volgare:
Voi [donne] v’andate innamorando e disiderate l’amor de’ giovani, per ciò che alquanto con le carni più vive e con le barbe più nere gli vedete e sopra sé andare e carolare e giostrare […]. Certo io confesso che essi con maggior forza scuotano i pilliccioni, ma gli attempati, sì come esperti, sanno meglio i luoghi dove stanno le pulci […]. Voi non v’accorgete, animali senza intelletto, quanto di male sotto quella poca di bella apparenza stea nascoso. Non sono i giovani d’una contenti, ma quante ne veggono tante ne disiderano, di tante par loro esser degni; per che esser non può stabile il loro amore, e tu ora ne puoi per pruova esser verissima testimonia. […] Tu adunque, che male eleggesti, sieti di colui a cui tu ti desti, e me, il quale schernisti, lascia stare a altrui, ché io ho trovata donna da molto più che tu non se’, che meglio m’ha conosciuto che tu non facesti.
L’affollarsi dei luoghi comuni non deve nascondere il valore innanzitutto psicologico di questo lungo e arraffazzonato discorso: lo scolare esprime senza accorgersene la sua invidia per la maggiore prestanza del giovane amante della vedova, e offre così al lettore attento la reale motivazione di una vendetta che va ben oltre il pareggiare i conti (e anche in questo campo la misoginia offre a Rinieri una giustificazione teorica:
se io vendicar mi volessi, riguardando a che partito tu ponesti l’anima mia, la tua vita non mi basterebbe togliendolati, né cento altre alla tua simiglianti, per ciò che io ucciderei una vile e cattiva e rea feminetta […] dove per te non rimase di far morire un valente uomo, come tu poco avanti mi chiamasti, la cui vita ancora potrà più in un dì essere utile al mondo che centomilia tue pari non potranno mentre il mondo durar dee.
Il narcisismo dell’intelligenza
Il secondo intervento esplicativo di Pampinea è dedicato a giustificare l’atteggiamento della vedova nella prima parte: perché infatti una donna che avrebbe tutti i motivi per ignorare il corteggiamento dello scolare si impegna a beffare l’infelice spasimante? Anche in questo caso, la spiegazione è sottile e complessa:
La giovane donna […], si guardava dintorno e prestamente conosceva chi con diletto la riguardava […] pensandosi che quanti più n’adescasse e prendesse col suo piacere, tanto di maggior pregio fosse la sua bellezza e massimamente a colui al quale ella insieme col suo amore l’aveva data.
Insomma, la vedova si compiace («seco stessa vanamente gloriandosi») di sedurre perché ritiene di valorizzare in questo modo la sua bellezza e di apparire quindi tanto più desiderabile al proprio amante.
Lo sguardo di costui ha per la vedova un valore fondamentale ed è uno dei motori segreti dell’azione: è infatti per rassicurare l’amante, e non per gratuita crudeltà, che la donna organizza la beffa ai danni dello scolare; e lo confermano le parole che gli rivolge mentre osservano il povero Rinieri che trema di freddo nel cortile: «credi tu che io, se quel ben gli volessi che tu temi, sofferissi che egli stesse là giù a agghiacciare?»; e subito dopo: «faratti il freddo che io gli fo patire uscir del petto quello che per li miei motti vi t’entrò l’altrieri?» Non manca nella vedova il compiacimento un po’ narcisistico per il proprio potere di seduzione («parti che io sappia far gli uomini carolare senza suono di trombe o di cornamusa?»), ma resta in secondo piano, perché l’esaltazione di sé è sempre condizionata dallo sguardo dell’uomo amato.
Nella seconda parte, al narcisismo della donna, legato al potere seduttivo della bellezza, si contrappone vittoriosamente il narcisismo dell’intelligenza di Rinieri, sintetizzato nella frase: «le tue lusinghe non m’adombreranno ora gli occhi dello ’ntelletto». Rinieri, infatti, grazie alla lucidità che gli deriva dal non essere più animato dall’amore, ma dall’odio, è in grado da un lato di approfittare delle occasioni che la fortuna gli offre, dall’altro di governare i propri sentimenti e i propri istinti. La sua trappola (una delle tante, dice lui, in cui prima o poi la vedova sarebbe incappata) può scattare grazie a una serie di combinazioni fortuite (la donna viene abbandonata; la serva propone alla padrona una «nigromanica operazione»; la vedova ha una proprietà con tutte le caratteristiche ideali per il piano di Rinieri) che lo scolare sa cogliere al volo. E quando si vede passare accanto la donna nuda e prova un misto di compassione e desiderio, l’uomo resiste («la compassione e il carnale appetito cacciati, stette nel suo proponimento fermo»), lasciandosi guidare appunto dall’intelletto.
Si conferma insomma che l’amore rende ciechi, mentre l’odio è all’origine di una perfetta lucidità mentale. Anche la vedova, alla fine della sua ordalia, manifesterà il suo rinsavimento inventandosi una favola per spiegare la propria scottatura e la gamba rotta della sua serva, cioè il riacquistato controllo su di sé (e anche la capacità di ingannare gli altri con l’abile uso della parola, che è un altro dei temi della novella, oggetto di un’altra lunga digressione dello scolare, narrativamente non necessaria, ma significativa sul piano tematico e ideologico, come ho cercato di mostrare nel mio precedente intervento).
Un mondo senza compassione
È significativo che siano messi sullo stesso piano, e contemporaneamente repressi, un impulso etico (la pietà, da cui Rinieri sarà infastidito, ma invano, anche in seguito) e uno ferino (il pensiero di usare violenza alla donna indifesa). Osserviamoli entrambi.
Compassione è, fin dall’introduzione di Pampinea, la parola-chiave della novella, ripetuta ben sei volte e ripresa nell’introduzione alla successiva. Tutti gli altri temi (l’antitesi savio/stolto, il carattere distruttivo dell’amore, l’uso e l’abuso della parola) sono funzionali alla riflessione su questo concetto, quello enunciato nella prima frase dell’opera («Umana cosa è avere compassione degli afflitti»): Boccaccio mostra in realtà, in questa come in tutte le novelle del Decameron, un mondo da cui ogni sentimento di pietà, di solidarietà, di fratellanza umana, è assente.
Il carattere apocalittico delle prime pagine del Decameron, con la descrizione di Firenze e del contado in preda alla peste, e l’annientamento di ogni vincolo sociale, nelle novelle non viene smentito, ma confermato, con pochissime e marginali eccezioni (anche nella novella che stiamo commentando: l’atteggiamento del lavoratore che trova casualmente la donna in fin di vita e l’accoglie in casa sua è l’unico moralmente rispettabile). Della peste, a partire dal momento in cui i dieci novellatori giungono in campagna, non si parla più, nemmeno quando, alla fine della Decima giornata, i giovani tornano a Firenze insieme alla servitù, ma in effetti non ce n’è bisogno, perché tutto il mondo descritto nel Decameron ha lo stesso carattere infernale.
Contro la visione edulcorata di un Boccaccio divertente, intrattenitore e cantore dei mercanti e della loro mentalità, occorre invece riconoscere il carattere problematico, aperto e spesso conturbante delle vicende narrate e della visione del mondo ad esse sottesa. Boccaccio anticipa di fatto l’amara antropologia enunciata centocinquant’anni più tardi da Machiavelli nel cap. XVII del Principe: «delli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno;».
E non stupisce che il Segretario fiorentino riprenda (da trattatista e non da narratore) gli stessi temi al centro del Decameron: la fortuna e la virtù, la giustizia e la forza, l’avarizia e la liberalità – e perfino il ricorso a metafore animali (la «golpe» e il «lione»), che in questa novella, tra le più tetre e angoscianti del Decameron, abbondano in modo particolare: dalla cicogna all’aquila, dalla colomba al leone (a cui sono paragonati sia lo scolare, sia la serva della vedova), alle mosche e ai tafani e ai porci, fino al serpente e alle «salvatiche fiere» a cui Rinieri paragona Elena. Ma sulla ferinità dei comportamenti umani converrà ritornare in un prossimo intervento.
(continua)