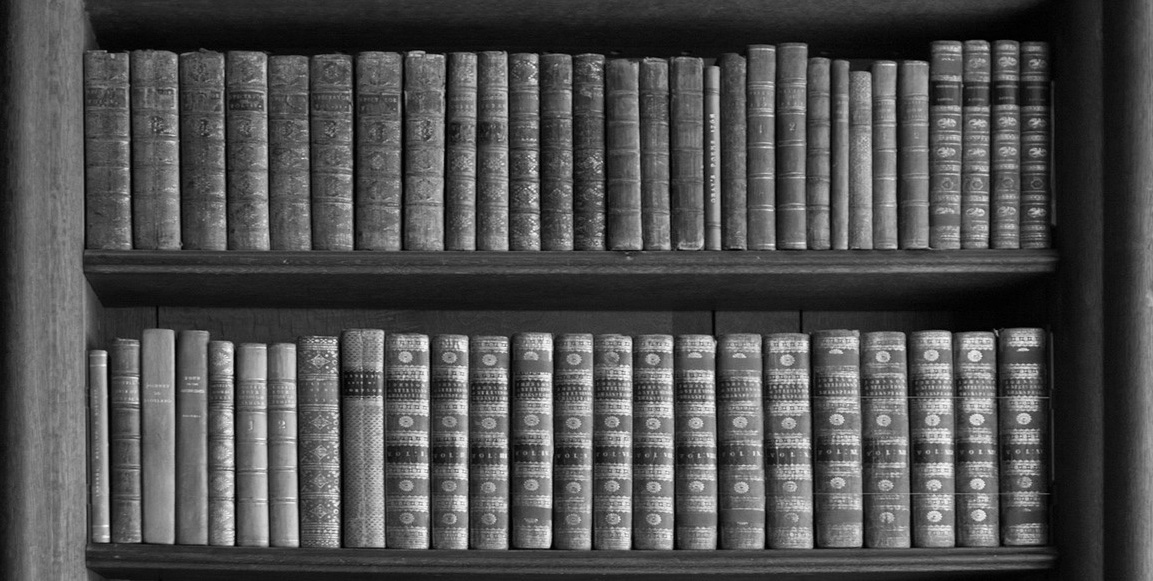
Nel Seicento scrivevano male
I promessi sposi, come è noto, non incominciano con la celebre descrizione del Lago di Como, cioè con le prime righe del capitolo 1, ma con l’Introduzione: «L’Historia si può ueramente deffinire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia». Il manoscritto da cui Manzoni finge di copiare la prima pagina del suo romanzo si apre con una serie di considerazioni retoriche, che Manzoni puntualmente contraddice nel suo libro. Per lui infatti scrivere di storia non significa richiamare in vita gli anni trascorsi, passarli in rassegna e schierarli di nuovo in battaglia, qualunque cosa si intenda con queste metafore, ma analizzare il passato, cioè mostrare i meccanismi politici, economici, sociali, culturali, che caratterizzano una certa epoca; non «operationi diaboliche», quindi, ci mostrerà l’autore moderno, ma errori e debolezze umane, imputabili soprattutto a coloro che, secondo il servile anonimo del XVII secolo, «con occhij d’Argo e braccj di Briareo, si vanno trafficando per li pubblici emolumenti».
Ma questo incipit non serve solo a chiarire uno dei meccanismi narrativi portanti del romanzo (la figura di un narratore inattendibile, accanto a quello che fa da portavoce dell’autore) e a enunciare uno dei temi di fondo dell’opera (la riflessione sulla storia e su come raccontarla). Chi legge, infatti, resta colpito innanzitutto dalla scrittura dell’anonimo – la sua lingua e il suo stile – e su questo , una volta conclusa la falsa citazione, si concentra l’io narrante: quasi tutta la seconda parte dell’introduzione è dedicata a spiegare perché Manzoni si sia impegnato a «rifar l’opera altrui», sostituendo alla «intollerabile… dicitura» dell’anonimo quella che scopriremo a partire dal capitolo 1. Ma quello che vorrei chiarire è che l’anonimo non è un caso isolato: tutto il romanzo conferma come si tratti viceversa di un caso tipico – la letteratura del XVII secolo (questo sta dicendo in realtà Manzoni) adottava uno stile ampolloso, ridicolmente retorico, affollando metafore lambiccate, concetti campati per aria, riferimenti mitologici gratuiti; a questi difetti Manzoni contrappone la sua ricerca di uno stile moderno, cioè piano, concreto, razionale, e alla difficoltà di una lingua che si compiace della propria astratta dottrina l’efficacia di una lingua viva, il fiorentino parlato dalle persone colte, capace di diventare la lingua della futura Italia unita e di rispondere a tutte le esigenze della comunicazione, letteraria e non.
Sul piano dell’argomentazione, diciamo pure della polemica, la trovata manzoniana ha un’indubbia efficacia. Al prezzo, tuttavia, di un’evidente forzatura: Manzoni non poteva ignorare che la prosa italiana del Seicento offre ben altri modelli, e che, al netto dell’esagerazione ironica, la scrittura da lui attribuita all’anonimo non è affatto rappresentativa. Ecco due brani tratti da opere contemporanee a Renzo e Lucia:
1. Bertoldo incominciò a caminare innanzi agli altri di buon passo, sì che era discosto da loro un buon tratto di mano. Quando coloro che l’accompagnavano viddero le guardie all’ordine per far il fatto ed essendo omai Bertoldo arrivato da quelle, cominciarono da discosto a gridare che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio, che così aveva ordinato la Regina. Le guardie, vedendo Bertoldo innanzi agli altri, pensando che esso fusse il capo di tutti, lo lasciarono passare senza fargli offesa alcuna, e quando giunsero i servi gli cominciarono a tempestare di maniera con quei bastoni che gli ruppero le braccia e la testa…
2. L’intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive, o vero extensive: […] extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l’intender umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto all’infinità è come un zero; ma pigliando l’intendere intensive, in quanto cotal termine importa intensivamente, cioè perfettamente, alcuna proposizione, dico che l’intelletto umano ne intende alcune cosí perfettamente, e ne ha cosí assoluta certezza, quanto se n’abbia l’istessa natura; e tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di piú, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dall’intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa esser sicurezza maggiore.
Il primo è tratto da Le sottilissime astuzie di Bertoldo di Giulio Cesare Croce, opera di uno scrittore semi-colto, destinata a un pubblico popolare e accolta effettivamente con molto favore. Il secondo è tratto dal Dialogo sui massimi sistemi di Galileo Galilei, opera di argomento scientifico e filosofico, destinata anch’essa a un pubblico più vasto di quello degli specialisti, come rivela la scelta del genere (il dialogo) e della lingua (l’italiano anziché il latino).
Si tratta di due esempi che ci dicono come nel XVII secolo esistesse e fosse praticata in Italia una forma di scrittura concreta, lineare, aliena dai concettismi barocchi e dal gioco intellettualistico delle metafore e delle citazioni classicheggianti dell’anonimo. Manzoni tuttavia, nel romanzo, non fa mai cenno a questo aspetto del Seicento, e tutte le citazioni da testi dell’epoca (che siano le gride o i documenti storici sulla peste) presentano tutti o in parte i difetti della pagina incipitaria. Perfino quando allude senza citare (per esempio parlando della biblioteca di don Ferrante, o delle opere di Federigo Borromeo) Manzoni lascia intendere che tutto il secolo sia riconducibile al grottesco falsetto dell’anonimo.
Analogo discorso si può fare se dall’Italia allarghiamo lo sguardo all’Europa e in particolare alla Spagna, che governava per l’appunto il Ducato di Milano. La Spagna viveva nella prima metà del Seicento il suo Siglo de oro, con autori come Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina (l’autore del primo Don Giovanni) e Baltasar Gracián. Anche su questo Manzoni tace, e riduce la Spagna del Seicento a cattivo governo, sussiego, punto d’onore e insomma a tutte le caratteristiche negative che emergono nella scena del banchetto in casa di don Rodrigo e sono confermate su un piano di verità storica documentata dai comportamenti del cancelliere Ferrer.
Un secolo senz’arte e senza musica
In generale, il Seicento dei Promessi sposi sembra essere un’epoca di decadenza culturale senza appello. Noi sappiamo benissimo che non è così, e lo sapeva benissimo anche Manzoni: in campo musicale e artistico, l’Italia produce nella prima metà del secolo una quantità impressionante di capolavori, di cui nel romanzo non v’è alcuna traccia.
La musica, nei Promessi sposi, è sempre legata a situazioni negative, dalla “canzonaccia” che intonano i due bravi dopo lo scellerato incontro con don Abbondio ai canti ancora più turpi dei diabolici monatti a cui Renzo è costretto ad accompagnarsi quando torna a Milano nel pieno della peste. Manzoni non poteva ignorare, tuttavia, che proprio nel primo trentennio del XVII secolo si colloca l’attività di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, Claudio Monteverdi, e non poteva ignorare che proprio Mantova, la città contesa nella guerra a cui il romanzo dedica molte pagine, era uno dei centri dove si affermava il genere del melodramma, destinato a immensa fortuna in tutta Europa e parte fondamentale della cultura milanese ai tempi di Manzoni (il Teatro alla Scala viene inaugurato nel 1776, pochi anni prima dalla nascita dello scrittore).
Manzoni non dedica nemmeno una riga alle arti figurative, se non per ironizzare sulle immagini popolari del purgatorio (siamo ancora nel I capitolo, dove è descritto il tabernacolo al bivio per cui passa don Abbondio, “sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert’altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là”); o per criticare la funzione retorica che le classi dominanti attribuiscono ai ritratti (si vedano quelli degli antenati di don Rodrigo, nel suo palazzotto, e quelli dei dodici Cesari, nello studio dell’Azzecca-garbugli). Anche in questo caso, non è verosimile che Manzoni ignorasse come non solo a Roma, con Bernini e Borromini, ma anche a Milano, con i cosiddetti “caravaggeschi” come il Cerano, Daniele Crespi e altri, nei primi decenni del Seicento venivano prodotte grandi opere d’arte.
Estetica e ideologia
Come si spiegano questi tanti silenzi da parte dell’autore? Come si spiega, se vogliamo dirla in modo più drastico, la falsificazione a cui Manzoni sottopone il “suo” Seicento?
Il secolo in cui è ambientata la vicenda di Renzo e Lucia è molto più di uno sfondo, di un “contesto storico” del romanzo: per certi versi anzi è possibile affermare che il Seicento è il vero protagonista dei Promessi sposi, in quanto gli avvenimenti storici e più in generale la mentalità del periodo condizionano il destino di tutti i personaggi. Nel ricostruire quest’epoca, tuttavia, Manzoni compie una serie di scelte radicali e non esplicitate: anzi, si presenta con l’atteggiamento dello storico, capace di offrire un’immagine obiettiva, fondata su documenti e dati di fatto inoppugnabili, laddove in realtà offre ai suoi “venticinque lettori” una visione del XVII secolo parziale, soggettiva e tratti perfino umorale.
È possibile che nello scrittore lombardo agisca una forma di autocensura: Galilei era un autore all’indice, e quindi assai scomodo, per un cattolico, sia pure imbevuto di illuminismo; la Chiesa, nell’Ottocento, si ostinava a considerare il teatro musicale una forma di intrattenimento moralmente condannabile. È possibile, ripeto, che Manzoni non abbia osato citare alcune delle glorie culturali dell’Italia seicentesca, come l’invenzione del metodo scientifico e del melodramma, per queste ragioni – ma è poco probabile, in uno scrittore che coraggiosamente dedica tante pagine alla storia di una monacazione forzata e che fa di un prete pavido e indegno del suo ruolo uno dei protagonisti della vicenda che narra.
Le ragioni dei silenzi di Manzoni vanno piuttosto cercate nel progetto complessivo da cui nascono I promessi sposi. Manzoni aveva cioè bisogno di mostrare un’epoca di decadenza e di corruzione (morale, economica, politica, ma anche culturale e artistica) per meglio mettere in risalto i temi di fondo del romanzo: la riflessione sulla giustizia, sul potere, sul valore sociale dei princìpi evangelici e così via. Manzoni sa che l’estetica ha sempre un valore ideologico: non poteva mostrare un secolo artisticamente e culturalmente ricco, perché ciò avrebbe introdotto nel romanzo un elemento di debolezza irrimediabile. Il Seicento doveva essere una “età sudicia e sfarzosa”, e quindi l’autore ritaglia il quadro a seconda delle sue esigenze, escludendone non solo gli imbarazzanti Galilei e Monteverdi, ma anche i cattolicissimi Bernini, Góngora e Calderón.
Perché vale la pena di soffermarsi su questi aspetti dei Promessi sposi? Simili operazioni di ritaglio e di messa a fuoco prospettica sono alla base di qualunque progetto artistico. Naturalmente, dato il peso che I promessi sposi hanno avuto in Italia negli ultimi due secoli, in ambito scolastico e non solo, Manzoni sembra avere una grave responsabilità nella visione distorta del Seicento che, senza sua colpa in realtà, il romanzo ha contribuito a diffondere e a consolidare, a dispetto delle clamorose correzioni di studiosi come Croce, Getto, Raimondi e altri. Tenerlo presente è utile, sia nel momento in cui si parla del Seicento, sia nel momento in cui si parla dei Promessi sposi. La tradizione si crea anche in questo modo, attraverso schematizzazioni e falsificazioni, correzioni di rotta e progressivi arricchimenti del quadro.
(continua)

